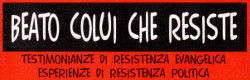
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1995
Dalle relazioni di ieri sono emerse-riemerse le profonde radici della nostra vita, quelle che ci hanno consentito e ci consentono di attingere all’Humus esistenziale della condizione umana.
È giusto ricordare da dove veniamo per vedere meglio dove andare.
Cosa ci stava e ci sta a cuore?
– la fedeltà alla vita e alla storia; ciò ha significato la spogliazione dei ruoli e il ripercorrere la via della compagnia;
– la ricerca di Dio nutrita di ascolto della Parola e di sintonia con le vicende ‘sotto il sole’;
– il vivere con gratuità imparando cosa significhi normalità della vita;
– l’Evangelo come evento improvviso, manifestazione di grazia non prevedibile né programmabile;
– l’Evangelo come annuncio-testimonianza senza preoccupazioni di riscontri, di ritorni, di onde gratificanti.
Ci stava e ci sta a cuore poter vivere con lo stile di chi si sforza di stare accanto senza essere ingombrante: l’offerta di una testimonianza soft, sottile, leggera.
Beato chi resiste oggi
L’importante è percepire che c’è in me, nel compagno di lavoro, nei vicini di casa un inespresso, qualcosa di solo intuito, gravido che viene alla luce poco a poco.
1) Abbiamo mantenuta alta l’esigenza di capire, il gusto del pensare, la gioia della razionalità che ci consente di leggere eventi politici, trasformazioni culturali, modificazioni personali, speranze ecclesiali.
Adopero il plurale perché mi pare essere una comune tensione. Ci siamo sforzati e ci sforziamo di pensare il vissuto che è sempre più grande di noi.
C’è il gusto di restare svegli, attenti…
La resistenza si fa fierezza di pensare, libertà di pensare.
2) L’inespresso che abita in noi si è canalizzato nella ricerca di una fede povera, essenziale, nuda.
Fede come fedeltà al Dio fedele , al Dio dei padri, vivente dentro la storia; e consegna, affidamento a Lui, roccia sicura.
Una fede che si alimenta di mezzi poveri e che stimola ad atteggiamenti poveri: l’ascolto, il silenzio, tempi di attesa e di invocazione, spazio di canto, apertura al mistero… il riconoscere di non sapere e di non possedere Dio…
Non è venuta meno la speranza di dire Dio e di nominarlo non invano.
La ricerca si è spostata sul come dirlo:
dirlo senza dimostrarlo
senza possederlo
indicando
vivendo una reale compagnia e gratuità.
È questa ricerca che sta ridisegnando la stessa parabola del lavoro e del lavorare: l’intuizione di vivere con il lavoro delle proprie mani oltre che scelta di condivisione si fa condizione per consentire libertà al testimone.
Ecco perché ci sta a cuore, come dice il salmo, abitare la terra e vivere di fede senza cortocircuiti, senza fretta di dipingere nuovi scenari né di pastorale, né di cultura, né di politica.
Legato a questo, l’essere minoranza: a dare dignità e consistenza alla vita non è né il consenso né l’essere maggioranza, ma la serietà con cui si sa stare a questo mondo.
La resistenza si fa ostinazione nel continuare a cercare… lasciarsi cercare.
3) Nel mio linguaggio tornano spesso parole come ‘fierezza’ e ‘intuizione’: inseguiamo Qualcuno, qualcosa: è l’Evangelo come buona notizia ai poveri. E ci sta a cuore che l’ Evangelo rimanga Evangelo.
Mi ha sempre disturbato l’uso del termine ‘evangelo’: vangelo della coppia, della famiglia, della sessualità del lavoro, della pace, della vita, della carità…
È una maniera per organizzare noi l’evangelo e così rischiamo di ridurlo a nostro uso e consumo.
Vorrei poter restare un servo dell’evangelo: un servo inutile. La condizione operaia, di lavoratore dipendente libera l’evangelo e me lo fa percepire come semente da gettare, non grano da raccogliere.
Con i Padri del deserto ripetiamo a noi stessi e alla comunità: quel che abbiamo di più caro nel cristianesimo é Gesù Cristo.
E con tutti cerchiamo di rispondere alla domanda: quale Gesù Cristo?
La resistenza si fa riproposizione di questa centralità.
“Bisogna avere oscurità dentro di sé per partorire una stella danzante”.
Per questo a volte ci facciamo poeti, a volte mistici, a volte politici: così è il vivere, l’esperimentare la vita.
Non l’Aut-aut ma l’ Et-et raccoglie il senso dei nostri giorni.
Il cammino continui…
a) Il gusto di pensare: ha una radice nel non essere preoccupati di niente; questo non come forma di apatia e di indifferenza ma come percezione di un pellegrinare in compagnia. Pensare è legato alla capacità di essere liberi e di liberare.
b) L’essenziale: andare ai nodi del vivere e del morire, del lavorare e del riposare, del parlare e del tacere; l’essenziale abita in profondità e non emerge se non alla scuola della paziente ricerca, del silenzio: chi oggi educa più all’ascolto?
Sul versante ecclesiale liberarci da presunte centralità per riscoprire Colui che è Alfa e Omega .
c) La comunicazione: favorire il racconto dei vissuti, raccontare e ascoltare il racconto di altri; anche quest’arte del raccontare rischia di perdersi!
Certa passività ecclesiale può essere vinta attraverso il ridare la parola perché ognuno manifesti l’opera che Dio va compiendo in lui.
E i valori del pluralismo, della tolleranza, del gusto del collettivo e della partecipazione democratica, della libertà e della giustizia rimangano il tesoro a noi giunto attraverso la “resistenza” di tanti uomini e donne la cui memoria non va tradita.
