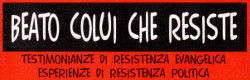
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1995
Interventi
La tematica della “resistenza” può trarre in inganno. Essa fa pensare ad un accerchiamento dentro al quale un gruppo non si dà per vinto. La parola “resistere” ha la stessa radice di “esistere”, che significa “vivere, star lì, essere presente”. Un’esistenza che ha bisogno di energie maggiori per sostenere situazioni nuove e di una grande dose di pazienza per poter sedimentare. Resistere allora non ha l’effetto di un temporale, ma di una pioggia leggera e costante che penetra nel terreno.
Da maestro del legno ho capito che gli alberi meno compatti sono quelli che crescono in fretta, ma i primi a schiantarsi a colpi di vento, come i pioppi attorno casa che perdono rami ad ogni temporale. Quello che cresce lentamente ha una struttura più dura: quando affondi lo scalpello non si spacca seguendo la linea della venatura. In questi ultimi anni si ripete spesso che ci troviamo nella notte, nell’inverno e si vive nell’attesa che tutto passi presto, quasi che questi fossero qualcosa di negativo. Ma ogni stagione ha una sua logica e una sua importanza.
Il Kohelet afferma:
Ogni cosa ha il suo momento
e ogni faccenda ha il suo tempo
sotto il cielo:
tempo di nascere
e tempo di morire.
Tempo di piantare
e tempo di sradicare
ciò che si è piantato…
Tempo di lamentarsi
e tempo di danzare;
tempo di lanciare le pietre
e tempo di raccoglierle…
Ho meditato sull’occupazione che Dio ha dato
ai figli dell’uomo perché vi si impegnino.
Egli ha fatto ogni cosa proporzionata al suo tempo (3,1-12).
La parabola della vita di noi PO si può riassumere in alcuni momenti: momenti forti sostenuti dall’età e dalle situazioni propizie, momenti di grandi progetti con la conseguente realizzazione, momenti in cui si difende quello che si è conquistato e momenti delle cose più ordinarie e minute.
I contadini durante l’inverno sistemavano gli attrezzi e facevano delle piccole riparazioni per prepararsi alla stagione che stava per sopraggiungere. Quando si hanno in mente dei grandi ideali spesso ci si dimentica dell’ordinario, del frammento. La logica degli anni ottanta a livello pubblico era per i finanziamenti straordinari: opere faraoniche, superstrade, grandi strutture, alta velocità… tutto a discapito dei piccoli servizi con i quali abbiamo a che fare ogni giorno.
Il lavoro artigiano mi ha fatto imparare che oltre ai grossi progetti da realizzare c’è il cassetto e la finestra, la cerniera e la sedia rotta. Queste piccole riparazioni danno molte soddisfazioni anche perché vedi la gioia delle persone che dopo settimane e settimane possono richiudere la porta e il cassetto e sedersi su una sedia riparata. Questo è il tempo delle cose umili, ma preziose, è il tempo di raccogliere i cocci sparsi, considerando tutto quello che ci passa accanto come una piccola perla. È anche il tempo della custodia e difesa delle perle acquisite.
È il momento della consapevolezza e dell’attenzione e della veglia. Vegliare nella notte, essere attenti ad ogni movimento e ad ogni persona. Tutto ha valore: l’incontro in metropolitana, il dar tempo a chi ti cerca senza avere fretta e senza guardare l’orologio, staccando il telefono quando si è con qualcuno. La notte è silenzio, che oggi assume un grande valore, data l’inflazione della parola, che ha perso tutto il suo significato (si è creato un parlare tra sordi).
Silenzio è sentire le ragioni degli altri, senza la pretesa di avere delle risposte pronte.Un detto degli indiani del Nord America dice: “Quando uno ti parla, lascialo parlare, non interromperlo. Quando ha finito, aspetta a rispondere facendo così capire che stai pensando a quello che ha detto. Intervieni dopo aver osservato un momento di silenzio”.
Nella notte si sentono i rumori: resistere è anche sentire le voci, ascoltare, stupirsi di quello che capita attorno a noi: stupore come meraviglia, per non assuefarsi. Tutto questo lo vedo in un atteggiamento di nonviolenza, che mi fa capire la relatività di ogni cosa dove i punti di riferimento sono molti. Esistono più “centri” e più “modi” di vedere È la verità di Gandhi: in ogni essere c’e una parte di verità. La contrapposizione e il muro contro muro non producono frutti duraturi. E quando cadono i muri è facile rifugiarsi nelle trincee e se non si cambia metodo si rimane arroccati sulle proprie posizioni, che a lungo andare danno origine all’apatia e al disinteresse.
Durante la prima guerra mondiale i militari italiani e austriaci nelle trincee dialogavano tra di loro e s’accorgevano che i problemi erano gli stessi. È per questo che i capi cambiavano spesso turni perché non potessero fare amicizia tra di loro. Il dialogo rompe le trincee e le rende inutili.
Resistere significa creare degli spazi di libertà, delle zone liberate. Essere PO per noi ha voluto dire libertà economica dalla struttura-chiesa, ottenendo come frutto la gratuità del messaggio diventato a sua volta liberante, e l’appropriazione della propria vita, non vendibile a nessuno. Il nostro esistere è un continuo liberare degli spazi dove altri hanno seminato rovi. Ho presente l’immagine del terreno attorno casa: qualche anno fa era infestato da rovi, sterpi, deposito di rottami e immondizia. Ora c’è un giardino. Sembra l’immagine di un film ambientato in una zona degradata: si entra da una porta malmessa che si apre su un giardino stupendo. È il nostro essere liberi in mezzo al degrado, dove gli spazi quotidiani, sociali, politici e religiosi esprimono ciò che è avvenuto in noi: la liberazione. Essa è la nostra esistenza, nella speranza che “gutta cavat lapidem”.
Si è detto che i PO sono al capolinea; vorrei usare un’immagine che vedo quotidianamente: davanti casa c’è un capolinea: arriva il 246 dal centro, ma dallo stesso capolinea parte lo 023, carico di immigrati, di contadini e operai che vanno verso la estrema periferia. Il prete operaio arriva al capolinea e riparte su un altro autobus, in compagnia di altri come lui, andando verso il margine, la periferia, dove altri orizzonti si aprono: arrivare e ripartire.
