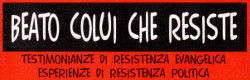
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1995
Seconda relazione
Premesse
b. Partendo dalla nostra condizione di “dipendenza”, dall’“essere in condizione operaia” ci portiamo il patrimonio delle analisi e delle esperienze dei lavoratori, il loro senso forte della giustizia e dei loro rapporti e solidarietà con le altre situazioni di sfruttamento, di ricerca di dignità, che, nel vissuto, è resa difficile dalle condizioni economiche e dalle schiavitù legate al degrado morale della società civile di oggi e a quello fisico personale. E queste ci avvicinano più all’esperienza dei crocifissi che a quella dei vincenti e della loro visione “spirituale”. Anche la riflessione ne risente e fa cogliere maggiormente la paradossalità della proposta evangelica e la sua forza di liberazione. Essa nasce dalle prospettive intraviste come PO e rende meno urgenti le problematiche dell’essere o non essere nell’organizzazione Chiesa, del ruolo o non ruolo in essa. Tuttavia è ad essa che intendiamo proporre e offrire queste nostre “grida”, insieme a tutti coloro che cercano dentro e fuori spazi di libertà, dove incontrare lo Spirito senza troppe mediazioni o vincoli, per diventare adulti nella fede, per aprire spazi al “santo” riducendo quelli del “sacro”.
1. INTUIZIONI ORIGINARIE
Incarnazione / La Chiesa in classe operaia e la classe operaia nella Chiesa / Esperienza religiosa
Ci sono, nella nostra storia, momenti diversi e intuizioni più centrali e altre più “periferiche”, ma tutte parte integrante del nostro vissuto e con conseguenze forti nell’impostazione e nella ricerca di prospettive per il futuro:
a. – centrale è la prospettiva dell’incarnazione, dell’essere “con”, della scelta della condivisione per essere con tutti umanità in cammino, senza privilegi e senza primogeniture, nella prospettiva trinitaria della comunione, dell’unità delle diversità, della solidarietà, che ha come prospettiva anche la croce di Cristo, senza drammi, ma con forte senso di compartecipazione e di condivisione, di una fede laica, di una speranza contro ogni speranza nella piena libertà della ricerca di Dio nel vissuto,
b. – accanto al desiderio di portare la Chiesa nella classe operaia avvertita come “lontana”, non influente nella mentalità ecclesiale, insieme alla necessità della condivisione della vita operaia serva così da portare nella Chiesa la presenza della condizione di dipendenza e far riconoscere le sensibilità e i valori di questo mondo, quindi
– accanto alla partecipazione al movimento operaio come realtà significativa e storicamente portatrice di sensibilità e proposte per un’esperienza evangelicamente coerente e significativa, cioè
– accanto all’esperienza religiosa come ricerca di libertà della persona, fuori dagli schemi prefissati, vincolanti e nell’essenzialità della libertà per il credente e per la sua esperienza di Dio, verso il
– superamento dell’ecclesiastico per riaffermare l’ecclesiale e la possibilità della vita di fede nella profanità, “fuori della città” (Gv.19), con i rischi e le prospettive dell’essere adulti di fronte a Dio e carichi delle nostre responsabilità umane, inoltre
– attraverso la povertà nella Chiesa non solo come “scelta dei poveri”, ma come dimensione essenziale del suo essere testimone di Cristo povero e tramite non unica di un messaggio non suo;
c. – inoltre ci è apparsa la necessità della presenza e del passaggio dal sacerdozio professionale al sacerdozio di testimonianza (misurandoci con la polvere che sollevano i testimoni),
– nel superamento del sacerdozio come “mediazione” non evangelica, come pura diversità sociologica, da privilegiati, spesso confusa con l’alterità del trascendente e l’esperienza indicibile dell’incontro con Cristo e con il Padre, libera e liberante, dove
– è richiesto di rapportarsi con la testimonianza cristiana della gratuità, fuori dal temporalismo del Concordato, dell’8 per mille, delle sicurezze economiche e dei privilegi politici rassicuranti, in una testimonianza fiera del “guadagnarsi la vita con le proprie mani” di Paolo (Atti 20,33),
– nel liberante superamento della testimonianza del prete o della fede come pura produzione sociale, per andare verso una distinzione tra fede e politica, che sentiamo come un grande servizio reso a tutti i nostri amici preti, la loro vita stressata e dilaniata tra continue supplenze, confusioni e sacralizzazioni inutili, in una perenne ansia di essere “maestri” per tutti e in tutte le cose, senza viverne effettivamente nessuna (famiglia-sessualità-lavoro…).
2. RESISTENZA EVANGELICA
Pluralismo / Forme di vita / Ricchezza delle diversità nella Chiesa
L’elencazione precedente, necessariamente sintetica (che allarghiamo dando alcuni spunti di riflessione), cela la nostra vita vissuta e un lungo cammino di liberazione e parla di intuizioni in parte originarie e in parte sviluppatesi nel tempo, che fanno il tessuto della storia dei singoli e del gruppo PO. Esse sono il risultato di scelte e insieme di casualità, di soggettività e ambienti umani o ecclesiastici diversi. Ci ritroviamo oggi come PO in parrocchia o in gruppi di animazione e di vita; PO singoli o in comunità di amici; PO sposati; PO in fabbrica, nell’artigianato, nel sindacato, nel sociale pubblico o privato.
Questo pluralismo, che va oltre le intuizioni originarie e va al di là delle “forme di vita” e di una vita che fa riferimento al concetto di “sacerdozio”, è oggi una grande ricchezza del movimento.
Infatti nessuna intuizione o forma di vita, pur legittima, può costituirsi in fondamento esclusivo o originare una qualsiasi esclusione, senza impoverirsi: tutti hanno bisogno di tutti in questa ricerca e nel volersi costruttori di futuro, un futuro originario e fondante. Le diversità diventano ricchezza nel cammino comunitario ed evangelico. La nostra storia e la nostra vita del resto si muovono dentro la ricerca di libertà, dove emergono le due libertà strettamente legate e reciprocamente condizionantesi (“non dò libertà se non sono libero, non sono libero se non dò libertà”, diceva Riccardo):
• libertà personale : l’indipendenza economica del PO, la sua presenza in forme politiche e sindacali nelle quali, più che nella Chiesa, valgono la discussione, le scelte, le diversificazioni, la coerenza più che l’obbedienza, da un lato porta il PO ad essere uno “qualsiasi”, sottoposto alle leggi economiche e di mercato, dall’altro aprono per lui il problema della sua libertà personale. E questo soprattutto in relazione al diventare adulti, non al riparo da condizioni date, ma nel “mare aperto” della condizione umana. Diventa perciò sterile l’opposizione tra preti nell’istituzione e preti “liberi”, perché l’essere adulti è un compito che riguarda tutti e porta fuori dell’ambito del “i genitori mangiano l’uva acerba e ai figli rimane la bocca amara”, verso il “nessuno dovrà più insegnare agli altri” di Geremia 31, 29);
• libertà comunitaria : nello stesso tempo ciò che si conquista di libertà per sé e di responsabilità, origina attivamente un compito, che è quello di dare-permettere-promuovere la libertà nella Chiesa e nella società che ci circonda. Qui come PO abbiamo verificato che mettere in campo la propria esperienza (anche nel settore politico, sindacale e sociale), significa cogliere immediatamente il peso negativo che le classi dirigenziali portano nel tessuto sociale, quando si professionalizzano e fanno dell’ampliamento e della salvaguardia rigida dei loro ruoli (anche i vescovi e i preti “moderni”, “bravi”) un qualcosa di privato, coperto dal pubblico.
Su questo punto il PO, pur minoritario, si rifiuta di essere marginale, come una specie di libero professionista e pone i problemi attualissimi, evidenziati dal suo “oblò”, del rapporto sacerdozio-laicato, dell’essere minorenni o adulti nella Chiesa. Sono problemi posti dal suo interno, al di là della sterile polemica mediazione-suo superamento che nascondono il problema nella sua immediatezza e urgenza:
- sappiamo bene che la coppia sacerdozio-laicato ha dei severi punti di riferimento: non più maestri (Geremia 31,31-33), non imitate il loro modo di agire (Matteo 23), non fatevi vedere dalla gente e non cercate ricompensa (Matteo 6), il buon pastore dà la vita (Giovanni 10, 1-19)…
- facciamo i conti non con il fatto che ci siano pastori cattivi, ma pastori che hanno esteso il loro ruolo (nel quale e del quale vivono) fino ad oscurare il collettivo e a renderlo insignificante e “consultivo”;
- constatiamo l’esistenza di una confusione tra legittimo automantenimento dei preti e testimonianza, diventata vendita di una merce, di un Dio “cosificato”, fatto talismano, idolo toccasana per tutti i mali. Siamo testimoni di un’altra confusione tra testimonianza e prestazione di servizi sociali (prete = assistente sociale = educatore sempre e comunque). Tutti elementi che portano all’identificazione-confusione tra fede = morale = servizi sociali. Per questo la testimonianza evangelica identificata con i servizi sociali, trasforma la fede in un problema soprattutto di etica e di politica, che da un lato emargina dalla politica le verità della fede come inutili, dall’altra porta l’attenzione del credente, più che verso l’agire senza mercede, all’esclusiva attenzione per gli ambiti cristiani (scuola cattolica, calcio cattolico, ospedale cattolico, partito cattolico…);
- incontriamo i nostri amici preti, svuotati di vita umana in proprio, diventati testimoni di una morale “per gli altri”, con il rischio di mettere pesi sulle spalle altrui, che essi non portano (contro cui si scaglia Cristo in Matteo 23, 4 ss.) vanificando la presenza a se stessi e agli altri. Inoltre la testimonianza, trasformata in professionalità stipendiata (vivere non per la religione, ma di religione) aumenta la pressione del prete sul collettivo, fino alla sua scomparsa, fino al fatto che i fedeli “popolo di Dio” diventano gente, massa (come avviene in politica, dove si passa da un corpo di elettori a telespettatori muti, a consumatori) cercando l’aggregazione a ogni costo e il riferimento a una totalità anonima, che vanifica le diversità e fa delle persone un aggregato informe e unico (parrocchia = paese = tutti).
- ci domandiamo a volte dove sia il prete che si identifica con il “contadino che dorme” di Marco 4,26, dove il seme ha tempi lunghi tra l’essere seminato e crescere. Normalmente si testimonia la fede non come possibilità, ma come prodotto nel senso ricordato da Bonhoeffer (lettera del 5 maggio 1944): “uccellino o mangi o muori”. Il nostro essere di minoranza, ma non marginali, come PO, indica essenzialmente un legame stretto tra ricerca di liberazione per sé nell’esperienza religiosa e contemporaneamente di come la necessaria testimonianza, renda possibile l’intreccio tra la libertà di Dio, la libertà dei soggetti singoli e la libertà del loro incontrarsi.
3. CONSEGUENZE PER LA FEDE
a. La libertà, essere liberi e liberare
“Lavorare” per il PO è molto di più che un migliore strumento di pastorale, un nuovo metodo di conquista dei lavoratori alla Chiesa; per noi è diventato:
• decentramento, distacco della nostra vita (che è ricerca di noi stessi come pane-lavoro-identità ecc.) dall’identificazione con la testimonianza come ruolo, vedendola invece nel suo normale aspetto, come ora, nella fatica comune, nella normalità, nella quotidianità piatta, dove cogliamo uno dei molti elementi liberi che fanno l’accadere, la venuta del Regno di Dio;
• mettere in evidenza, nella teoria e nella prassi la pericolosità dell’eccessiva importanza e decisività del sacerdozio a tempo pieno nei confronti della fede e della comunità, molto al di là dell’“ex opere operato” sacramentale e dell’annuncio del Vangelo, che ritorna così ad essere l’essenziale. Una delega della società e dello Stato e il tradizionale desiderio di “espandersi” e di “occupare” spazi e ruoli (supplenze), nel Veneto, più che altrove!, hanno portato ad una trasformazione del prete da testimone esperimentato di fatti religiosi, a operatore sociale onnicomprensivo. Avrebbe per questo necessità di una specializzazione (tanto quantitativa, che qualitativa), ma non la ricerca, perché ritiene che è suo proprio patrimonio congenito, legato al ruolo religioso. Questa perdita di identità o il non sapere quale sia effettivamente il suo “lavoro” ha per il prete una forte ricaduta nella sua fede, perché resta oscurata la verità essenziale. Cioè che nella ricerca di Dio è impensabile non il ruolo istituzionale o sociale, ma l’azione e la ricerca del singolo (in qualsiasi situazione sia l’istituzione), la sua attività di riflessione sulla sua vita e sulla fede, l’autonomia della sua coscienza, la preghiera e la grazia libera. Questo vale per tutti e non può essere sostituito dalla vicinanza o meno di qualsiasi intermediario;
• rinunciare a dire il senso dell’umano di fronte a Dio, partendo da piattaforme sociali, politiche, economiche, di cui non si porta il peso (matrimonio-sessualità-lavoro…), mentre invece, se possibile, dovremo “dire Dio”, pregare, proclamare un’etica e una morale cristiana a partire dalle nostre realtà vissute e dalle situazioni di vita condivise; solo loro portano al dono della vita in maniera totale, come nelle testimonianze che ci vengono dal Sud, come don Peppino Puglisi e don Giuseppe Diana e gli altri;
• significa anche, da quello che constatiamo, trovare il modo di liberare nel prete e nei credenti le disponibilità e le responsabilità necessarie negli ambiti collettivi della politica (laicali-mondane), invece di negarle, mettendosi al riparo, in politica, lasciandola gestire alla Gerarchia (vedi l’adesione incondizionata alla DC, di cui ora si tende a scaricare le connivenze e le responsabilità, mai ammesse); o invece di rispondere con una difesa ad oltranza degli ambiti considerati “sacri” e propri (scuola cattolica, partito cattolico, maestri cattolici ecc.) o operando dietro le quinte, giustificandosi con la salvaguardia del “bene della Chiesa”;
• diventa urgente per noi e per tutti percepire la propria religione come tutte le altre religioni nel loro aspetto istituzionale, come insufficienti, limitate, bisognose di “redenzione”, di umanizzazione, di costante riforma, soprattutto nei riguardi delle loro responsabilità nel manifestarsi delle ingiustizie esistenti nel mondo (cfr. Balducci). L’attuale forza delle religioni è insieme una “miseria” che vive della “miseria degli Stati”, cioè della loro incapacità di mettere mano ai problemi e risolverli radicalmente e a livello politico mondiale;
• vivere tra i lavoratori ci ha fatto avvertire che il Regno non può essere pensato come salvezza-rifugio, ma come liberazione-impegno, come cammino di ricerca per affrontare e risolvere i problemi dell’umanità oggi (cfr. rivista Pretioperai n. 19, aprile 1992), a dimensione planetaria. Questo domanda anche il “mettersi da parte”, in riferimento alla testimonianza, nei riguardi del problema “Dio”, ritenendolo non un oggetto di lavoro fuori del mondo, nella prospettiva medievale e monacale dell’“ora”, più valido e dignitoso del “labora”. Ci pare cheDio va cercato là dove ha scelto di essere incarnato, vivente, operante, la cui possibilità di incontro diviene un compito da ripensare, un bene non proprio, non strumentalizzabile, non fonte di denaro e di sussistenza per lavoratori del sacro a tempo pieno;
• significa ancora superare l’attuale situazione, che riduce la testimonianza a pura produzione di senso o di motivazioni etiche, a “salvezza” e a interessato recupero di privilegi e del paradiso, che conduce a costruire luoghi, spazi e mezzi cristiani, ruoli certi nell’organizzazione chiesa e un “potere spirituale” (lo Stato fa le guerre, e la Chiesa-charitas cura le ferite!). Più che spazi dobbiamo occupare problemi vissuti, recuperando la gratuità per non chiudere la libertà del linguaggio religioso (cfr. Bori), facendo di Dio e di Cristo eventi politici e morali e trasformando il mistero in assurdo inutile (Trinità definita con tre uguale uno), in insensatezza mortale, fuori del reale. Questo è anche il modo di ridurre la trascendenza e il mistero ad essere calcolabile, visibile, sottomessa al dilemma visibile uguale significante / invisibile uguale insignificante , slegata dall’azione e dall’impegno politico, dalle responsabilità globali sul mondo e per l’umanità, pur attraverso i beni variabili, temporali, discutibili, non definitivi della politica corrente;
• occorre giocare l’Incarnazione assieme allo Spirito (come la Samaritana di Gv. 4, e Nicodemo di Gv. 3; e il Gv. 16, 7 del “è bene per voi che io me ne vada”), perché non diventi giustificazione di “sabati” o di “templi”, di fughe o di spiritualizzazioni evasive, di condanne per tradimenti o infedeltà nel momento in cui qualcuno condivide la situazione di drogati, omosessuali, divorziati, emarginati sociali (vedi vicenda del vescovo francese mons. Gaillot o di quello messicano mons. Samuel Ruiz). Non ha significato mostrare la realtà divina come realtà potente e tappabuchi, che non rende ragione (vedi Matteo 25,31 ss. e Simone Weil nel Quaderno IV) del rendersi assente del Dio forte e onnipotente nel Cristo crocifisso, che appare come portavoce dei non-Cristo nei crocifissi qualsiasi. Per cui anche le “lacrime delle Madonne”, soprattutto se è sangue vero, nascondono le lacrime reali dei qualsiasi di Matteo 25, nei quali va cercata realmente la presenza della Madonna. Abbiamo imparato in questi anni, che la vita e la riflessione dei PO deve superare ogni auto-compiacimento e ogni fissazione pro o contro l’istituzione, considerandolo problema non-essenziale, per il fatto che ci è domandato di amare gli uomini in quanto tali, neppure in quanto rappresentanti di Cristo, visto che Lui si è fatto già prossimo. Proprio in quanto credenti, ci è richiesto di uscire dall’ecclesiasticità (“davanti a Dio, vivere senza Dio”, come dice Bonhoeffer nella Lettera del 16/7/44, pag. 440), per approdare all’ecclesialità, da questa alla fede e dalla fede all’agire nel bene, senza mercede e senza tanti perché (cfr. Matteo): è la fede laica, attuata nella profanità, nella mondanità.
b. La divinità: fra trascendenza e responsabilità umana
Quello che caratterizza il nostro cammino di PO è proprio questo passaggio continuo alla laicità, alla profanità, non solo come situazione storica, ma come struttura necessaria dell’essere cristiani, prevista dallo spirito di Matteo 25, 3lss. (Cristo che crea la profanità della religione, dove l’agire cristiano si attua nel non sapersi cristiani). Occorre tuttavia evitare che l’esercizio della nostra libertà sia un autocompiacimento; confermi cioè, magari con forme più democratiche, l’attuale e non controllato esercizio di libertà, che c’è nella classe dirigente della Chiesa. Essa, come tutte le società organizzate, vive nel comunitario, un radicale vivere per sé, per la sua sopravvivenza, per rinsaldarsi. E in questo senso c’è un totale silenzio circa la verità comune, evidente, che anche la classe dirigente della Chiesa rientra nei fenomeni corporativi presenti nella politica, nei partiti, nei sindacati, nelle organizzazioni come tali. Si tratta dell’uso privato del bene pubblico (in questo caso la religione), che invece oggi sembra che la Chiesa non metta tra le sue tentazioni concrete. La nostra esperienza ha qui un suo senso e qualcosa da dire:
1. • perché come lavoratori (essendo cioè lavoratori e non solo “con” i lavoratori), siamo diventati “qualsiasi”, dispersi nelle correnti economiche e politiche della società, che ci ha sbattuti e ci sbatte dove vuole, come tutti i lavoratori. Inoltre e soprattutto abbiamo abbandonato o ci sono stati tolti (perché coinvolti radicalmente!) tutti i ripari che vengono dall’essere sempre e comunque educatori di…, in perenne funzione educante, ignorando il fatto che nella comunità cristiana esistono correnti, uguali a quelle della politica o addirittura più pericolose, perché nascoste nel paternalismo e nella difesa di categoria. Esse sbattono il credente e lo trascinano via senza complimenti sulle strade dell’irresponsabilità e del gregarismo. Infatti qui, come nell’economia e nei regimi di mercato, si ha ben poco il senso delle masse, che sono vittime di mode, di strategie, di autorità a discrezione, di dogmi che diventano opinioni (il Papa ora scrive libri oltre che Encicliche) o di opinioni che diventano dogmi (cambia il prete in un paese e cambiano le verità e i valori). Noi PO muteremmo la nostra esperienza di condivisione se (al di là del “sono pecore senza pastore” di Matteo 9, 6) non sentissimo in noi, diventati gente con loro e come loro, questa situazione. Forse noi avvertiamo meglio il disastro della perdita di cristianesimo nel diffondersi della società-civiltà cristiana. Il pressapochismo delle autorità ecclesiastiche, il loro agire per i propri interessi economici e politici, il loro considerare i fedeli degli eterni bambini obbedienti, ricercando su di loro autorità morali e prestigio sociale, la solitudine dei credenti senza stimoli e proposte “spirituali”, ci fanno pensare al rischio di abituarsi al peggio, all’addomesticamento del Vangelo, all’inutilità del trascendente, perché – come tutti i professionisti che accettano quote statisticamente prevedibili di fallimenti – anche noi accettiamo con distacco i disagi degli utenti tra i compagni di lavoro e di vita.
2. • Eppure, proprio perché PO, credenti-operai, dovremmo invece sentire i disagi e gli errori non come medici, ma come malati, condividendo con i cristiani qualsiasi l’essere trattati male, ignorati, strumentalizzati, oggetto di aggregazione anonima, gente comune, ascoltatori, elettori, oggetto di controllo morale e politico, consumatori applaudenti ecc., figli di un “dio minore”! Poiché in anni di vita operaia, abbiamo visto che niente della testimonianza clericale può essere utilizzato, senza profonde trasformazioni. Sappiamo tuttavia che esse non richiedono strumenti culturali straordinari o nuove missioni, salvo misurarsi con la vita quotidiana, con la normalità.
Diventa indispensabile l’essere adulti e liberi per sé a partire da questa sofferenza in proprio, per porre il problema della libertà, che è da condividere e diffondere per tutti, anche nella Chiesa.
Questo diviene compito urgente, anche per chi è in parrocchia, perché, essendo la Chiesa da noi una società di delega, dove è diffuso il senso di indegnità e di paura, di scarsa circolazione di idee e innovazioni, predomina la potenza delle abitudini e dei gesti tradizionali-sacralizzati, per cui è più urgente e più necessario il lavoro dei singoli. Libertà per sé e per gli altri, dicevamo, e ciò comporta “portare anche noi i pesi che imponiamo agli altri”.
Può essere utile orientarsi su queste linee:
a) rivendicare nella Chiesa spazio alla libertà personale, assumendo anche l’esser soli, come possibilità che si toglie al fatale proiettarsi sempre sugli altri, sulla loro conversione, senza coinvolgere la propria,
b) lottare per una classe dirigente diversa nella Chiesa, perché, essendo una società povera di democrazia e di formazione di cittadini responsabili, “dà cattivi esempi” e spoliticizza la presenza laicale e le toglie l’autorevolezza di essere in politica per scelta propria, senza primogeniture, concordati, spazi cattolici, partiti ecc., pagandone i prezzi e assumendosene le responsabilità e gli errori (leggi comportamento con la DC ora PPI, CDU, CCD, e interventi recenti nuovamente poco chiari e senza assunzione di responsabilità a rischio e ammettendo le sconfitte e gli errori…);
c) non ritenere compito totale e a termine la lotta per la riforma della Chiesa (“semper reformanda”), perché la sua organizzazione è spesso insensata, non solo perché si è tolta tutti i mezzi per riformarsi, lasciandosi stimolare dalle situazioni, dalle problematiche mondiali e dalla vita vissuta e tragica del momento (vedi il dominio dei tradizionalisti duri, intransigenti, nostalgici tra i vescovi), ma soprattutto perché questa insensatezza è stata prevista da Cristo e dal Vangelo come intrinseca a ogni istituzione, anche “santa” (Matteo 23);
d) significa infine non dimenticare mai che Cristo per il credente non è fondatore della Chiesa (cioè sepolto e dimenticato dai discepoli, che ora continuano loro al suo posto), ma resta contemporaneo alla Chiesa, come evento che mette l’organizzazione alla periferia, in modo che i rapporti con essa non siano decisivi e indispensabili. Lo stesso Vangelo si rifiuta di essere un testo fondante una certa Chiesa più di un’altra, quella di Pietro più di quella di Giovanni. Usandolo così lo si fa morire, perché lo si mutila e lo si riduce. È invece contemporaneo proprio attraverso le sue contraddizioni e i suoi paradossi. Incarnazione e Spirito: l’uno senza “mondanizzazione” e l’altro senza “spiritualismi”, come nella Lettera a Diogneto.
c. La resistenza: profanità, politica e laicità
1. resistenza e decentramento della fede nella “profanità” del Cristo sofferente presente in chi non è Cristo. Valore centrale dell’etica cristiana, in quanto esce e vive fuori dai “recinti della mercede” di Matteo 6 (“Quando pregate…”) e dalle “cose cristiane”. Significa dar valore alla politica, i pesi della quale sono portati in proprio, a proprio rischio, pagandone il prezzo, come dicevamo;
2. resistere e decentrarsi della Chiesa da comunità “pediatrica” (spesso ipocrita e solo per gli altri), a comunità di adulti, dove l’educazione dei bambini è “d’ambiente”, diretta a loro, divenuta fatto personale, esperienza di Dio, senza troppe mediazioni;
3. decentramento del prete da educatore a adulto, che vive in proprio l’esperienza di fede e che, come testimone, semina e “dorme”. Si deve andare verso la fine dell’ansia di indottrinare, verso la scoperta della comunicazione dolce (tante lune da indicare e un dito solo che le indica senza confusioni e travisamenti) e nessuno padrone della fede degli altri, neppure a scopo pedagogico;
4. decentramento della fede verso la responsabilità in politica, senza marchi o recinti, da vivere poi in una presa di distanza da un fideismo succube e superstizioso e dalle pratiche senza coinvolgimento della vita, verso un culto e una preghiera da credenti adulti (Messa e ciclo liturgico compreso, oggi ridotto a contenitore di riti e simboli incomprensibili e massificanti). Dato che il sacerdozio non è considerato valido “ex opere operato”, ma “ex opere operantis”, l’assemblea liturgica rischia di farsi sociale e politica, più che “spirituale” e piena di “mistero”. Il decentramento verso il culto è insieme decentramento verso l’esperienza religiosa, dove (nel suo sperimentarsi) non solo scompare il sacerdozio, ma gli stessi riti, gesti, teologie sono solo “figure”, che sono attraversate dall’esperienza: quindi né sacramenti, né non-sacramenti, ma solo occasioni e creazione di momenti vissuti, attualizzati. Qui essi si riscattano dall’abbandono e dal disprezzo di quelli che li usano come evidenze, costumi, cornici delle verità fondanti (Trinità, Incarnazione…), che diventano invece, manifestandosi in essi, esperienze vissute, mistica del quotidiano, incontro indicibile tra umano e divino;
5. infine l’ultimo decentramento avviene nel rispetto delle persone, nella creazione-considerazione dei credenti come “gente” (“gente semplice che non ha bisogno di molte teologie e da tener lontana dagli “intellettualoni”), salvaguardati nella loro esperienza di singoli e insieme di popolo di Dio, che il Vangelo ritiene degni delle briciole. Ad essi si propone quanto più è possibile, in tempi lunghi, tutta la ricchezza della tradizione cristiana e non cristiana, oltre quindi i rifiuti catechistici o gli omogeneizzati predigeriti del Vangelo di tante omelie. Quello che sarà decisivo e che va oltre questi e altri strumenti culturali, avverrà necessariamente “altrove” rispetto sia alla coppia testimone-discepolo, sia al gruppo e alla comunità, nella “stanza” solitaria di Matteo 6 o nella “pietruzza bianca” di Apocalisse (2,17). Là dove si diventa “famigliari di Dio”, liberi e portatori di libertà.
Pretioperai del Veneto
NEL TEMPO
Sul come i PO possono intendere la Resistenza tra i due estremi della febbre del “nuovismo” o del “rimanere a seppellire i propri morti”, possono aiutare due lettere di Bonhoeffer:
• contro la smemoratezza (Resistenza e resa, Lettera 1/2/44, Ed. Paoline, pag. 275),
dove la responsabilità del passato, i valori originari e originanti, chiedono fedeltà senza compromessi;
• per il senso di un futuro “sempre adveniens”, non quindi già detto e già dato (Resistenza e resa, Lettera 21/2/44, Ed. Paoline, pag. 289): le origini ritornano dal futuro, Dio è presente anche nel destino, che si accetta anche se subito non si capisce e che solo dopo diventa “guida”.
