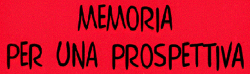
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1996
1° gruppo
Sfrondare la memoria per avere uno sguardo più ampio
sul fronte della fede e della mondialità
Innanzitutto la foto del gruppo: tra i PO italiani, infatti, vige la “cultura dei nomi propri”, dei “volti”; ecco allora la composizione del gruppo: Giorgio Bersani, Beppe Socci, Nino Nigra, Mario Pasquale, Angelo Reginato, Giampiero Zago, Luigi Meggiato, Delfina Rossano, Jean Perrot.
Dopo la fotografia, la radiografia! Dal punto di vista lavorativo il gruppo era composto da 3 persone che lavorano in fabbrica, 2 in cooperative di produzione-lavoro, 1 in un patronato sindacale, 1 in cassa integrazione a perdere e 3 pensionati.
Dal punto di vista del ministero ecclesiale 3 dei componenti svolgono la funzione di parroco.
Dal punto di vista delle attività e degli interessi principali è emerso il dato di una diversificazione di percorsi: si va dall’intervento culturale nell’ambito delle scuole popolari, nella redazione di riviste o anche nel campo artistico-musicale; all’attività associativa nelle ACLI o nell’arcipelago del sindacalismo (confederale o autoorganizzato); all’impegno sul fronte dell’ecumenismo e del dialogo inter-religioso. La differenziazione dei fronti d’intervento non toglie, tuttavia, un “minimo comun denominatore”, una passione condivisa da tutti: quella per l’umanizzazione della fede e della vita. Una passione etica più che sacrale. Una battaglia per la laicità e per il riconoscimento e la valorizzazione della fragilità dell’umano.
I componenti del gruppo hanno trovato una convergenza anche sull’atteggiamento dell’ascolto, il quale si dà solo riscoprendo il valore delle singole persone (i volti!), coltivando, dunque, rapporti personali in gruppi ristretti.
La discussione sulle relazioni
* Rispetto alla “memoria”. Alcuni hanno posto l’accento sulla novità della situazione attuale. Se all’inizio della parabola dei PO sta il “salto” in classe operaia, ora è necessario un secondo “salto”: sfrondare la memoria per avere uno sguardo più ampio sul fronte della fede e della mondialità. In questa direzione sono fondamentali le alleanze-collaborazioni con altri soggetti. Uno dei componenti del gruppo ha usato l’immagine della barca che ad un certo punto urta contro uno scoglio e si frantuma in tante assi: ci si salva solo aggrappandosi ad una di queste.
Dietro queste considerazioni si intravvede il “paradigma della diversificazione” che è applicato sia al campo ecclesiale, sia a quello sociale, sia alla vicenda stessa dei PO.
Altri invece hanno posto l’accento sulla continuità da non perdere, sul dovere di una memoria attiva. Secondo costoro fa parte del patrimonio dei PO italiani il lasciarsi evangelizzare dalla vita: più che evangelizzare, il vivere una fede povera, essenziale, il costruire una chiesa umile (kenotica) e non trionfalista. Questi nodi mantengono tutta quanta la loro attualità proprio perché non si può considerarli sciolti.
Dietro queste riflessioni si intravvede il “paradigma dell’unità”: un’unità da ricercare attorno al “ripensare il cristianesimo”.
* Rispetto al quadro socio-economico. In un contesto lavorativo peggiorato, dove la maggior parte degli operai “lavora, tace e non pensa”, dove l’antagonismo è giocato nei rapporti tra lavoratori; in una simile situazione è fondamentale “restare”. Un “restare” che spinge ad essere più esigenti nei confronti della politica, della cultura, della fede. Un “restare” per farsi interrogare dalla situazione e continuare a “cercare”.
(a cura di Angelo Reginato)
2° gruppo
Siamo capitati dentro un fiume di gente
che ha alzato la testa accettando il conflitto
Le storie personali, presenti in modo molto convinto e determinato, nella prima parte del lavoro di gruppo, hanno interagito in modo attivo con le tre relazioni di apertura del convegno. Ogni storia personale segna però reazioni abbastanza differenziate. Della storia del movimento PO c’è un sentire positivo e, in certo senso, orgoglioso. Anche perché la si percepisce, la nostra, come “uno” dei fili di una storia di un alzare la testa da parte delle condizioni subalterne, iniziata molto prima di noi, nell’800. Siamo capitati dentro un fiume di gente “che ha alzato la testa”, accettando il conflitto, non accettando ‘guide’.
Una storia anche molto laica di non omologabilità, da tenere quindi in una memoria da non disperdere. Certo, in una fase di dispersione, bisognerà anche rinunciare a un ‘dire’ e ‘diffondere’ qualcosa come da una nostra centrale personale, nel senso di mete e progetti generali. Ognuno è messaggero all’altro, nelle microvite che abbiamo, intrecciate con altri. Ma LEI, la verità, avrà le sue strade e i suoi tempi per autodiffondersi, dopo il tramonto dei centri forti come il movimento operaio o di centri come la Chiesa, dove dissenso e discussione creavano vitalità, a differenza dell’attuale encefalogramma piatto. Soccorrono forse, alcune parole del N.T. (le lettere di consolazione e rimprovero alle sette chiese, nell’Apocalisse, o lo “stolti! Non avete capito che…” ai delusi delle Emmaus di ieri e di oggi, o le beatitudini) o i temi della ‘perfetta letizia’ in Francesco censurato. Da queste categorie religiose e mistiche, dovranno attentamente essere tenuti lontani i confusionari ingenui o astuti, che fanno di esse un uso politico oppressivo. È stato anche fatto notare il pericolo che la nostra storia diventi o un ‘santino’ o le vicende dei cavalieri senza macchia e senza paura.
Due osservazioni. Se indubbio è stato il coinvolgimento materiale e politico con le classi subalterne nelle condizioni di lavoro e di cittadinanza, scarsa o nulla è stata la condivisione o una qualche empatia con le condizioni di cristiani dei nostri compagni di lavoro e, più in generale, delle classi popolari. È sfuggito che il ‘non contar niente’ nei rapporti di lavoro aveva ed ha un corrispettivo nell’essere ‘gregge’, ‘fedeli’, ‘la nostra buona gente’ ecc. nella Chiesa. Lettori di Bonhoeffer, Eckart ecc., si accetta che poi, per la gente, vadano bene madonne, superstizioni, le piazze che applaudono i vari Lui, ecc.
L’altra osservazione riguarda la completa inattualità (se non fantasiosità come ricostruzione storica) della nostra storia, qualora essa sia storia di chi ‘condivide’ a fronte dei preti che non condividono, oppure vicenda di vite ‘profetiche’ a fronte della macchina-istituzione. Perché?
Oggi la delega dello Stato da una parte, il farsi la Chiesa agenzia di valori e servizi sociali su tutti i fronti dall’altra, la completa professionalizzazione del prete, diventato a pieno titolo non solo ‘prete operaio del terziario’, ma assommante in sé le più disparate mansioni e competenze, fa della nostra ‘condivisione’ e del nostro ‘profetismo’ un assurdo, una parola comoda per avere noi un’identità, ma muta perché essenzialmente privata.
Sembra quindi che (in un rovesciarsi di un luogo comune tra noi) un certo futuro dei preti-operai sia nei PO-parroci. Qui sembra esserci un terreno di inizio di una discussione che può portare la nostra storia ad essere una risorsa per la società e la Chiesa. Il lavoro infatti di preti che siano nella pastorale (grande o piccola che sia) permette di immettere un ostacolo attivo dentro alla macchina socio-sacrale che schiaccia la fede sul sociale, schiaccia il prete come uomo o come credente sul suo ruolo, non permette di governare in qualche modo né il suo egoismo né la sua generosità. Il lavoro del prete come divisione di ruoli, automantenimento, libertà di uomo e di credente ecc.: “l’essere così una risorsa per la società, il rimandare la società ai suoi compiti ecc. Questi sono i terreni di un’interazione possibile tra storia dei PO e la società, al di là del lutto nostalgico perché ormai non ci sono più PO…”
La reazione del gruppo alla relazione di Cesare, è stata inizialmente di un blocco, soprattutto perché due amici del gruppo (Consonnì e Ambrosini) l’uno per l’Africa e l’altro per il Salvador hanno mostrato, in presa diretta, che cosa sono quelle parole, globalizzazione ecc. L’Africa che offre ai giovani, come futuro, solo la guerra per conto di altri e il Salvador che, passato dal feudalesimo allo sfruttamento selvaggio di una forza lavoro a costo zero, dicono che non c’è futuro, anche se, come in Salvador, i ceti popolari hanno pagato un prezzo altissimo al progetto di liberazione del Fronte.
Dopo il blocco iniziale, vari interventi dei presenti hanno mostrato anche concretamente (per es. essere falegnami e non usare legno di foreste che non saranno reimpiantate) possibili azione di contrasto alla macchina delle sette parole evocate da Cesare.
Sul tema ‘terzo settore’ è stato osservato che il debito pubblico, gli sprechi della gestione del pubblico, potrebbero spingere a buttare sul mercato privato, come già sta accadendo, diritti fondamentali di cittadinanza (come salute, assistenza ecc.), settori dove il mondo cattolico, che pensa i cittadini in difficoltà come “bisognosi”, è già pronto per intervenire.
(a cura di Roberto Berton)
3° gruppo
Non abbiamo cambiato niente
nella Chiesa, nel sindacato, nel mondo…
ma ci siamo legati alla normalità della vita,
ad una vita vista dal basso
(R. Fiorini, A. Ruffato, R. Povoli, C. Carlevaris, L. Sonnenfeld, M. Faldani, N. Barra, B. Introvigne, G. Manziega, S. Artioli, O. Ferrari).
Non abbiamo cambiato niente nella Chiesa, nel sindacato, nel mondo… È vero: può essere questa la nostra resa di fronte alla storia nella quale ci siamo immersi con tanta foga, con spirito giovane, senza riserve. La storia della classe operaia, sul finire degli anni ‘60.
Ma ci siamo legati alla normalità della vita, ad una vita tutta vista dal basso. Abbiamo fatto del quotidiano il nostro chiostro.
La scoperta che ci ha sorpreso e ancora ci sorprende, è che questo non ha spento le tensioni. Non è stato un rientrare nei ranghi per aver sofferto quell’ essere a parte che caratterizza la crisi attuale del prete. Non ci ha fatto mollare.
Per anni abbiamo arato il campo, ma oggi possiamo dire che una pianta è nata. Tra i rovi, forse, ma questo dà ragione della serenità di fondo che oggi esprimiamo, mantenendo aperta la speranza.
Alla radice, il rifiuto di Dio come oggetto. Quel Dio mai raggiunto e sempre ricercato. Quel Dio che è Grazia e quindi Amore per tutta l’umanità e Libertà di poter essere questo amore.
E, come frutto, la consapevolezza che questa libertà di Dio possa incontrare la libertà dell’uomo e della donna. Nella Parola di Cristo, unico mediatore.
Gesù Cristo, libertà non esercitata per se stessa come nell’esperienza umana dopo la “caduta”, ma, in novità di vita, per far essere l’altro / l’altra.
Il sentiero che si è aperto è quello di un servizio reso alla “diminuzione” del potere delle mediazioni che offuscano l’unica mediazione. A cominciare dalla mediazione del prete e, più in generale, di quella del potere ecclesiastico.
“Diminuire”. Fin dove? Fino a che punto?
Qui si apre tra noi una forbice. Essa parte da lontano e si alimenta in teologie assai diverse tra di loro. Da una parte c’è chi attraverso questa “diminuzione”, spera in una Chiesa finalmente serva e povera. Dall’altra chi la sente come misura di resistenza verso una Chiesa in cui sembra predominare un istinto di conservazione di sé. Dall’altra ancora chi la vede come l’azzeramento necessario di ogni vecchio otre, perché il vino nuovo dell’adorare Dio in spirito e verità è possibile solo in nuovi contenitori: quando e quali?
La forbice si allarga – se possibile – ancora di più quando si passa ad esaminare quella realtà ormai a dimensioni mondiali che coinvolge la vita economica e culturale. Eppure ci si potrebbe aspettare una posizione convergente in un unico “realistico” atteggiamento: quello di rinuncia “perché non c’è nulla da fare”. Ma dal “micro” di ciascuno cresce una voglia di analisi per capire e aiutare gli altri a capire.
La presenza tra noi di posizioni tanto diverse per situazioni di vita, di lavoro, per scelte politiche e sindacali, per idealità di segno opposto ha condizionato, fino ad oggi, un certo silenzio. Come un passarci sopra per troppa sofferenza.
Tutti i presenti nel gruppo sono intervenuti, ed è stato come un primo confronto che ha aperto spazi per un prossimo incontro dove scambiare analisi, prospettive per poter resistere.
Dagli interventi:
• Occorre dirci i nostri angoli di visuale.
• Chi non si oppone e non organizza il dissenso è orientato quanto meno alla collaborazione passiva.
• Guardando avanti, qualcuno dovrebbe dirmi che non sono solo uno che “ha scelto” di lavorare, ma uno che vuole vivere. Perché il livello di vita è così asfittico…
• Il dissenso va contestualizzato: rispetto ai contratti di lavoro, rispetto alla difesa della salute, rispetto alla dignità della persona.
• Il peso del “primo mondo” cresce sempre più: con le mie lotte cosa scarico nel “terzo mondo”?
• Riascoltiamo quella voce di profeti che all’inizio ci ha permesso di capire. Di chi sarà il Regno?
• Un modo caratteristico di essere insieme poneva problemi agli altri. Ci riusciamo oggi?
• A noi del nordest dicono che siamo ricchi, ma la nostra ricchezza è frutto del pensiero unico, del mercato.
• Si è avviato un processo economico il cui punto d’arrivo neppure i grandi proprietari riescono a scorgere.
• Stiamo vivendo un periodo di transizione in cui possono prevalere gli elementi negativi. Ma anche elementi di speranza.
• Dobbiamo darci luoghi di pensiero su scala mondiale: tocca a chi si accorge di non poter più fare il piccolo cabotaggio…
Se si vuole andare avanti insieme occorre confrontarci sulle tematiche che queste considerazioni sottintendono. Anche per capire se vogliamo veramente sottrarci al confinamento nella zona grigia che permette una via d’uscita in un’opposizione puramente intellettiva. Se siamo in grado di esprimere un’opzione e quindi una volontà di azione.
(a cura di Luigi Sonnenfeld)
4° gruppo
Il collettivo PO è ancora luogo di confine
tra esperienza e speranza,
tra lotta dei subalterni ed obbedienza evangelica
Al gruppo hanno partecipato S. Pellegrini, L. Foffano, L. Forigo, G. Piccio, L. Rossi, C. Sommariva, P. Renato, G. Cumini, T. Uderzo, R. Fanfani, M. Kim, G. Song (coreani).
Escludendo i due Coreani, l’età media è di 60,1 anni. La posizione sociale dei componenti: 4 sono pensionati, 4 lavorano in Coop. Sociali, 1 è in mobilità, uno nell’artigianato, uno lavora nel sindacato, 2 sono parroci.
Interazione con le relazioni e dibattito
Ripresa l’immagine del PO come indicatore della condizione del popolo, dei nodi di schiavitù sociopolitica ed anche religiosa, il PO è anche indicatore delle speranze e delle frustrazioni storiche. Essere indicatore esprime il fare continuamente memoria del proprio popolo anche nel vissuto quotidiano ed anche accettare con meraviglia di esser osservato dai compagni di viaggio.
La comunicazione scorre liscia sulla dimensione del racconto personale, sul valore della memoria, sulle militanze e le resistenze attive nel sociale e nel religioso.
Su quest’ultimo punto si è rimarcata:
• la mediazione necessaria, oltre il regime di cristianità, ma una mediazione leggera per non occupare il Mistero, dove ognuno pone la propria umanità nella ricerca, nel dubbio, nella serenità e gioia od anche nella rabbia e sofferenza puntando a ridare la parola (non necessariamente con categorie clericali) alla gente che ne è stata defraudata
• l’uomo adulto e maturo, capace di analizzare le direzioni imposte dalla struttura economica / politica, le conseguenze e ricadute sulla vita della gente; ma capace, anche, di una fede non ridotta a diversivo o fuga.
• l’essere servi inutili: di fronte all’utilitarismo laico (scienza, tecnologia, programmazione, gestione…) e religioso (meriti, premio, servizi sociali della Chiesa…), fiduciosi non nell’efficienza del sacro, ma nell’efficacia della Parola / Vita.
La seconda relazione di Cesare ha in parte spiazzato la memoria e gli equilibri personali nel politico e nel sociale ed è quindi risultata ostica. Qualcuno ha tentato di rivedere il proprio mondo alla luce delle sette parole. Le posizioni personali possono risultare differenti a seconda se si è privilegiato l’essere o l’essere stati nel mondo del lavoro con la dimensione personale / soggettiva: la condivisione, la liberazione da schemi clericali, la nuova visione di vita con il popolo, la comprensione… O dall’altra parte, l’aver privilegiato il porsi dentro la struttura produttiva che crea e svela i meccanismi di subalternità, dipendenza sociale, politica, culturale e religiosa. Il PO, a seconda della finestra che ha scelto, ha visioni differenti.
Vista la composizione del gruppo in cui molti sono impegnati nel sociale, 3° settore e volontariato, l’accettazione è andata al cambiamento in atto che domanda un ripensamento di queste presenze.
In particolare:
• la rottura del compromesso del capitale nazionale con lo stato per giocare a tutto campo sul pianeta senza più ostacoli di blocchi ideologici / politici, sentendosi così libero da vincoli di contributi sociali
• il cambiamento dei soggetti storici della resistenza oltre la Classe Operaia nella figura delle classi subalterne
• la difficoltà a creare dialettica con lo stato nazionale da parte del 3° settore, scavalcato dalla mobilità del capitale
• l’affermazione dello stato sociale che però sta andando all’esaurimento nell’attuale condizione “statalista”; e la necessità di trovare nuove forme di riproposizione riscoprendo energie popolari di base.
Tutto questo mette in discussione l’impianto cattolico del volontariato, ma anche la concezione statalista dello stato sociale della sinistra laica.
Il Collettivo PO è ancora luogo di confine, tra esperienza e speranza, tra lotta dei subalterni ed esperienza evangelica dove poter coniugare l’esserci della persona ma anche il bisogno di capire le situazioni in continua evoluzione.
L’uomo adulto passa dall’etica della convinzione e della responsabilità alla nuova etica di fronte alle provocazioni dei cambiamenti in atto.
(a cura di Luigi FORIGO)
PROSPETTIVE DEL GRUPPO NAZIONALE DEI PO
ED ORGANIZZAZIONE
(assemblea conclusiva)
Nei gruppi di lavoro e nell’assemblea conclusiva è stata sottolineata l’importanza del collettivo nazionale per il sostegno reciproco e per gli scambi di esperienze che rende possibile. Le motivazioni addotte per la continuazione degli incontri a livello nazionale sono le seguenti:
• non abbiamo ancora percorsa tutta la strada;
• è uno stimolo anti-isolamento e quindi una ricarica per l’impegno quotidiano;
• è uno dei momenti rari nei quali avviene nella libertà lo scambio di parola- ascolto-riflessione;
• è un punto di incontro valido perché mette in relazione le differenze presenti tra noi e le diversità dei cammini regionali.
L’assemblea richiede che vengano organizzati incontri con cadenza annuale. In proposito vengono sottolineate due esigenze:
• la necessità di trovarsi insieme come amici in maniera meno rituale e scontata, più affidata… all’evento (convegni);
• l’approfondimento di tematiche e pratiche attraverso l’organizzazione di incontri con altri soggetti; comunità, gruppi, riviste… (seminari).
A livello organizzativo si propone di continuare con un coordinamento nazionale stabile costituito da rappresentanti delle diverse regioni, integrato anche da singoli in rapporto ai programmi che si intendono attuare.
È stata inoltre proposta la costituzione di gruppi di PO omogenei per pratiche, interessi e competenze (es. cooperative, 3° settore, volontariato, parroci…), per l’approfondimento di tematiche specifiche per arricchire il lavoro del coordinamento in vista di seminari e convegni.
Sulla rivista si registra un generale apprezzamento e molta attenzione. Vi è chi ha osservato che talvolta il suo linguaggio è difficile e che non sempre è presente il riferimento al vissuto.
Altri hanno ricordato che spesso gli appelli redazionali a scrivere testimonianze e riflessioni personali per una loro pubblicazione non trovano seguito.
Inoltre si è affermato che, particolarmente in numeri monografici curati da singoli gruppi regionali, il tentativo di pensare la propria fede per oltrepassare le ‘credenze’ o i luoghi comuni della fede predicata, non può non lasciare qualche segno di fatica anche nel linguaggio. Altrimenti – ha finito con il dire uno – chi leggerebbe Paolo o il Vangelo di Giovanni?
