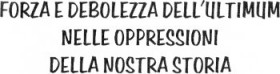
Viareggio, 20-21 aprile 2002
Introduzione
Premessa
Ci ritroviamo ancora una volta qui a Viareggio pretioperai e compagni di strada che hanno incrociato i nostri cammini. Lo scorso anno a Strasburgo ci eravamo ripromessi questo appuntamento. Non si tratta di un ritrovo di nostalgici ma di uno spazio nel quale trova conferma e riconoscimento un elemento di permanenza, presente in noi, la cui energia non si è esaurita o stemperata con il tempo.
In questa comunicazione si offrono alcuni spunti, tracce, allusioni, più o meno sviluppati, senza alcuna pretesa di completezza, che servono ad integrare le sollecitazioni offerte nella lettera di convocazione. In essa scrivevamo: “In questi ultimi anni sulla Rivista, ed anche nei nostri incontri, ha avuto una forte accentuazione il riferimento al tempo: vita e Parola nel tempo ( Vangelo nel tempo : incontro del 2000 e n. 51 della rivista; Svelare il tempo , n. 52; Sulle strade degli uomini e delle donne: vivere l’oggi … aprire l’avvenire: incontro di Strasburgo e n. 52-53; Come vegliare in questo tempo ?: n. 54-55). Pensiamo che questa insistenza nei tentativi di discernimento e di comprensione dei tempi che stiamo vivendo sia l’espressione di interrogativi e di sofferenze profondi, che attraversano il nostro animo. Essi non riguardano tanto la nostra dimensione esistenziale quanto piuttosto il “come va il mondo” e “come va la nostra fede e la nostra responsabilità in questo mondo”.
In un tale contesto è nato il tema che ci siamo dati come punto di incontro dei nostri pensieri e delle nostre esperienze: l’ ultimum ci incrocia, pretende di attraversare i nostri giorni e di diventarne il discrimine, irrompendo nella nostra inevitabile dimensione penultima dove tutto è mescolato, e reclama per sé la ultimatività.
Riportiamo ancora le parole di Sandro già ricordate:
“Vivo il tempo (l’età) in cui uno si sente chiamato a misurarsi sull’ ultimum (“perché non venga all’improvviso”). Penso ci sia un ultimum (giudizio, ventilabro, pigiatura) anche del credere. Di fronte ad esso tutte le cose penultime diventano, in qualche modo, “relative” (ho creduto, ho fatto miracoli, ti ho adorato… ). In questo ultimum i giudicanti non sono più le regole, le norme, i comandamenti, i confessori, le gerarchie, ma solo coloro che avevano fame e a cui hai dato da mangiare, che avevano sete e hai dato da bere, che erano nudi, perseguitati, affamati di giustizia … L’ ultimum non è quindi il ‘dopo’ della vita ma il suo punto di arrivo cosciente e responsabile, che relativizza tutto riconducendo le cose al loro nocciolo duro non mistificabile. Come se sentissi il bisogno di non chiedermi ormai più nient’altro che questo: se quello che faccio risponde o no alla domanda del tribunale della storia di oggi” (Per una domanda sulla dimensione teologale della mia vita in Pretioperai 34/1996 pp. 17-22)
L’ultimum: forza e debolezza
Noi non possediamo la chiave dell’ ultimum, nessuno lo possiede o lo può arginare. Appartiene a quell’ordine segreto che non si può manomettere o circoscrivere catturandolo nel discorso, deviandolo nella metafisica o mettendolo al bando con i meccanismi della forza. Appartiene all’ordine dell’evento ed entra nella concretezza di tutte le relazioni, progettualità ed attuazioni umane. Esso ci incrocia sempre, è dentro le nostre decisioni, chiede conto della nostra libertà. Ci viene incontro non perché siamo noi a programmarlo, ma semplicemente perché attraversa il nostro cammino e non possiamo evitare di incontrarlo.
Parlando dell’ ultimum per noi è giusto ricorrere al repertorio biblico. Però deve essere chiaro che va ben oltre le narrazioni che troviamo nella Bibbia ed anche nelle altre tradizioni religiose, perché la sua pretesa ha un carattere di universalità.
Ecco alcuni tra i moltissimi testi:
– Mt. 25, 3-46
– Lc. 13, 22-30
– Ger. 22, 15-16
Non ci soffermiamo nel commento esegetico ai singoli brani. Preferiamo riportare alcuni testi che esprimono in sintesi la forza in essi evocata.
La prima citazione la prendiamo da La prima radice di S. Weil, un’opera scritta quando era ormai prossima alla morte per “radicare un popolo”, quello francese, che esce distrutto, soprattutto moralmente, dalle rovine della seconda guerra mondiale.
La Weil parte dalla insufficienza della dichiarazione dei diritti per affermare la necessità di recuperare l’idea della obbligazione verso l’essere umano, nella sua concretezza, a partire dai suoi bisogni, primo fra tutti il cibo.
“Quest’obbligo non si fonda su nessuna situazione di fatto, né sulla giurisprudenza, né sui costumi, né sulla struttura sociale, né su rapporti di forza, né sull’eredità del passato, né su un presupposto orientamento della storia. Poiché nessuna situazione di fatto può suscitare un obbligo … Quest’obbligo non si fonda su nessuna convenzione … Quest’obbligo è eterno. Esso risponde al destino eterno dell’essere umano … Quest’obbligo è incondizionato. Se esso fosse fondato su qualcosa, questo qualcosa non appartiene al nostro mondo. Nel nostro mondo non è fondato su nulla … Quest’obbligo non ha un fondamento, bensì una verifica nell’accordo della coscienza universale. Esso è espresso da taluni dei più antichi testi che ci siano conservati. Viene riconosciuto da tutti e in tutti i casi particolari dove non è combattuto dagli interessi o dalle passioni. Il progresso si misura su di esso … Benché quest’obbligo eterno risponda al destino eterno dell’essere umano, esso non ha per suo diretto oggetto quel destino … L’obbligo è adempiuto soltanto se il rispetto è effettivamente espresso, in modo reale, non fittizio; e questo può avvenire soltanto mediante i bisogni terrestri dell’uomo. La coscienza umana, su questo punto, non ha mutato mai. Migliaia di anni fa gli egiziani pensavano che un’anima umana non possa giustificarsi dopo la morte se non può dire: ‘non ho fatto patire la fame a nessuno’. Tutti i cristiani sanno di dover udire un giorno Cristo dire loro: ‘ho avuto fame e tu mi hai dato da mangiare’ … Far sì che non soffra la fame quando si ha la possibilità di aiutarlo è dunque un obbligo eterno verso l’essere umano. Essendo questo il più evidente esso dovrà servire come esempio per comporre l’elenco dei doveri eterni verso ogni essere umano” .
Commenta P.C. Bori:
“(In questo testo) si distingue tra fondamento, verifica, oggetto dell’obbligazione morale. Al carattere incondizionato, assoluto dell’obbligazione morale quanto al suo fondamento corrisponde, anzi è inversamente proporzionale la concretezza del suo oggetto, che emerge dalla specificità e determinatezza antropologica, storica, politica dei bisogni umani, che costituiscono il contenuto dei diritti.” (Per un consenso etico tra le culture, Marietti 1991 pp. 91-92).
Un testo di Arturo Paoli ci consente un approfondimento sul fronte del rapporto tra obbligazione etica ed il religioso.
Si pone queste domande:
“Perché le persone profondamente religiose, che sembrano aver fatto della religione il senso unico della vita, sono così disorientate nelle scelte politiche al punto da trovarsi sempre dalla parte dell’oppressione e mai della liberazione dell’uomo? Perché persone profondamente religiose vorrebbero imitare Cristo povero, ma non comprendendo appieno il senso della povertà, finiscono per non intendere l’economico come valore veramente religioso e cadono nella complicità con coloro che usano l’economia come strumento per dare morte all’altro?”.
La risposta è molto importante perché esprime una discriminante netta:
“Perché hanno collocato la trascendenza fuori . Il rifiuto del sacro e del mistico in Levinas è chiarissimo e non si può non condividere. Questo rifiuto non è già chiaro nei profeti, e non è chiarissimo in Matteo 25? È un testo che può essere accolto da un ateo e da un credente. La trascendenza, cioè l’incontro con l’Infinito, in fondo, è presentata come un ‘investimento della libertà’ … Chi è seguace della metafisica fuori dallo spazio storico leggerà superficialmente il testo di Matteo 25 e capirà il dar da mangiare all’affamato e il vestire l’ignudo come elemosina e l’incontro con l’altro approfondirà il fossato, aumenterà il peso della dominazione, affiderà l’organizzazione sociale a forze neutre che non hanno bisogno di progetti ed ideologie di liberazione. Non è questo lo spettacolo ‘religioso’ a cui oggi assistiamo?…
Nel discorso di Gesù è evidente che è l’altro asimmetrico, perché è l’affamato che accusa me sazio, l’ignudo che accusa me ben vestito e mi comanda: o investo la mia libertà o mi libero dall’accusa allontanandolo da me con un po’ di soldi… La vera mistica è quella che mi obbliga a cercare nell’esteriorità il mistero della mia esistenza.
(…) E quanto più si estende la superficie del sacro tanto più si restringe quella dell’etica e la religione è sempre più alienazione (A. Paoli, Quel che muore, quel che nasce, EGA, pp. 124-125, 113).
L’ ultimum come incondizionato, dotato pertanto di una forza interna più forte di tutte le condizioni, nella Bibbia viene raffigurato come giudizio, come rovesciamento di posizioni, come sovranità indiscussa di Dio e del suo Cristo, come realtà che incombe. Ciascuno di noi è in grado di ricordare moltissimi passi dei due Testamenti nei quali con chiarezza viene affermata la forza di questa signoria a cui deve necessariamente corrispondere la responsabilità dell’essere umano chiamato in causa come “custode di suo fratello”.
I salmi di lode, gli inni che troviamo ad es. nell’Apocalisse rappresentano la confessione fiduciosa di questo potere di bene che si esprime nel produrre tutto ciò che è buono e giusto e che si fa garante che una vera giustizia deve compiersi.
Eppure questo ultimum , che si presenta come imperativo, nel “frattempo” della storia è soggetto pure ad una debolezza sconvolgente.
Ne troviamo la eco ad es. nelle confessioni di Geremia. “Signore, tu sei giusto, eppure io voglio lamentarmi con te; voglio discutere con te a proposito della giustizia. Perché ai malvagi va tutto bene? Perché quelli che compiono il male vivono tranquilli…?”. La risposta è stupefacente: “Geremia, tu ti stanchi a correre quando gareggi con gli uomini; come puoi pensare di farcela con i cavalli? Se non rimani in piedi in un terreno pianeggiante come ti reggerai in piedi sulle rive ripide del Giordano?” (Ger. 12, 1.5).
I salmi di lamentazione esprimono spesso quell’attesa di giustizia di cui si ha assolutamente bisogno e che tarda ad arrivare.
Il dolore umano, l’essere preda dell’ingiustizia rappresenta l’esperienza drammatica di un “ritardo”, spesso intollerabile, nel compiersi della giustizia. La lacerazione di certi testi biblici, sono la eco del grande lamento che sale da tutte le generazioni e in tutto il mondo che indica la sospensione e l’incompiutezza di una giustizia che rimane sempre da compiersi, tanto che addirittura è proclamata una beatitudine per “gli affamati ed assetati di giustizia”.
Ma mentre nella composizione letteraria dei salmi la tensione alla fine si ricompone nella lode e nel ringraziamento, nell’esperienza umana l’ingiustizia rimane, anzi si aggrava, mentre la nostra storia esibisce lo spettacolo devastante e sconvolgente della capacità umana di produrre e strutturare dolore e morte su scala universale.
L’esperienza di oggi è quella di una sproporzione terrificante tra il poco che si riesce a pensare e a fare e la strutturale iniquità che domina il mondo.
Dove è la forza dell’ultimum ? Essa sembra annegare nel grande mare della storia umana.
La sua forza è dunque affidata alla debolezza della nostra assunzione di responsabilità?
Un orientamento importante lo troviamo sintetizzato in un testo di Bonhoeffer: fa parte del canovaccio di un suo progetto di studio a noi pervenuto solo in questa forma:
“Chi è Dio? Anzitutto, non una fede generica in un Dio nella sua onnipotenza ecc. Questa non è autentica esperienza di Dio, ma un pezzo di mondo prolungato. Incontro con Gesù Cristo. Esperienza del fatto che qui è dato un rovesciamento completo dell’essere dell’uomo per il fatto che Gesù esiste per gli altri, eslusivamente. L’ esserci-per-gli-altri di Gesù è l’esperienza della trascendenza! Solo dalla libertà da se stessi, solo dall’ esserci-per-gli-altri fino alla morte nasce l’onnipotenza, l’onniscienza, l’onnipresenza. Fede è partecipare a questo essere di Gesù (incarnazione, croce, risurrezione). Il nostro rapporto con Dio non è un rapporto con un essere più alto, più potente, il migliore che si possa pensare – questa non è autentica trascendenza – bensì, una nuova vita nell’esserci-per-gli-altri , nel partecipare all’essere di Gesù. Il trascendente non è l’impegno infinito, irraggiungibile, ma il prossimo che è dato di volta in volta, che è raggiungibile. Dio in forma umana! Non il mostruoso, il caotico, il lontano, l’orribile in forma umana, come nelle religioni orientali; ma neppure nelle forme concettuali dell’assoluto, del metafisico, dell’infinito, ecc; e neppure la greca divino- umana dell’uomo in sé , bensì l’uomo per gli altri! e perciò il crocifisso. L’uomo che vive a partire dal trascendente” ( Resistenza e Resa , Ed. Paoline p. 462).
In che mondo siamo
I pochi accenni che faremo servono per collocare storicamente i nostri ragionamenti e le nostre possibili assunzioni di responsabilità. Si rimanda oltre che all’ultimo numero di Pretioperai ad un articolo di Raniero La Valle, comparso su Missione oggi nel gennaio scorso, che utilizziamo riportando i punti più salienti.
L’occidente capitalista vincitore nell’89 non ha più antagonisti; finalmente può estendersi fino ai confini della terra in un mondo globalizzato. Allora era ancora un capitalismo influenzato dall’antagonismo socialista e dalle lotte sindacali. L’assenza di antagonismo lo ha portato allo stadio selvaggio che oggi stiamo sperimentando con la sua irrefrenabile pulsione ad annientare fondamentali diritti dei lavoratori e dei cittadini. In Italia ne sappiamo qualcosa!
Nel processo di globalizzazione è diventato sempre più chiaro che il capitalismo non può essere universale. Il mito dello sviluppo per tutti si è rivelato falso perché i meccanismi economici sono attrezzati per produrre profitti e danaro, ma non per soddisfare i bisogni reali.
A questo si deve aggiungere che i sistemi di vita dell’occidente sviluppato non sono estensibili a tutto il mondo per i limiti intrinseci al sistema terra. Non solo, ma diventa impossibile mantenere i livelli attuali: vi è un errore di fondo nel rapporto uomo/natura concepito in termini di sfruttamento e di dominio ottuso. L’assoluta irresponsabilità verso il futuro per le nuove generazioni è l’aspetto più evidente della cecità alla quale costringe la molla universale della ricerca del profitto e del prosciugamento delle risorse da rintracciare e sfruttare in qualunque luogo della terra.
Un tale sistema può reggersi solo sulla guerra. L’occidente ha scelto solo se stesso, dichiarando gli altri superflui; ha scelto la propria parte, il proprio essere, negando l’esistenza degli altri o affermandola solo in quanto utili al proprio scopo.
Un tale mondo si può governare solo con la forza, con la forza di tutta la tecnologia applicata ai diversi campi. In particolare con la forza della tecnologia militare.
Così “La guerra è diventata il passe-partout per ogni crisi”.
“Quando ci dicono che questa guerra non finirà mai, forse è un modo per dirci: d’ora in poi se vorrete preservare le vostre isole di benessere, sappiate che vi dovete difendere con le armi da tutto il resto del mondo.
Allora è chiaro che la guerra non serve per battere il terrorismo. Se la guerra viene elevata a strumento universale, c’è una discriminante: i poveri non possono farla: solo quelli che sono potenti e armati possono fare la guerra. E gli altri? A loro viene lasciato il terrorismo : il ‘nuovo terrorismo’ perché c’è sempre stato; l’attuale, che mette in scacco il mondo, è la conseguenza diretta, speculare, del processo che in questi dieci anni è arrivato a fare della guerra lo strumento universale del governo del mondo. Questa è la situazione contro cui dobbiamo resistere”.
“In questi tre gridi: Silete theologi, Silete jureconsulti, Silete sociologi, c’è la parabola della modernità, e la vedo riassunta nel corso delle tre guerre dell’ultimo decennio: nel ’91 l’opinione pubblica era contro la guerra: c’era ancora un’etica della pace, le religioni si erano pronunciate, Giovanni Paolo II aveva fatto delle straordinarie affermazioni contro questa guerra. In quel momento ci dissero: Silete theologi : state zitti, voi che vi appellate ai valori etici, religiosi, di fede; sono i giuristi che devono decidere. E cercarono di mostrare che era una guerra per il diritto internazionale, e fecero in modo che l’Onu vi fosse implicata.
Nella guerra della Iugoslavia non si fa appello ai giuristi. Sono messi a tacere, la guerra è già completamente fuori dal diritto: dall’ordine dell’Onu si è passati a quello della Nato, che ha lasciato la sua natura difensiva per diventare una struttura militare d’intervento pronta all’uso per intervenire in qualsiasi contesto in cui fosse necessario. Viene consapevolmente abrogato tutto il diritto umanitario di guerra, si fa la guerra senza tener conto dei protocollo di Ginevra. Si va già su un piano in cui neanche i giuristi possono parlare.
Adesso si arriva a dire: Silete sociologi . Nella società moderna la sociologia è la scienza della società, analizza e cerca le ragioni delle cose. Imporre il silenzio ai sociologi vuol dire mettere a tacere la conoscenza, la ragione, chi cerca di capire come va il mondo. Ecco il senso della vicenda che stiamo vivendo: le fedi sono messe a tacere; il diritto è esautorato; anche la ricerca di capire le cause degli avvenimenti non deve più parlare. L’unica parola resta alla guerra ”.
“Questa è la situazione contro cui dobbiamo resistere”!
Possiamo ancora essere utili? Per un agire responsabile
In estrema sintesi indichiamo alcuni tracciati.
• “Pensare e agire pensando alla prossima generazione, ed essere contemporaneamente pronti ad andarcene ogni giorno, senza paura e preoccupazione”.
“L’essenza dell’ottimismo non è guardare al di là della situazione presente, ma una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tener alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé
… Può darsi che domani spunti l’alba dell’ultimo giorno: allora, non prima, noi interromperemo volentieri il lavoro per un futuro migliore” (Resistenza e resa, pp.68-69).
Alle affermazioni che erano arrivate a dire dopo l’89: “la storia è finita e siamo stati noi a portarla a compimento” c’è da rispondere: “non solo un altro mondo è possibile, ma è doveroso lottare per costruirlo”.
La pretesa di chiudere la storia coincide con l’impossibile tentativo di soffocare per sempre l’ultimum .
• Il capitalismo che appare sempre più selvaggio anche negli stati sviluppati non è né può essere universale. È inevitabile, nella sua logica e nelle dinamiche messe in atto con diabolica coerenza, che una parte grande di umanità continui a venir esclusa dalle risorse che appartengono a tutti, e quindi dalla vita, che è un bene di ciascuno. La globalizzazione come si tenta di realizzarla ed il ricorso alla guerra come fatto organico sono in rotta di collisione con i contenuti di giustizia dell’ultimum e con il divieto di uccidere. Il cristianesimo nell’abbraccio mortale dell’occidente arrischia lo svuotamento totale e la morte. Questo “occidente cristiano appare come la negazione della fraternità e della giustizia.
• “I punti oscuri, le macchie nere nello splendore della Chiesa, sono i tradimenti della giustizia ricoperti e nascosti sotto i drappeggiamenti della sacralità. Oggi bisogna riprendere l’equazione: il santo è il giusto e, coscienti che nell’uomo la giustizia non può mai coincidere con l’essere umano, si soccorra la definizione dinamica delle beatitudini, affamati e assetati di giustizia ”.“Per me è chiaro che oggi ogni cristiano deve assumere la colpevolezza dell’Occidente diventato il centro di comando della morte e, partendo dalla coscienza di essere colpevole, costruire la sua esistenza. Perché siamo colpevoli, proprio in quanto religiosi, per aver usato lo spazio del sacro, che la Chiesa ha rifornito abbondantemente, come fuga dalla giustizia”.
Parlando dell’Italia: che dire dei piatti di lenticchie che la lobby ecclesiastica pretende ed ottiene in Italia (scuola privata, assunzione degli insegnanti di religione e dei cappellani, finanziamento oratori, spazi televisivi…)?
Chiaramente non vi è nulla di gratuito (timeo danaos et dona ferentes).
• Responsabili del “pezzo di Dio” che abita in noi e della sua custodia.
Mio Dio sono tempi tanto angosciosi … Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali, ma anch’esse fanno parte della vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare noi responsabili. E quasi ad ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi”.
• L’ ultimum è la chiamata a dare senso al mondo riscattandolo dalla maledizione della vanità e corruzione, cioè dall’utilizzare le sue risorse contro gli esseri umani, per la distruzione della loro vita.
“Tutto l’universo aspetta il momento in cui Dio mostrerà il vero volto dei suoi figli. Il creato è stato condannato a non aver senso, non perché l’abbia voluto, ma a causa di chi ve l’ha trascinato. Vi è però una speranza: anch’esso sarà liberato dal potere della corruzione per partecipare alla libertà e alla gloria dei figli di Dio. Noi sappiamo che fino a ora tutto il creato soffre e geme come una donna che partorisce. E non soltanto il creato, ma anche noi, che abbiamo già le primizie dello Spirito, soffriamo in noi stessi perché aspettiamo che Dio, liberandoci totalmente, manifesti che siamo suoi figli” (Rom. 8, 19-23).
Due sguardi sulla nostra vita di PO
Ci sembra utile richiamare due modi o sguardi interpretativi per discernere il senso della nostra storia ed anche l’attualità del nostro vivere. Se vogliamo sono due interpretazioni estreme, tra le quali è possibile collocare delle varianti. Esse ci aiutano a chiarire la nostra posizione personale anche in vista dello scambio che stiamo attuando. Per descriverle utilizzo dei testi: due comparsi nel numero 0 della nostra Rivista all’inizio del 1987 e uno che verrà pubblicato nel prossimo quaderno che raccoglierà i contributi di questo incontro.
Inizio da quest’ultimo. Gianni Chiesa di Bergamo scrive:
“Quella dei PO è una storia conosciuta e ampiamente raccontata dalla rivista Pretioperai; non c’è più nulla da aggiungere, credo.
Una storia che da alcuni anni ha esaurito la sua spinta propulsiva e la capacità creativa.
Quanto è stato vissuto rimane ‘dono di grazia’ per i singoli PO, non essendo riuscito ad andare oltre la sfera personale e del movimento e non avendo assunto una qualche dimensione e misura ecclesiale, rischia di ripiegarsi su se stesso. È stato questo un punto centrale della discussione che ha diviso e non poche volte contrapposto i PO.
Personalmente da anni ritengo esaurito il movimento dei Pretioperai italiani e condivido l’analisi che con dolcezza mi hanno sbattuto in faccia alcuni amici non credenti, analisi che ripropongo all’attenzione della rivista: ‘Ogni movimento quando è passato dovrebbe aver individuato gli elementi da istituzionalizzare , distinguendoli da quelli coreografici che devono finire con il movimento stesso. Chi non fa questa distinzione e vuole conservare tutto o rigetta tutto – che è la stessa cosa –, compie un errore storico e tradisce, nel momento in cui snatura, gli elementi di innovazione, trasformandoli in conservazione. Gli amici hanno aggiunto anche: ‘spesso, chi fa questo, paga di persona in quanto dilatando artificiosamente la teoria che vuole giustificare si pone in una situazione di pensiero patologico’.
Non ci è dato sapere se il ‘seme’ gettato con passione e generosità prima o poi fruttificherà, o sarà ripreso da altri secondo modalità che solo lo Spirito conosce”.
Gli altri due testi esprimono uno sguardo diverso e rappresentano la linea di fondo alla quale si è sempre ispirato il lavoro della rivista e soprattutto ispirano tuttora il cammino di molti di noi.
Il primo è di don Sirio, quello che apre il n. 0 della Rivista che lui aveva lanciato come ipotesi di lavoro nel convegno di Firenze. In parte lo abbiamo riportato nella lettera di convocazione. Personalmente l’ho sempre interpretato come un suo testamento:
“Quando si è posto mano alla pazzia la razionalità più consigliabile è cercare di essere pazzi del tutto… Perché può avvenire che l’Amore (cioè la vera ragion d’essere della propria vita, l’unica appassionante spiegazione del proprio destino) sia tutto nel rimanere…” (Bollettino di collegamento dei Pretioperai n. 0, pp. 3-5).
Il secondo è di Gianni Tognoni ed è stato indirizzato ai PO lombardi.
“1. Essere preti-operai significa condividere la situazione di tutti coloro che, nella loro microstoria, sono portatori di un’idea molto grande, tale da sfidare le regole della macro-storia.
La scelta che si fa dentro, non da un punto di vista razionale, ma come un bivio istintivo della conoscenza (o della stanchezza), è quella tra vivere questo stato di sproporzione o come ‘minoranza-lievito’ o come ‘pretesa’.
• la ‘minoranza-lievito’ è quella che trova in sé la giustificazione profonda, naturale, totale, di essere quello che si è;
• la ‘pretesa’ è quella che, in un modo o nell’altro, dipende dal riconoscimento esterno, da una istanza non necessariamente identificata, per poter vivere con pienezza di significato.
2. Essere portatori – nella microstoria – di un’idea grande, coincide con l’essere membri e nodi di un popolo che ha come caratteristica quella dell’esilio , e perciò della nostalgia…
3. Anche se li rimangia, la storia sarebbe deserta senza questi esiliati portatori di nostalgia .
Perché essi dicono la storia che vorremmo vivere. Un’altra non ci interesserebbe.
Quando riconosciamo, nella storia-grande, le persone che ci dicono qualcosa è come se tracciassimo la mappa di quel popolo che vorremmo essere. È come se raccontassimo o ci accorgessimo di una storia del nostro sguardo: noi siamo capaci di vedere solo con quegli occhi.
Anche se, a volte, vien voglia di chiuderli, o di desiderare di avere uno sguardo diverso.
4. Questo sguardo-necessario, che ci portiamo dentro, ci fa vedere, soprattutto e ripetitivamente le bugie della macrostoria.
Queste bugie sono molto concrete: sono le protagoniste del quotidiano. Sono molto normali, al punto che rendono difficile continuare a credere che ci sia spazio per i portatori di nostalgia. Più ancora: che abbia senso avere nostalgia. Addirittura: che sia la nostalgia ad essere, forse, una cosa falsa.
5. La macrostoria minaccia i portatori di nostalgia di ‘dissociazione’.
Di essere non solo i perdenti, ma coloro che hanno torto, che non hanno senso.
L’utopia che non diventa più un futuro, che emerge in un posto e in un tempo che non si sa, ma che in ogni modo ha un posto e un tempo certi, anche se non identificabili nella storia dell’amore dell’uomo.
L’utopia che coincide con il significato letterale: il non-luogo. Il miraggio. Il dubbio della follia.
Perché si è soli a ripetere che la nostalgia è il vero rivelatore della storia dell’uomo. Gli altri – gli Alberoni, le chiese o le istituzioni – dicono con sempre più normalità di sapere il dove va la realtà, e come si creano gli equilibri vivibili”. ( ibidem pp. 65-69).
Una sola annotazione: nei tre testi si ricorre ad una terminologia psichiatrica:
“situazione di pensiero patologico”;
“pazzia come razionalità più consigliabile”;
“minaccia della dissociazione… dubbio della follia”.
Nel primo caso si individua una situazione da fuggire perché è un avvitamento su se stessi; negli altri due testi, invece, viene indicata come “permanenza e fedeltà” (Sirio)
o come “nostalgia” che rivela il senso vero della storia e quindi come storia che si vuole vivere sotto la sua guida perché ormai si è capaci di vedere le cose solo con quegli occhi (Tognoni).
Per concludere
Ultimum e follia è un accostamento che ha antiche e nobili ascendenze. Ci basti il riferimento a 1 Cor. 1,25:
“la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini”.
