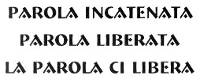
Bergamo, 27 aprile 2013 / Introduzione
Il titolo scelto per questo Convegno – Parola incatenata, Parola liberata, la Parola ci libera – pone al centro della nostra riflessione quella Parola attestata nelle Scritture, la cui riscoperta costituisce, a nostro giudizio, il cuore dell’evento conciliare. La Costituzione dogmatica Dei Verbum riposiziona la chiesa cattolica “sotto la Parola”, e non più “sopra”. La lunga stagione dell’esilio della Parola aveva determinato una figura di cristianesimo che riteneva sorpassate le Scritture. Come emerge da questa descrizione fatta nel 1949: “Quante volte si sente l’osservazione: ‘Leggere la Bibbia? Ma è un libro protestante!’, oppure: ‘E’ proibito! E’ all’Indice!’. Alle volte, persino sacerdoti zelanti e religiose ben intenzionate sconsigliano di leggere la Bibbia completa, soprattutto il Vecchio Testamento: ‘Perdereste la fede; è pieno di cattivi esempi; e poi, è proibito!’. Senza arrivare a tal punto, la grande maggioranza si accontenta di rispondere: ‘Ma a che pro? Attraverso l’insegnamento della Chiesa non sappiamo forse tutto ciò che dobbiamo credere e fare? Il Vangelo non ha abolito forse la Legge? Tutto ciò è sorpassato. E tra la Storia sacra, il catechismo e le prediche ne sappiamo abbastanza’” (C. Charlier).
La scelta di rimettersi in ascolto della Parola è stata la mossa decisiva stabilita dal Vaticano II. Il documento della Dei Verbum, rimettendo la Parola al centro della vita della chiesa, dopo secoli di digiuno, ha “inaugurato un’epoca nuova, dalle conseguenze imprevedibili” (Y. Congar).
E tuttavia, più che la commemorazione di quell’ora storica per la chiesa cattolica, sentiamo l’esigenza di riflettere più a fondo su cosa significhi essere chiesa “sotto la Parola”. Del resto, “la Dei Verbum non ha risolto tutti i problemi relativi all’uso delle Scritture e non è riuscita a trarre fino in fondo le conseguenze pastorali della propria impostazione teologica. Proprio per questo, la costituzione conciliare non costituisce un monumento da contemplare, quanto piuttosto uno strumento di lavoro ancora attuale” (L. Mazzinghi).
L’esilio non è terminato col Vaticano II. Anni dopo, Ernesto Balducci osservava: «noi siamo ancora i cristiani della parola incatenata. Le catene che abbiamo costruito sono fatte con metalli preziosi. La parola di Dio l’abbiamo chiusa in scrigni di perfetta fattura, con le perle della filosofia greca, con cinture metalliche del diritto romano».
Infatti, se è giusto leggere il Concilio come evento epocale, che ha posto una cesura rispetto al passato (fine della cristianità, dell’era costantiniana…), sarebbe ingenuo pensare che una nuova forma di cristianesimo sorga di colpo. G. Routhier suggerisce di leggere il “post-concilio come un periodo di tirocinio non ancor terminato, dentro il quale una nuova figura di cattolicesimo tenta di istituirsi” (e aggiunge: “questo processo di istituzione di un nuovo tipo o di una nuova figura di cattolicesimo, ovviamente, non è senza periodi di avanzamento e di regressione, né senza tensioni e contrapposizioni”). Dunque, la nostra riflessione si colloca in questo tempo incerto di apprendistato; un tempo di “crisi” in senso teologico, di scelte e decisioni evangeliche.
Il vaticano II ha rappresentato “l’impresa di tutta una chiesa volta a comprendere il vangelo nel proprio momento storico… operando una reinterpretazione globale della sostanza viva del vangelo nel proprio tempo” (G. Ruggieri).
L’aspetto innovativo dell’evento conciliare è dato proprio dall’attenzione alla storia. La Dei Verbum esprime questa ermeneutica storica fin dal suo incipit (un testo che funziona come introduzione a tutto il Concilio e che inizia così: “In religioso ascolto della Parola di Dio…”), non separando la rivelazione dal suo ascolto, introducendo così la storia stessa come elemento costitutivo dell’autocomunicazione di Dio. Prendendo le distanza dal mantra di una chiesa che non può cambiare, Il Vaticano II costituisce un nuovo inizio, in obbedienza alla Parola che domanda conversione.
D. Bonhoeffer parlava di una necessaria rinascita, a partire dalla Parola: “Nelle parole e nei gesti della tradizione intuiamo qualcosa di totalmente nuovo e di sconvolgente, senza tuttavia riuscire ad afferrarlo e a esprimerlo. La colpa è nostra. La nostra Chiesa, che in questi anni ha lottato solo per la propria sopravvivenza, quasi essa fosse il suo proprio fine, è incapace di farsi portatrice della Parola riconciliatrice e redentrice per gli uomini e per il mondo. Ed è per questo che le parole antiche devono svigorirsi e ammutolire e il nostro essere cristiani si riduce oggi a due cose: pregare e operare tra gli uomini secondo giustizia. Ogni pensiero, parola, organizzazione nelle cose del cristianesimo, dovrà rinascere da questa preghiera e da questa azione”.
L’ascolto della Parola, al cui cuore sta il ristabilimento della giustizia del Regno, ci induce a domandarci, di nuovo, “con quale cristianesimo” abitare questa nostra terra.
L’esperienza dei pretioperai si colloca in questo quadro. Anche noi abbiamo provato a metterci in ascolto di questa Parola, letta non tanto come parola religiosa quanto come paradigma teologico-politico, che ha nella storia, e non nel tempio, il suo orizzonte ultimo. Ed è proprio sul nodo del rapporto tra Parola e storia che intendiamo interrogarci.
A partire dallo stupore per un Dio che parla. Molti di noi hanno sperimentato la tenebra e l’abisso e, nonostante tutto, continuiamo a credere che in questo nostro mondo risuoni una Parola divina. Una Parola che suscita la passione del Regno, ovvero del mondo come Dio lo vuole; che ne tiene desta l’attesa impaziente (Rom 8); e che chiama a precise assunzioni di responsabilità nella città terrena. La Parola che ci interpella è ispirata ed ispirante: non definisce dogmi ma sollecita il discernimento del sogno di Dio per il nostro tempo. Ancora con le parole di Bonhoeffer: “la volontà di Dio non è un sistema di norme stabilito una volta per tutte, ma è sempre nuova e diversa nelle diverse situazioni, perciò bisogna sempre di nuovo cercare quale essa sia. Il cuore, la ragione, l’osservazione e l’esperienza devono tutti partecipare a questa ricerca”.
Questo convegno intende essere un piccolo laboratorio di ascolto della Parola nella storia per comprendere meglio cosa significhi, oggi, essere discepoli di Colui che ha promesso il Regno ai poveri.
Ci aiuteranno gli interventi di Piero Stefani (“Il primato della Parola in tempi difficili”) e di Antonietta Potente (La Parola nel deserto del neoliberismo”).
Angelo Reginato
