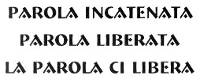
Bergamo, 27 aprile 2013 / gli interventi (7)
La condizione di vita che ha avuto una decisa sterzata per la morte così repentina dell’amico con cui condividevo molte cose da anni, mi sta confermando come la traccia della mia vita di prete si sia svolta intorno alla parola “obbedienza”.
Quanto, se e come questa parola sia “incatenata” o “liberata” nella mia storia personale, giudicatelo voi.
Sono stato ordinato prete della diocesi di Lucca nel giugno del 1966. Prima destinazione Roma, a “completare gli studi” con i gradi accademici, come si diceva allora. Tre anni di frequenza delle università romane con due licenze di insegnamento, una in teologia dogmatica, l’altra in teologia morale.
Avevo terminato quasi del tutto le frequenze obbligatorie e per la tesi di dottorato non era necessario rimanere nella capitale. A luglio ero di nuovo a Lucca, ma non tornai a casa dai miei. Il cordone ombelicale era rotto dopo quasi 10 anni di vita di seminario a Lucca e di collegio a Roma. Chiesi ospitalità a don Sirio Politi e alla comunità di Bicchio, vicino Viareggio. Mi sentivo bene con loro, mi avevano aiutato (più con l’esempio che con le parole) a superare una crisi di rigetto dopo due anni di seminario. Ma per me allora, non rappresentavano un punto di arrivo. Erano amici che godevano della mia più ampia fiducia e non mettevano in discussione il fatto che io avessi la mia strada da fare. Mi prendevano bonariamente in giro, loro, gente usa al lavoro manuale, perché io dovevo mantenere le mani lisce e non callose per poter voltare le sottili pagine dei libri in carta “india” che andavano in voga allora. E avviarmi a una vita di studioso.
Da via della Bozzana 50 – l’indirizzo della comunità – scrissi al vescovo che aspettavo lì la lettera di destinazione che allora costituiva la forma di comunicazione dei nuovi incarichi in diocesi ai primi di settembre.
Ho atteso invano la lettera della mia prima destinazione. Ebbi solo vaghe non-spiegazioni. Solo tre anni dopo il vescovo in un incontro con la comunità sollevò il problema della mia mancanza di ogni giustificativo giuridico per la mia permanenza al Bicchio. Disse che mi avrebbe nominato parroco di Bicchio con don Rolando parroco moderatore, ma la cosa rimase lì e non ebbe mai attuazione.
Nel frattempo continuavo a frequentare gli incontri dei preti, venivo richiesto per le feste di Natale e di Pasqua dai parroci (allora pochi) che avevano più di una parrocchia e di appoggio per temporanee sostituzioni. Non mi rifiutavo a queste richieste e chi richiedeva la mia presenza sapeva che ero solito svolgere il mio compito con semplicità e senza strascichi di sorta.
Passarono 16 anni dalla mia ordinazione prima di avere il primo incarico in diocesi. Nel frattempo avevo iniziato a lavorare. Con fatica perché il mio apprendistato partiva da zero. Da Bicchio, con don Sirio, don Beppe Socci e Maria Grazia, passai alla Chiesetta del Porto in Viareggio. Avevamo iniziato l’esperienza del “capannone” nella Darsena e, dopo sette anni di lavoro dipendente, trovai difficoltà nel mantenere il posto di lavoro e si aprì per me la strada dell’artigianato.
Una sera di inverno del 1981, bussarono alla porta della Chiesetta tre uomini. Andai ad aprire e questi chiesero di parlare. Sapevano che lì alla Chiesetta c’erano tre preti. Venivano a nome di un comitato di un paese sulle prime pendici delle Apuane. Avevano avuto una spiacevole esperienza con l’ultimo parroco e il vescovo aveva proposto loro un prete che non sembrava diverso dal precedente. Alle loro rimostranze il vescovo seccato li aveva congedati dicendo: “allora cercatevelo voi, un prete alla vostra misura!”
Alcuni paesani lavoravano nei cantieri in Darsena e ci conoscevano. Di tre, almeno uno ci dirà di sì, avevano pensato. E poi non sembrano assetati di quattrini come pareva loro fossero stati i due precedenti.
Don Sirio li ascoltò con me e ci salutammo con la promessa di far sapere loro una risposta all’indomani, dopo averne parlato con don Beppe.
Quella sera a cena Sirio si espresse brevemente: “se fosse stato il vescovo a chiedercelo, avremmo anche potuto cercare di rifiutare non essendo il ministero pastorale parrocchiale quello che ci identificava come preti, ma vox populi vox Dei e allora non ci resta che accettare!”.
Don Beppe era appena tornato alla Chiesetta dopo dieci anni di vita spesa a crescere i quattro bambini che aveva raccolto da una storia di sangue e di galera. I genitori, tornati in libertà, ripresero i figli con loro e Beppe poteva occuparsi di quella parrocchia in un percorso di re-inserimento necessario per lui dopo un’esperienza di totale dedizione. Ma, come era naturale per noi dopo anni di vita insieme, l’impegno sarebbe stato comune.
E infatti il vescovo, informato dalla gente del paese, accettò la proposta ma si rifiutò di nominare parroco don Beppe perché arrivato in diocesi da Firenze senza permesso ufficiale (era ancora in vigore la vecchia forma di “incardinazione”). Così io chiesi al vescovo che nominasse me e lui non obiettò niente. Per la prima volta dal 1966, all’inizio del 1982, ebbi il primo incarico da prete. E accadde nel modo appena descritto.
Detto per inciso, siamo stati responsabili di quella parrocchia dal 1982 per 16 anni. E se ancora oggi capitate in quel paese e chiedete chi fu il parroco in quegli anni, ci sarà chi dirà don Beppe e chi don Luigi perché per noi non faceva davvero differenza: chi c’era, in quel momento era il parroco e prendevamo le decisioni in un clima di piena fiducia e di corresponsabilità. Da uomini.
Con lo stesso spirito accettammo la responsabilità della parrocchia della Darsena nel 1988. Questa volta il vescovo non ebbe difficoltà ad affidare a don Beppe l’incarico di parroco. E Beppe è stato parroco amato fino alla sua improvvisa morte nel 1998. Io lo sostituivo e lo integravo: rimasi in continuità con lui per sei anni incaricato della parrocchia.
Ma non abbandonai mai la Chiesetta del Porto. Nemmeno, credo, nello spirito. E, rimasto ormai solo, credetti di obbedire ad una storia più grande di me lasciando la parrocchia e mettendomi al servizio dell’ascolto di ogni voce che risuonava per le strade della città, a cominciare da quelle più deboli e meno qualificate.
Il numero complessivo dei preti in diocesi (ma non solo) stava diminuendo a vista d’occhio e l’età media rapidamente si stava innalzando. Tanto valeva non cercare ad ogni costo di tappare i buchi, ma di porre le mie poche energie al servizio di modalità meno irrigidite dalle tradizioni del servizio presbiterale. Lo feci senza rotture di nessuna sorta: rimanevo oltretutto nel territorio parrocchiale in un modo sereno e senza intralci né doppioni con il nuovo parroco.
In quegli anni assunsi il compito di “cucire” strappi provocati dall’abbandono o dalla morte di parroci nella zona di Viareggio e rimasi in ascolto dei bisogni della chiesa locale dando risposte secondo il mio modo di essere, assumendomi responsabilità di gestione sia pure temporanea con un minimo di “progetto”, senza mai prestarmi alla semplice esecuzione di riti e sacramenti per tappare buchi.
Finché, all’inizio di quest’anno, accompagnai don Beppe Giordano in ospedale. Collaborando in amicizia e corresponsabilità con lui, sia pure residente nei pressi di Lucca, era normale che lo sostituissi sia in parrocchia che nel servizio di cappellano presso il carcere di Lucca. Così feci, nella speranza di una sua sollecita guarigione. Rapidamente si fece strada per lui una malattia invincibile. Morì dopo nemmeno due mesi.
Adesso sono cappellano delle carceri e amministratore parrocchiale di S. Pietro a Vico, in un territorio di circa 4.000 abitanti. Continuo a vivere a Viareggio, alla Chiesetta del Porto (ormai son più di 40 anni), e giro senza soluzione di continuità tra la Chiesetta (e la presenza a Viareggio), il carcere di Lucca e la parrocchia di S. Pietro a Vico. Il vescovo mi ha ringraziato e ha aderito senza indugio alla mia richiesta di nomina sia come cappellano delle carceri che come amministratore parrocchiale e legale rappresentante. Quando assumo un compito lo voglio fare in piena responsabilità.
Da meno di un mese un giovane prete di Lucca si è avvicinato al carcere e mi sta affiancando. Se tutto va bene alla fine dell’anno potrà esserci un avvicendamento nella continuità. Così potrò cominciare a guardarmi intorno anche per la parrocchia.
Quando voglio darmi un po’ di importanza, tra me e me, mi raffiguro come un cincinnato che scende in campo nell’emergenza, ma il suo proposito è tornare alla cura dei campi, all’umiltà della terra nella quotidianità.
A volte qualcuno osserva che per tutta la mia vita di prete ho sempre fatto quello che ho voluto. Non posso davvero dargli torto. Mi chiedo però se in queste vicende sempre di poco conto che connotano il mio curriculum, io abbia ignorato del tutto l’obbedienza.
O l’abbia da sempre vissuta.
Luigi Sonnenfeld
