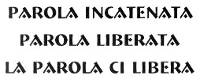
Bergamo, 27 aprile 2013 / Le relazioni (2)
Alcune premesse
In questo titolo ci sono tre elementi importanti dell’esperienza cristiana: la parola, il deserto e il contesto (in questo caso il neoliberalismo). Ma mettere insieme questi tre elementi potrebbe avere un rischio: essere un po’ retorico.
Retorico perché, ancora una volta, tutto potrebbe restare sul piano del discorso, tra ricerca di colpevoli e critiche sentenze sulla realtà. In oltre, Parola e deserto, nella tradizione cristiana hanno tutta una loro valenza simbolica che non ha mai avuto un senso negativo e che ha evocato sempre momenti profondi e trasformativi di donne e uomini in ricerca. Per cui abbinarli al neoliberalismo, certamente significa volerci portare a una caleidoscopica rilettura.
La Parola, sia essa essenzialità e responsabilità del linguaggio umano o, ancor più, veicolo del divino perché l’umano capisca, nel neoliberalismo, non ha molto posto. Almeno che non si pensi a una parola ambiziosa e bugiarda e dunque irresponsabile, utilizzata solo per sorreggere il mercato e l’egocentrismo di pochi, insieme all’immagine. D’altra parte, lo spazio-tempo del neoliberalismo, non è il deserto, ma le mega città, i mega mercati o super-mercati, la finanza e le sue succursali: le banche. Dunque, usare l’immagine del deserto, a mio avviso è molto anacronistico, e per questo rischia la retorica.
Ma dovendo cercare un senso a questa triade, provo a dire qualcosa, partendo dal deserto e lasciando la Parola all’ultima parte della mia riflessione, in quanto archè originario che resta senza tempo cronologico e che per questo ha una sua forza, una sua libertà e una sua strategia di cura che a volte ci sovrastano e non capiamo.
Gli altri due elementi invece, sono molto legati al tempo cronologico, evocano esperienze, momenti storici di uno o più popoli, ma anche di individui, indicando non solo avvenimenti o luoghi, ma anche mentalità, sensazioni e trame molto esistenziali.
Il deserto
Lungo il corso della storia sono stati molto pochi i popoli identificati con il deserto, per alcuni il deserto è stato solo un faticoso transito da cui uscirne al più presto. Normalmente infatti, il deserto si attraversa ma non si abita, un po’ come il mare. Dire questo, a mio avviso, ci può già aiutare a capire meglio, cosa vogliamo dire e anche cosa ci sta a cuore.
Nelle geografie terrestri e in quelle umane, saranno sempre molto poche, le persone che rimangono fedeli al deserto. Forse solo chi ha le sue stesse radici; forse chi sa muoversi, pur essendo un abitante, come un nomade e pellegrino. Un luogo, in un certo senso inospitale, con una biodiversità occulta, almeno a prima vista, che costringe chi lo abita a spostarsi con frequenza per ricercare cibo e acqua. In un deserto la “visita” di qualcuno è così preziosa, che rende i popoli che vi risiedono molto ospitali. L’arrivo di qualcuno infatti, è così prezioso come preziose sono l’acqua e il cibo, che va ricercato e mantenuto con strategie obbedienti ai ritmi dell’ambiente circostante.
Nel simbolismo biblico il deserto è luogo di faticose trasformazioni, passaggio obbligato per cambiare qualcosa della propria storia. In alcuni casi il deserto fa parte di quell’immaginario del popolo in cerca di una nuova creazione; è premessa di un mondo nuovo ma anche di un modo nuovo di essere. Paradossalmente, nel deserto si coltiva qualcosa, che assomiglia e ha lo stesso gusto delle cose belle e buone: il tempo della giustizia: abbondanza, fertilità, fonti d’acqua, ecc. pur restando un clima austero, in cui la grande esperienza è quella della ricerca dell’Assenza-Assente.
Mi domando allora se sia davvero possibile, fare un paragone, cercare delle similitudini tra il simbolismo del deserto e il neoliberalismo.
Neoliberalismo
Il neoliberalismo non ha come luogo propizio il deserto, né appartiene alla sua cosmovisione. Il neoliberalismo infatti è tremendamente abitato, riempito, strapieno, grasso: di cose, di persone, di parole, di false istituzionalizzazioni associative, per far credere all’essere che non è solo, non è abbandonato. Il luogo del neoliberalismo non è un mercatino, magari sporadico, ma un super-mercato. Sono le banche, è il mondo della finanza, dell’imbroglio istituzionalizzato, della difesa gli uni dagli altri, contrariamente all’accoglienza del nomadismo del deserto.
Si capisce allora perché mi resta difficile parlare del “deserto del neoliberalismo”, perché queste due immagini e, allo stesso tempo, realtà, sono troppo diverse, sono troppo distanti. E se qualche abitante dei molteplici deserti del mondo, quelli di sabbia, di ghiaccio, di sale o di terra, ci sentisse parlare così, si sentirebbe offeso, perché la loro vita ha poco a che vedere con lo spreco, l’accumulo ecc.
Ma, allo stesso tempo, capisco anche il senso profondo di questa immagine, che lega deserto e neoliberalismo. Infatti nel mondo neoliberale e nella mentalità che lo sostiene nonostante tutto, non ci si accorge che abbiamo sospinto milioni e milioni di persone a vivere come nomadi, come pellegrini in cerca di sopravvivenza; stranieri di passaggio, costretti solo a vendere e a vendersi, magari per un paio di sandali, come gridava il profeta Amos. Il neoliberalismo, ha creato in effetti situazioni desertiche, sia sul Pianeta, su Gaia, sia negli animi di tante donne e uomini, giovani, anziani, bambini, che camminano legati al filo della speranza.
E allora viene la Parola, primo elemento nel titolo, che ho lasciato appositamente, come ultimo, in questa riflessione.
Voce di chi grida nel deserto … preparate
Forse, il nodo tra queste due contrastanti e paradossali realtà, è proprio la Parola, non come facoltà umana, ma come Archè originario, un Principio senza principio, lasciata comunque nei venti e nei vortici delle realtà storiche, individuali e collettive.
Questa Parola fin dal Principio, senza sapere bene di che principio si tratta: metafisico, biologico, energetico, ecc. Questa Parola gratuita, lasciata più volte nel deserto perché qualcuno la raccolga, la segua, se ne innamori. Questa Parola che non può essere abusata, perché non è la Parola della magia, del proselitismo o della vittoria. Questa Parola infatti non può solo criticare, perché è anche lettura autocritica di chi la riconosce; questa Parola non comanda ma suscita. Certamente, questa Parola strappa arroganza, ma cura e ricompone lo stelo sottile di certe situazioni e ravviva lo stoppino fumigante nelle disperazioni umane.
Probabilmente, questo Archè originario ha come spazio il silenzio trasformativo e il segreto, come il lavoro e il dramma del non lavoro; come la gioia dell’incontro e il dramma dell’esilio; come la gratuità e la resistenza, insomma, come l’osare per fede –secondo le parole di Dietrich Bonhoeffer-.
C’ è un racconto che ci viene dalla comunità di Luca, che evoca questo Archè.
Si tratta del testo che riguarda quello strano tempo che intercorre tra la morte di Gesù e la Resurrezione (cfr. Lc 23). Un tempo di transizione, tra sconcerto, stupore, silenzio, paura e allo stesso tempo fretta e attesa. Ci sono tre immagini che scorrono in questa narrazione: deposizione, preparazione dei profumi e tomba vuota. Con la descrizione fatta dalla comunità di Luca, è come se leggessimo i diversi sentimenti sul volto di chi ha vissuto quell’evento.
A mio avviso, i primi due quadri – deposizione e preparazione dei profumi- mostrano dei gesti di cura. In questo senso la Parola cura e si lascia curare. Il terzo quadro, quello della tomba vuota è il velo della resistenza e del silenzio. La Parola è silenziosa. Forse qui c’è qualcosa di molto simile all’immagine del deserto. Inizia il nomadismo e il gemito della ricerca: dove l’avete posto …
Che cosa può significare per noi tutto ciò? Ciascuno, certamente può fare la sua ermeneutica e la sua esegesi.
Personalmente ritrovo in questo insieme di atteggiamenti, gesti, sentimenti descritti nel capitolo 23 di Luca, il senso più profondo del cristianesimo che è la ricerca del Volto nei volti, dell’Assente nelle assenze, della Presenza nelle presenze, del Giusto nella liberazione e nella dignità di ciascuna e ciascuno. In questo quadro rileggo la nostra passione mistico-politica per la realtà; il rifiuto del potere e del trionfalismo, ma non solo rifiutare il potere ma anche non cercarlo mai più, nemmeno il “potere” della profezia, dell’essere i migliori.
Mi rendo conto che questo lo dico come donna, perché noi donne pur essendo profetesse, cioè, pur prendendoci cura della Parola, non siamo mai state riconosciute come le reali portatrici e curatrici delle disarmonie del mondo, anche se siamo noi a continuare a preparare i profumi nell’assenza.
Non dico questo con polemica, ma per ricordarvi che quello che voi avete fatto per tanti anni e che alcuni di voi continuano a fare, è più simile alla preparazione dei profumi che all’eco forte e potente di una voce.
Questa preparazione è ancora doverosa, perché la tomba è rimasta vuota, perché anche noi come le prime discepole e i primi discepoli, non sappiamo dove l’hanno portato e non cessiamo di cercarlo. Certamente non andremo nei palazzi dei re … o tra coloro avvolti in morbide vesti …
Antonietta Potente o.p.
