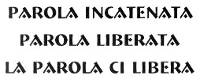
Bergamo, 27 aprile 2013 / Le relazioni (1)
1. Due icone bibliche
Traendo ispirazione da un procedere caro a Carlo Maria Martini, inizio con l’evocare due icone bibliche. La prima è incentrata più sulla parola da riscoprire, la seconda più sui tempi difficili. Peraltro le due componenti si richiamano a vicenda; anche perché si tratta di testi che rispondono, in maniera per alcuni versi antitetica, a una stessa situazione, legata alla vita del popolo d’Israele appena tornato dall’esilio babilonese. La prima icona è legata alla lettura pubblica della parola narrata nel capitolo otto del libro di Neemia (presterà però qualche attenzione anche ai due capitoli successivi). La seconda si soffermerà sul libro di Giona. Da questa duplice lettura si ricavano molti aspetti, compresa la chiusura di orizzonte di chi si trova al centro, opposta alle aperture che provengono dalle periferie.
I. Neemia
La lettura della Scrittura da cui prendiamo lo spunto è ambientata dopo il ritorno dall’esilio in Babilonia. Siamo a Gerusalemme, quando è già stato ricostruito, sia pure in maniera non ancora fastosa, il tempio. Tuttavia la scena è ambientata non nel luogo sacro, ma nello spazio profano della piazza che sta di fronte alla porta delle Acque. Questa collocazione consente che vi partecipi «tutto il popolo»; espressione che ritorna con frequenza nel brano. Essa rappresenta, per evocare un etimo debitore al greco e non già all’ebraico, una dimensione in senso proprio laicale. Il primo giorno del settimo mese Esdra portò il libro della Legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano in grado di intendere. Gli orecchi di tutto il popolo erano rivolti al libro della Torah. L’apertura del libro è contraddistinta da risonanze teofaniche (ma qui Dio è nascosto entro la parole): «si inchinarono e si prostrarono davanti al Signore con il volto a terra». I leviti lessero a sezioni spiegandone il significato davanti al popolo che stava in piedi. Il governatore Neemia disse al popolo che si trattava di un giorno di festa, tuttavia il popolo pianse quando ascoltò le parole della Torah. Segue l’invito a mangiare e bere e a rendere partecipe del pasto anche chi è privo di beni «giacché questo è giorno santo al Signore. Non rattristatevi perché la gioia del Signore è la vostra forza». Il secondo giorno, leggendo il libro della Legge, «trovarono scritto» che il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè che i figli d’Israele dimorassero in capanne durante la festa del settimo mese (cfr. Lv 23,33-36.39-43). Si diede allora disposizione perché ci si procurasse frasche e rami per costruire le capanne. «Dai tempi di Giosuè figlio di Nun fino a quel giorno non avevano mai fatto altrettanto. E l’esultanza fu grandissima. Celebrarono la festa per sette giorni; nell’ottavo giorno ci fu un’adunanza solenne così come prescritto» (Ne 8,17).
Come capitò all’epoca di Giosia (cfr. 2 Re 23,1-3), anche con Esdra il libro si presenta come qualcosa di trovato e come un testo che il trascorrere del tempo aveva fatto smarrire. Nei giorni di Giosia il «Libro dell’alleanza» fu rinvenuto nel tempio, all’epoca di Esdra la Torah (Pentateuco) fu proclamata a un popolo che non la comprendeva più. In essa si parlava di una festa non più celebrata da secoli. A prescindere da ogni legittimo impiego di tale riferimento in prospettiva storico-critica – i cui esiti ci porterebbero in tutt’altra direzione – conviene sottolineare come la lettura del libro sia sempre legata a una specie di perdita, scandita dall’esistenza di un nascondimento e da una non comprensione di parole antiche. La pubblica lettura del testo rappresenta la diuturna lotta contro il prevalere di un occultamento della parola. Si potrebbe affermare che l’«oggetto libro» rappresenta la distanza che ci separa dall’originario evento della rivelazione, mentre la pubblica lettura del testo costituisce il tentativo di recuperare e attualizzare la perduta forza delle origini.
È significativo constatare che la proclamazione della Scrittura avvenuta al tempo di Esdra è collegata al ripristino della festa delle Capanne (cfr. Dt 31,10-11). La lettura della Torah è legata sia al rinnovo dell’alleanza attraverso la parola udita nei propri orecchi sia alla festa delle Capanne volta a celebrare tanto la terra, nell’abbondanza del raccolto, quanto il ricordo del quarantennale soggiorno nel deserto. All’epoca di Esdra il pianto e l’esultanza del popolo espressero una simile economia fatta di ricchezza e povertà. La festa delle Capanne appare particolarmente predisposta a contraddistinguere la pubblica proclamazione di quanto è continuamente perso e ritrovato. Il Libro, infatti, è smarrito ogni volta che è riposto e lasciato chiuso; ed è ritrovato quando lo si legge, lo si ascolta e lo si mette in pratica. La proclamazione del testo può diventare una specie di effettivo atto di rinnovamento dell’alleanza. La lettura del Libro assume così inscindibilmente il duplice aspetto di quanto ci separa dalla pienezza della rivelazione e di quanto ci unisce alla voce uscita dal Sinai.
Alla luce del ritorno al tempo in cui fu stipulata l’alleanza tra Dio e il suo popolo, vanno lette anche le espressioni, volutamente eccessive, contenute nell’ottavo capitolo di Neemia. Esdra «aprì il Libro alla presenza di tutto il popolo (…) Esdra benedisse il Signore Dio grande, e tutto il popolo rispose “Amen! Amen!” elevando le mani (…) si prostrarono davanti al Signore con il volto a terra» (Ne 8,5-6). Le modalità di espressione, a cominciare dall’enfatico «tutto il popolo», tendono tutte a indicare l’esistenza di un’analogia con il giorno santo in cui fu stipulata l’alleanza del Sinai (cfr. Es 24,3; 34,10). La Torah diviene costantemente un libro che si può perdere e ritrovare facendo sì che la rivelazione passata torni a essere di “oggi”.
Il libro di Neemia fa seguire a questo un altro capitolo incentrato su una lunga preghiera che ripercorre, in tono penitenziale, l’intera storia d’Israele. Essa si chiude in tono minore alludendo al dominio persiano che, a causa delle colpe del popolo, pesa sui ritornati in Giudea: «Oggi, eccoci schiavi, e quanto alla terra concessa ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e i beni. Ecco in essa siamo schiavi. I suoi prodotti abbondanti sono per i re, che hai posto su di noi a causa dei nostri peccati…» (Ne 9,36-37).
A questo capitolo, in cui di fronte a Dio si dichiara il proprio peccato e la propria mancanza di libertà, ne segue un altro, di tutt’altra natura, che comincia con una rivendicazione di autonomia. I capi del popolo si impegnano reciprocamente a mettere in pratica la Legge di Dio stabilendo e firmando un patto. Qui non si tratta di un’alleanza (berit) che viene dal Signore ed è accolta dal popolo. Si è di fronte invece alla stipula di un patto (’amanah – la stessa radice di amen – ben reso dal latino foedus) (Ne 10,1.30) deciso e sottoscritto (c’è persino l’elenco dei firmatari) dai capi d’Israele e a cui aderisce anche il «resto del popolo». Tra i precetti che si trovano nella Legge data da Mosè si sottolineano in modo particolare il sabato e l’offerta per il tempio. Dalla lettura del patto però si ricava soprattutto l’impegno di «non dare le nostre figlie ai popoli della regione e non prendere le loro figlie per i nostri figli» (Ne 10,31). Questo patto orizzontale porta alla creazione di un’identità chiusa e ben distinta da quella degli «altri». La libera obbligazione qui sancita porta con sé una spinta alla separazione. Si tratta di un procedimento attestato anche nei capitoli 9 e 10 del libro di Esdra, incentrati sull’espulsione delle «le spose straniere» e dei loro figli, i quali, va detto, sono diventati tali proprio a causa dell’atto giuridico di espulsione. L’altra faccia dell’autonomia è la costruzione di un forte «noi» che si contrappone a «altri».
L’atto di cui si parla in Neemia 10 sembra, per più aspetti, un antico prototipo di un processo costituzionale. In ogni caso si tratta di una procedura più simile alla legislazione moderna (si pensi anche alle firme poste in calce) di quanto non lo siano le altre stipulazioni di alleanza di cui parla la Bibbia. Essa, perciò, corre il rischio di cadere nella stessa ambiguità insita negli ordinamenti giuridici contemporanei: «Se da una parte le costituzioni moderne esprimono un “basilare patto sociale” (…), esse non sono esenti da rischi. Infatti, come si legge nello stesso racconto di Ne 10,30, esse si configurano anche come “separazione” da coloro che rimangono all’esterno dell’associazione pattizia e non si impegnano nel patto. E la separazione può diventare esclusione» (M. Miegge «La Bibbia e il patto sociale» in «Bibbia e costituzione» a cura di G. Codrignani, Humanitas, n. 1, 2010, p. 14).
II. Giona
Il libro di Giona si propone di attestare che Dio è ovunque; Egli, perciò, si prende cura di tutti e non solo degli appartenenti al popolo d’Israele. Tuttavia, per conseguire questa meta, occorre passare attraverso molte svolte.
Il breve testo si apre con una chiamata rivolta al profeta ad alzarsi per andare a predicare contro Ninive, la grande, corrotta città posta a Oriente. Giona fugge dall’altra parte, verso Tarsis, nell’estremo Occidente. Il libro commenta tutto ciò dicendo che il proposito del profeta era di andare lontano «dal volto del Signore» (Gn 1,2.10). Ma è forse possibile, per un testo “universalistico” in cui si afferma che vi è un solo Dio per tutti, sottrarsi al volto del Signore? Forse che Dio abita un’unica terra ed è assente nelle periferie del mondo? Eppure Giona non sbaglia. In effetti ci si sottrae sempre dalla presenza del Signore quando si rifiuta il compito a cui si è stati chiamati. Non è questione di latitudine o di longitudine; si tratta di non assunzione della vocazione che ci è stata rivolta. Quando si dice «no» a quanto Dio ci domanda si stende un velo sul volto di chi ci interpella.
Per quale ragione il profeta si allontana da quel che gli è richiesto? Per rispondere alla domanda dobbiamo ripercorrere la vicenda del nostro profeta. Giona è chiamato a proclamare prossima una severa punizione riservata a una grande città. Egli si sottrae forse al compito perché teme di formulare minacce o, al contrario, lo fa perché paventa che esse non vengano attuate? L’autentico profeta annuncia la sventura nella speranza che essa non giunga. Quando la conversione e il mutamento di vita scongiurano la catastrofe, la parola profetica consegue il suo vero scopo. L’esempio paradigmatico di questo procedere è tratto proprio dal libro di Giona.
Il profeta, una volta ricondotto dalla sua iniziale fuga a predicare a Ninive, diede corso a una predicazione tutta posta all’insegna di un «fato enunciativo». Egli non dice: «se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo» (cfr. Lc 13,1-5); al contrario, afferma seccamente: «ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta» (Gn 3,3). La sua è una pura previsione che se fosse smentita lo consegnerebbe, secondo la sua opinione, al ruolo di falso profeta. La grande intuizione dei niniviti consistette nel non lasciarsi sgomentare dall’annuncio infausto. Ad esso si rispose con penitenza e digiuni. Il pentimento degli abitanti di Ninive trova corrispondenza in una misericordia divina che sembra falsificare quanto, in apparenza, predetto dal profeta. L’annuncio rivolto alle periferie del mondo non comporta solo che la parola del nostro Dio giunga anche a esse; significa di più, vale a dire che i «lontani» divengono in proprio protagonisti. Sono i niniviti a diventare soggetti attivi in grado, contro la lettera della parola profetica, di convertire Dio stesso facendo sì che si penta del male minacciato (Gn 3,10). Il più grande messaggio del libro di Giona sta forse proprio in ciò: gli «altri» sono diventati soggetti. In virtù dell’annuncio, i niniviti sono andati oltre l’annuncio.
Visto dalla parte di Dio, quanto è avvenuto è riassunto da un lapidario detto di Tommaso d’Aquino: «Egli muta decisione, ma non muta consiglio» (Sum Theol. q. 171, a. 6, 2um). La «dialettica della misericordia» esige appunto questa asimmetria in cui la lettera della profezia deve essere falsificata affinché se ne realizzi il senso più profondo. Giona cercò di sottrarsi alla chiamata proprio perché sapeva tutto ciò. Egli non voleva che gli «altri» diventassero protagonisti in grado di annullare la lettera della sua parola profetica. Prevedeva che Dio l’avrebbe condotto a vedere capovolte le certezze a cui era attaccato. Giona è chiamato a predicare il giudizio ed è consapevole che nel Signore prevale sempre la misericordia. Il profeta non sopporta questa contraddizione, a dirlo è lui stesso: «Signore non era questo quello che ti dicevo quando ero nella mia terra? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore e che si pente del male» (Gn 4,1-2). Il mutamento è dovuto alle opere di penitenza compiute dai niniviti. Così facendo essi diventano protagonisti di un nuovo modo di intendere Dio: le periferie diventano interpreti «autorizzati» della parola.
Dopo aver cercato di fuggire, Giona va a Ninive a cui annuncia la distruzione; la città è grande, per percorrerla occorrevano tre giorni di cammino, ma ne bastò uno per muovere gli abitanti alla conversione (Gn 3, 3-5). Quella prontezza è vissuta dal profeta come un ulteriore scacco. Alla fine Giona, seduto all’ombra del ricino, si rammarica di non poter assistere alla catastrofe. Quando, come ammonizione, fu privato della protezione vegetale, Dio rispose alle sue lagnanze, mostrandogli la forza della conversione (Gn 4,5-11). Dopo i niniviti e Dio, anche Giona è chiamato a convertirsi. Tuttavia il libro finisce in modo sospeso (non a caso termina con un punto interrogativo, sia pure posto a coronamento di una domanda retorica, ma che è tale per Dio, non per il profeta). Non ci è dato di sapere se il profeta che annunciò la distruzione e, con le sue parole, indusse alla conversione si sia a propria volta convertito. Ci è noto, solo, che gli abitanti di Ninive lo hanno fatto.
«Dio irrompe nella sua vita come un torrente. Lo invia a Ninive. Ninive è il simbolo di tutti i separati, i perduti, di tutte le periferie dell’umanità. Di tutti quelli che stanno fuori, lontano. Giona vide che il compito che gli si affidava era solo dire a tutti quegli uomini che le braccia di Dio erano ancora aperte, che la pazienza di Dio era lì e attendeva, per guarirli con il suo perdono e nutrirli con la sua tenerezza. Solo per questo Dio lo aveva inviato. Lo mandava a Ninive ma lui invece scappa dalla parte opposta, verso Tarsis. Quello da cui fuggiva non era tanto Ninive, ma proprio l’amore senza misura di Dio per quegli uomini» (Jorge Mario Bergoglio – Da un’intervista rilasciata nel 2007 a Stefania Falasca di “30 giorni”, riportata nel Corriere della sera del 14 marzo 2013, p. 9). Giusto, ma tutto questo non sarebbe avvenuto se i niniviti fossero stati solo destinatari della parola e non già interpreti attivi del messaggio portato loro, sub contraria specie, da un profeta d’Israele.
2. Scrittura come parola di Dio
La Scrittura è parola di Dio innanzitutto perché è ricevuta, accolta e trasmessa come tale all’interno di una comunità di fede. Può sembrare poco; in realtà è molto. In ogni caso, per affermare questa peculiarità, non abbiamo altra via che rivolgerci a questa catena che lega tra loro le varie generazioni di credenti. In altri termini, a rendere ispirati i libri biblici sono non tanto i modi in cui sorsero, quanto quelli in cui essi si sono imposti in seguito. Ciò spiega perché testi affini hanno avuto destini tra loro ben diversi: alcuni hanno avuto l’onore di essere inseriti nel canone, altri sono stati relegati tra gli apocrifi. Né i confini sono identici: qualche comunità considera ispirati libri che per altri non lo sono e viceversa.
Per capire cosa si debba intendere con la frase secondo cui la Bibbia è parola di Dio possiamo prendere le mosse, procedendo per antitesi, guardando alla posizione più estrema, di solito definita fondamentalista. Un presupposto del fondamentalismo si trova, infatti, nella stessa maniera di intendere prioritariamente la Bibbia come puro libro. La Scrittura viene infatti letta in modo letteralistico, astorico e globale in quanto intesa come un libro in se stesso completo e autosufficiente. L’astoricità e la globalità attribuite al testo da un lato si oppongono, come è ovvio, alla ricerca storico-critica orientata a individuare i modi in cui le singole parti della Bibbia si sono formate, mentre, dall’altro, prendono le distanze anche dagli approcci propriamente tradizionali. Questi ultimi, infatti, prevedono che il rapporto del lettore con il testo sia guidato, anzi in un certo senso sia addirittura pre-determinato, dai modi in cui la Scrittura è stata trasmessa all’interno delle varie comunità dei credenti. Tra il lettore e il testo, dunque, operano sempre delle mediazioni che svolgono un ruolo essenziale per definire la natura stessa del libro.
Uno dei passaggi chiave per comprendere questo procedere è la liturgia. Quest’ultima non è solo il contesto in cui si produce una determinata lettura della Bibbia: essa è anche una modalità che, in un certo senso, stabilisce sia la natura stessa della Scrittura, sia la gerarchia delle sue parti, sia i principi ermeneutici della sua interpretazione. Per rendersene conto basta un esempio. Tutti sanno che, nel corso della liturgia cattolica, la lettura del vangelo è ascoltata in piedi, mentre gli altri testi biblici li si ode stando seduti; ebbene, sarebbe sufficiente tale prassi per rendere immediatamente evidente l’eccellenza attribuita ai quattro vangeli nei confronti di tutte le altre parti della Scrittura. Infatti questa posizione chiave assegnata ai vangeli esprime concretamente l’adozione di una lettura che considera la persona di Gesù Cristo il riferimento fondamentale per interpretare l’intera Bibbia. Non a caso la risposta liturgica dell’assemblea è differenziante; essa qualifica come «parola di Dio» i testi proclamati nella prima e nella seconda lettura, mentre considera «parola del Signore» il vangelo. Eppure fuori dalla celebrazione della messa, tutte le parti della Scrittura sono considerate ugualmente ispirate, vale a dire non vi è un qualche testo che sia meno parola di Dio di un altro. Tuttavia in ogni approccio ermeneutico, non solo in quello liturgico, vi è l’interpretato e l’interpretante.
In termini generali si può asserire che la Bibbia è parola di Dio nel momento in cui è ricevuta, accolta e trasmessa da una comunità che, mentre compie questa operazione, individua proprio in ciò i criteri fondamentali dell’interpretazione del testo. Va da sé che essi mutano a seconda dei sistemi religiosi a cui ci si sta riferendo. Per esempio, per l’ebraismo un ruolo in un certo senso paragonabile a quello assunto nel cristianesimo dai vangeli è riservato alla Torah (Pentateuco), considerata, anche in sede liturgica, come la componente eminente dell’intera Bibbia ebraica. Se si prescinde da quest’ambito l’idea stessa di parola di Dio perde consistenza. Ciò non significa, va da sé, che non vi siano altri contesti, innanzitutto pastorali, teologici e spirituali, in cui la Bibbia è accolta come libro rivelato.
«Impara a conoscere il cuore di Dio mediante la parola di Dio (disce cor Dei in Verbis Dei)» affermava Gregorio Magno. L’accondiscendenza del cuore di Dio si trova nel fatto che nella Scrittura egli parla la lingua degli uomini: «le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini; come già il Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile agli uomini» (Dei Verbum, n. 13). Questo abbassamento costituisce il presupposto teologico di un problema ermeneutico decisivo: la Scrittura è parola di Dio perché parla la lingua degli uomini, ma proprio per questo essa è legata ai tempi, ai momenti e alle culture. Per la medesima ragione gli agiografi, secondo i dettami conciliari, vanno visti sia come ispirati da Dio sia come veri autori: «Per la composizione dei Libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo Egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva che fossero scritte» (Dei Verbum, n. 11). Le tendenze fondamentalistiche che intendono (sulla scorta del passo di Geremia 1,9) l’ispirazione come l’atto con cui Dio pone le parole una ad una in bocca agli autori, non colgono né il passaggio discriminante affidato all’interpretazione, né il profondo senso teologico rappresentato dall’abbassamento di Dio. In questo senso la parola biblica non va considerata, come vuole qualcuno, pura attestazione della fede dello scrittore sacro posto davanti all’evento della rivelazione. Narrazioni e scrittura, senza essere svincolabili dalla cultura che le impregna, sono parti integranti della rivelazione. Nessun evento fondativo e rivelativo giunge a noi se non è trasmesso.
Gregorio Magno, proprio nel passo in cui evoca l’immagine del cuore, paragona la Scrittura a una lettera vergata da Dio e destinata alle creature umane. Ricorrere a una simile immagine dovrebbe comportare il non tirarsi indietro neppure dall’esito estremo di vedere la missiva rispedita al mittente. Anche in ciò vi è un mistero di umiltà da parte di Dio. La distanza, intrinseca all’immagine della lettera, è quanto consente di operare un accoglimento o un rifiuto. La presenza-assenza di Dio nella Scrittura costituisce la Parola come un tipo di verità che rinuncia alla forza dell’imposizione. Essa lascia sempre spazio alla libertà. È nella fede, e solo in essa, che la Bibbia è indubitabilmente parola di Dio. Fuori dall’orizzonte del credere la Bibbia è parola umana sapiente o arcaica, amorosa o violenta, misericordiosa o crudele, bella o aspra e via dicendo. In effetti la Scrittura è anche questo. Non è empio leggerla come un documento profano in cui si colgono uomini che parlano di Dio e non già Dio che parla agli esseri umani.
Fu viva raccomandazione della costituzione conciliare Dei Verbum dichiarare la necessità che i fedeli avessero largo accesso alla Scrittura (DV n.22). Ciò sta a significare che l’incontro con la parola biblica è parte integrante della vita della comunità. Essa si alimenta nella misura in cui il testo scritto diventa «altro da sé» nell’ascolto, nella comprensione, nella preghiera e nell’esistenza dei credenti. In questo contesto il cammino individuale è chiamato a incontrarsi con quello proprio di una comunità convocata attorno alla Parola. Rivolgiamoci ancora alla Dei Verbum. Più esattamente al passo in cui la costituzione conciliare dichiara che, con l’aiuto dello Spirito, la crescita della comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse avviene «sia con la riflessione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19.51), sia con l’esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali, sia con la predicazione di coloro i quali, con la successione episcopale, hanno ricevuto un carisma sicuro di verità» (Dei Verbum, n. 8).
La successione dei tre «sia» non è casuale. Il primo passo indica quanto tutti accomuna. La riflessione e lo studio tocca ogni credente in prima persona. Resta però anche vero che senza ascolto reciproco i tre «sia» ora enunciati perdono consistenza. Non si tratta di compiere una pura somma di addendi: questo più quello, più quell’altro. Al contrario, nel caso in cui divenga linfa della vita ecclesiale, ogni «sia» si dà unicamente in relazione con gli altri due. La predicazione episcopale è sterile se non presta ascolto alla meditazione e all’intelligenza della parola presente nella comunità dei credenti. In modo analogo l’approfondito studio personale porta all’isolamento e al settarismo se non si confronta con la voce di chi presiede l’assemblea. Tuttavia il primo fattore enunciato è l’impegno da parte di ciascuno. Non è dato abdicare a esso, neppure quando (ed è situazione tutt’altro che teorica) latita la sapienza episcopale.
Il cammino individuale fatto di amore e ricominciamenti è chiamato a incontrarsi con quello peculiare a una comunità convocata attorno alla Parola. L’accesso personale alla Scrittura trova alimento nel fuoco dell’ascolto reciproco. Il grande monaco camaldolese Benedetto Calati non si stancava mai di proporre alla mente e al cuore dei suoi interlocutori alcune parole di Gregorio Magno. Con esse il vescovo di Roma esprimeva la convinzione in base alla quale la verità trova dimora solo là dove si realizza la pratica di porgere orecchio gli uni alla voce degli altri: «Ritengo come un dono ciò che ciascuno dei fedeli potrà sentire e comprendere meglio di me. Perché tutti coloro che sono docili a Dio, sono organi della verità! Ed è in potere della verità che essa si manifesti per mio mezzo agli altri o che per gli altri giunga a me. Essa è certamente uguale per tutti noi, anche se non tutti viviamo allo stesso modo; ora tocca questo, perché ascolti con profitto ciò che essa ha fatto risuonare per mezzo di un altro; ora invece tocca quello perché faccia risuonare chiaramente ciò che gli altri debbono ascoltare». Il pastore diviene guida autentica soltanto se ascolta e conosce la voce delle proprie pecore (cfr. Gv 15,14).
Si ascolta la parola di Dio in quanto si è inseriti in una tradizione; tuttavia nella modernità non ci si dovrebbe esonerare neppure dal confronto con il polo della ricerca storica. Civiltà del commento e civiltà della critica rappresentano, senza dubbio, fasi diverse e per alcuni versi contrastanti dello sviluppo dell’intelligenza della Scrittura. La prima ha lo sguardo rivolto a valle ed è immersa nelle scorrere della corrente; la seconda guarda a monte al fine di rinvenire, dall’esterno, i primissimi zampilli del grande fiume. La prima è fiduciosa, la seconda sospettosa. Pur essendo polarità opposte bisogna ugualmente chiedersi se, a certe condizioni, ad esse non sia consentito di interagire. Resta fuori discussione che ciò non avviene né nel caso in cui la critica ritenga di mettere in dubbio l’intero approccio tradizionale, né quando il tradizionalismo reputa empio ogni tentativo di attribuire alla ricostruzione storica di ambienti culturali un ruolo significativo al fine di giungere a una corretta e matura intelligenza della Scrittura.
In realtà, in seno alla civiltà occidentale si può essere fedeli allo spirito autentico della tradizione solo selezionando, vale a dire compiendo un’operazione critica. Questa posizione trova conferma nella constatazione che, a partire dall’enciclica Divino afflante Spiritu (1943), la Chiesa cattolica ha cominciato ad additare la legittimità, anzi l’irrinunciabilità, del metodo storico-critico al fine di pervenire a una più matura comprensione del dato rivelato. A motivo di questa operazione, tra commento e critica nasce un equilibrio instabile e ricco di tensioni interne che appaiono insanabili al tradizionalismo e feconde alla vera tradizione.
Quanto resta fondamentale è la volontà di scrutare le Scritture al fine di trarne un motivo di vita per la comunità dei credenti. Oggi l’indagine sulla Bibbia comporta vari metodi. Tra essi vi è anche quello storico. Non è il solo, esso comunque ha voce in capitolo. Si tratta di un apporto dotato di tratti peculiari e autonomi. Per questo in più ambienti si è tentati di attribuire alla ricerca storica un carattere di implicita sfida alle visioni di fede; oppure, con un’operazione simmetrica alla precedente, di renderla invece apologetica, cioè ancillare rispetto a visoni prestabilite. Osservata da entrambe le sponde, la sua natura critica e problematica appare una potenziale minaccia all’inconfutabile certezza di alcune verità fattuali considerate fondanti per un determinato modo di credere.
La dimensione non assoluta della conoscenza storica è un dato innegabile condiviso da ogni studioso onesto e avveduto. Tuttavia proprio questa impostazione fa sì che l’opera dello storico vada considerata libera da ogni pretesa di controllo esercitato su di essa dalla visione teologica. Occorre, quindi, prospettare la reciproca autonomia e non già l’integrazione tra le due aree. La ricerca critica va, per definizione, condotta secondo i parametri peculiari alla storiografia. Essa, dunque, ha l’obbligo epistemologico di presentasi scevra da ogni precomprensione dogmatica. È parte dell’ermeneutica dei credenti far interagire determinati esiti (per loro natura relativi, ma non per questo irrilevanti) della ricerca storica con la propria comprensione di fede, senza intaccare, con ciò, la distinzione tra le due aree. Quanto appare improprio è, invece, porre delle limitazioni preventive alla ricerca storica in ragione di specifiche precomprensioni teologiche. In definitiva, l’approccio storico appare una minaccia per l’ermeneutica di fede solo nella misura in cui quest’ultima si appoggia su dati storici che, assunti come assoluti, risultano invece opinabili in base a uno sguardo critico. Piaccia o non piaccia, per stabilire la realtà storica di un evento (non il suo significato culturale o teologico) non ci è data una via diversa da quella di una ricerca storiografica consapevole dei propri limiti.
Questi contrastanti approcci restano compatibili con il senso alto della tradizione nella misura in cui riescono ad alimentare in modo più maturo l’intelligenza spirituale dei credenti. Colti in quest’ottica, gli stessi metodi danno luogo a esiti molto diversi se applicati nell’accademia o nella Chiesa. Nel primo caso basta respirare l’aria della critica, nel secondo ci si deve impegnare nel compito, non facile, di collegare il senso storico-culturale con la crescita spirituale di una comunità posta in ascolto della Parola. Anche in ragione di tutto ciò, conviene, dunque, affermare che il baricentro della dimensione ispirata della parola sta più nei suoi modi di essere ricevuta, accolta e trasmessa che in quelli legati al suo remoto sorgere.
Tradizione ed escatologia
Leggendo e rileggendo il Prologo di Giovanni si coglie che le parole iniziali vanno comprese alla luce del racconto di quanto viene dopo. Il messaggio che ci è comunicato da questa prospettiva più ampia (Gv 1,1-18) è incentrato sulla massima rivelazione secondo cui il Logos, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose (Gv 1, 3), può essere accolto, e quindi anche rifiutato, dalle sue creature. Si tratta di un’alternativa che ci comunica una realtà abissale: chi è all’inizio di tutto, lungi dall’imporre agli esseri umani di essere riconosciuto, chiede loro di venir ospitato esponendosi, di perciò stesso, al rischio di restare fuori dall’uscio. La Parola che crea ogni cosa, nulla impone. È perciò un paradosso vero che il suo non accoglimento faccia parte, sub contraria specie, della rivelazione del Logos. Non è occasionale che ateismo e agnosticismo siano cresciuti all’interno di una cultura che ha conosciuto il cristianesimo. Il dialogo tra i credenti e la Parola inizia solo se quest’ultima è accolta. Lì è la svolta risolutiva. Il messaggio centrale del Prologo non è la razionalità, è l’accoglienza.
Come accogliere in modo conforme la parola quando essa si è fatta Scrittura? Perché ciò sia possibile si devono verificare condizioni per alcuni versi simili a quelle legate ai «classici» capaci di lasciare un’impronta nell’animo del lettore. Pure rispetto alla Bibbia vale quanto Dante affermava per l’opera virgiliana. Quando ci si confronta con la Scrittura il cercare va infatti visto come il coronamento di una diuturna familiarità e non già come un puro presupposto destinato a placarsi nella bonaccia di una tranquilla comprensione. Anche di fronte alla Bibbia si dovrebbe quindi ripetere: «vagliami ‘l lungo studio e ‘l grande amore / che m’ha fatto cercar lo tuo volume» (Inferno, 1,83-84). Studiare e amare un testo significa non cessare mai di cercarlo e di scrutarlo.
Quando ci si confronta con la Scrittura risuona costante la voce di una non rassegnata inadeguatezza. Per quanti passi si facciano, il terreno ancora da investigare resta comunque più esteso di quello già solcato e risolcato. Lutero disse che per diventare credenti occorre accogliere la parola di Cristo sapendo che non la si apprenderà mai a fondo. Il che comporta – aggiungiamo – che, più che dichiararsi veri credenti, occorre aspirare sempre a divenire tali. Se valesse la pena di vantarsi – proseguiva il riformatore – «io lo potrei anche. Ho passato infatti giorni e notti in questo studio, ma in questo insegnamento devo restare uno scolaro. Io ricomincio quotidianamente come un alunno delle elementari».uaQ
Nella vita della Chiesa cattolica il modo più frequente in cui è avvenuta la rottura della circolazione legata all’intelligenza delle cose spirituali sta nell’aver posto di fatto il magistero in luogo della parola e della tradizione. Questa deriva è stata parte della storia di una Chiesa che ha sequestrato la parola e l’ha sottratta ai fedeli. I credenti più che porsi in ascolto della Parola devono semplicemente ubbidire a un insegnamento episcopale che attribuisce a se stesso la funzione di essere interprete della Scrittura e della tradizione. Ciò avviene specie quando la Chiesa nei suoi vertici non si è alimenta della parola e della tradizione ma la sostituisce con forme di magistero che pongono al centro un insegnamento diretto a riproporre la centralità dell’istituzione. Per trovare la denuncia di simili pretese non è necessario pensare alla Riforma, basta rivolgersi a Dante e alla straordinaria chiusa del nono Canto del Paradiso. In essa si afferma che una delle conseguenze della dilagante corruzione ecclesiastica del suo tempo si trova nel fatto che Scrittura e tradizione sono trascurate a favore della produzione curiale:
Per questo l’Evangelio e i dottor magni
son derelitti, e solo ai Decretali
si studia, sì che pare a’ lor vivagni.
A questo intende il papa e’ cardinali:
non vanno i lor pensieri a Nazarette,
là dove Gabriello aperse l’ali.
(Paradiso, IX,133-138).
In questi versi il vistoso consumo dei bordi (vivagni) dovuto alla perenne consultazione dei Decretali e l’abbandono in cui sono lasciati i vangeli e i loro indispensabili interpreti (i dottor magni) esprimono, con la straordinaria pregnanza visiva propria di Dante, la simultanea perdita della centralità della parola e della mancanza di un’autentica comunione ecclesiale. Senza dimenticare che, quando si guarda a Nazaret, si celebra ispo facto l’umiltà di Dio; ogni affermazione centrata su se stessi è perciò costretta a dirigere i propri occhi altrove.
La parola e la tradizione si aprono su quanto l’approccio storico non può, né deve, fornire: il senso dell’attesa. La critica è storica e non tradizionale. Essa è uno scavo nelle viscere delle epoche e non già un pellegrinaggio nel tempo. Il suo terreno è l’esegesi, vale a dire la comprensione del passato in virtù delle categorie che gli sono proprie. Ne consegue che la fede non può vivere solo di un atteggiamento critico. Il suo volto non è girato unicamente all’indietro. Essa è chiamata ad attendere anche quando si trova in una stagione di penuria. Rovesciando l’antica sentenza (cfr. Eb 11,1), va affermato: la speranza è sostanza della fede. Non esiste un credere avulso dall’attendere. L’irriducibile differenza tra tradizione e storia passa anche su questo versante.
Quando l’attesa è posta sulla bocca dei credenti in Gesù Cristo l’espressione più propria è: «Maranà tha, vieni o Signore!» (1Cor 16,22). Le comunità dei credenti non sono state in grado di reggere per secoli il peso di questo grido. Forse è possibile che ciò avvenga da parte del Figlio dell’uomo seduto nel suo esilico regno dei cieli. Forse in questa sua attesa si trova il senso più autentico del detto di Pascal secondo cui Gesù è in agonia fino alla fine dei tempi. I credenti, chiamati a vivere sulla terra, non sono nelle condizioni di tenere quotidianamente spalancato di fronte a loro l’abisso del «non ancora». La «distrazione (divertissement)» pascaliana fa parte della nostra antropologia. Perciò è divenuto a poco a poco fatale imboccare la via dell’amputazione del desiderio. Un modo per farlo è stato rendere formula liturgica il Maranà tha. Nel corso della messa, subito dopo la consacrazione, si ripete «nell’attesa della tua venuta», tuttavia nella liturgia l’accento batte su una presenza detta reale e nel cuore dei fedeli la frase, per lo più, è soltanto una formula.
Non di rado, di fronte allo scarso ardore o all’aperta fiacchezza della fede dei credenti e alla drammatica situazione in cui giace il mondo si sente ripetere l’interrogativo del vangelo di Luca: «Ma il Figlio dell’uomo che viene troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8). Si tratta di una domanda propria del credente. La sua formulazione non lascia adito a equivoci. L’interrogativo sulla permanenza della fede è davvero tale, vale a dire resta aperto. Esso sorge solo all’interno di un presupposto che rappresenta il contenuto più alto e arduo della fede evangelica: la venuta del Figlio dell’uomo alla fine dei tempi. Se la storia del buon annuncio evangelico fosse giunta alla sua effettiva estinzione, ciò comporterebbe in prima istanza lo svanire della possibilità stessa della venuta del Signore. Il Figlio dell’uomo semplicemente non verrebbe mai. La sua venuta sarebbe una semplice illusione, non meno di quanto lo sarebbe la fede. Fuori dal kerygma non vi è alcun riferimento a una fine dei tempi contraddistinta non da una estinzione lenta o brusca di quanto c’è, bensì da un sopraggiungere di quanto ora è presente solo in forma di caparra.
L’espressione di Luca trova corrispondenza nel tenace permanere del piccolo numero di credenti non ingannati (ma proprio per questo messi continuamente alla prova) di cui parla Matteo: «ma chi persevererà fino alla fine sarà salvo» (Mt 24,13). La presenza di un «resto» confuta il totale estinguersi della fede. Nel primo vangelo il restringimento del nucleo dei credenti ha come contraltare l’allargamento dell’annuncio evangelico; subito dopo infatti si legge: «Frattanto questo vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine» (Mt 24,14). Affermazione potente che ha influito in modo determinante sulla storia. Lungo i secoli essa ha sospinto molti credenti ad annunciare il vangelo a ogni latitudine e longitudine. Ciò era necessario perché sopraggiungesse il compimento del Regno di Dio. Si è trattato di un impulso inesauribile che ha fatto travalicare monti, disboscare foreste, solcare oceani, senza che la fine giungesse. Quel moto ha trasformato il mondo, ma non ha fatto sì che la Gerusalemme celeste giungesse a noi.
I due volti si rimandano l’un l’altro: la diffusione della buona novella del Regno è il luogo massimo per misurare la presenza e la debolezza del credere. Si può essere più radicali: è il punto archimedeo per interrogarsi sul fallimento della fede. Domanda che nasce solo se si hanno fissi davanti agli occhi sia il Regno che viene sia i segni immensi di irredenzione sparsi ovunque in questo nostro mondo. La speranza in una pienezza di vita differente dall’affievolirsi del respiro che consegna tuttora alla morte la nostra esistenza dice la debolezza della fede a salvare, ne afferma l’impotenza e addita in essa la presenza dell’incredulità. L’interrogativo se il Figlio dell’uomo nel suo venire troverà fede sulla terra non è espressione di un dubbio relativo al credere, né sostiene che l’ipotesi dell’esistenza o dell’inesistenza di Dio si diano alla pari. È, come ha instancabilmente ricordato Sergio Quinzio, una domanda interna al credere che consegna la nostra fede alla piccolezza svelandone l’impotenza, senza per questo estinguere il senso dell’attesa. Letta sotto questa angolatura, è proprio della fede vivere sempre e comunque in tempi difficili.
Piero Stefani
