Proposte di lettura (2)
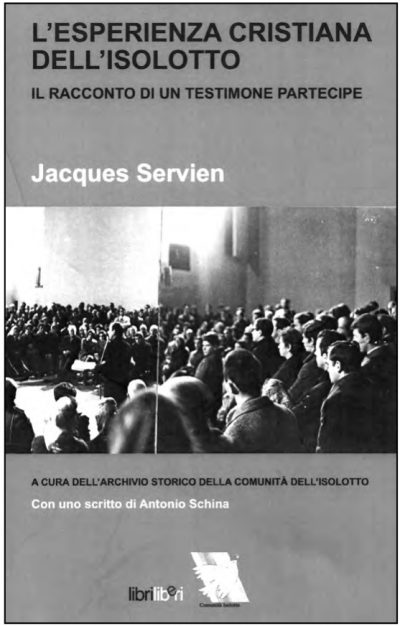
Il libro di Jacques Servien, L’éxperience chrétienne de l’Isolotto, del 1969, occupa un posto particolare tra le pubblicazioni in lingua straniera uscite quell’anno sulla vicenda della comunità parrocchiale dell’Isolotto, su cui si era concentrata, a partire dagli ultimi mesi del ’68, l’attenzione della stampa italiana e internazionale. Infatti il testo, che propone nella seconda parte la bella traduzione in francese di Incontro a Gesù, cioè dello strumento dell’innovativa esperienza di catechesi attuata all’Isolotto, contiene un consistente saggio sull’esperienza realizzata nella parrocchia fiorentina, con tre ampi capitoli animati da un interesse profondo non solo per l’«esperienza pastorale» realizzata nella «parrocchia operaia», ma anche per l’ambiente della Chiesa fiorentina che l’aveva generata, che ne aveva permesso la maturazione e l’assunzione, in oltre quattordici anni di cammino, di una precisa, forte, identità.
Rileggendo il libro, a quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione, ci ha colpito la freschezza del racconto, la volontà di cogliere e rappresentare per lettori lontani la tensione e l’autenticità delle esperienze che a Firenze si erano sviluppate soprattutto negli anni ’60, preparate, nei decenni precedenti dal cardinale Elia Dalla Costa e dall’esperienza della Madonnina del Grappa, voluta da don Facibeni.
Il quadro tracciato è ricco e completo, e le vite di questi «uomini in ricerca» sono delineate in modo preciso con intuizioni e capacità di cogliere le particolarità del carattere e del pensiero piuttosto rare: non solo Enzo Mazzi (a lui e all’esperienza dell’Isolotto è dedicato l’ultimo dei tre capitoli), ma anche don Lorenzo Milani, padre Giovanni Vannucci, Ernesto Balducci, Bruno Borghi e altre figure importanti che insieme formavano un tessuto che giustamente l’autore ha scelto di rappresentare nel suo insieme, valorizzando le relazioni, i punti di contatto tra esperienze diverse che spesso traevano ispirazione l’una dall’altra.
È per questa ragione – perché pensiamo che questo racconto meriti oggi una rilettura attenta, non solo da parte degli storici, ma anche da tutti coloro che sono interessati a capire l’origine, le radici di un modo di vivere il cristianesimo che ha una ragion d’essere anche oggi – che abbiamo deciso di pubblicare in italiano la prima parte del libro, che precede il Catechismo. A cinquanta anni dagli avvenimenti che determinarono la fine dell’esperienza vissuta in parrocchia e la nascita della comunità di base, la Comunità dell’Isolotto – che considera importante anche l’impegno sul versante della memoria e della testimonianza delle esperienze del passato come strumento di resistenza e di costruzione di consapevolezza – ha deciso di dare vita ad una collana editoriale, che abbiamo chiamato «Semi e fioriture».
Attraverso la collana ci proponiamo di valorizzare i documenti conservati nell’Archivio Storico e proporre approfondimenti su temi che sono stati oggetto in passato di riflessioni e di percorsi di ricerca, da rivisitare e riproporre anche per l’oggi.
Abbiamo voluto che il primo libro della collana fosse questo, che ha le caratteristiche del documento e della testimonianza diretta (un racconto scritto “a caldo”, quando la vicenda dell’Isolotto era ancora in pieno svolgimento…), e al tempo stesso si propone come un’analisi acuta, ricca di considerazioni di tipo teologico e sociologico, con frequenti raffronti con la realtà francese, che costituiva spesso il retroterra culturale che aveva ispirato molti degli uomini citati.
Un’altra ragione ci ha rafforzato in questa idea, e riguarda il profilo dell’autore. Jacques Servien è in realtà lo pseudonimo di Philippe Renard (1932-1992), uno studioso, un intellettuale che univa la passione per la letteratura e la cultura italiana alla riflessione costante sulla società italiana contemporanea, sul dibattito che si andava sviluppando, e che toccava tanti aspetti della religiosità, colti anche nelle differenze che lo caratterizzavano rispetto alla realtà francese e alla “scristianizzazione” che sembrava prevalere in quel contesto.
Docente di letteratura italiana, traduttore di numerosi autori italiani, tra cui Mario Luzi, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Attilio Bertolucci, ha insegnato letteratura italiana all’Istituto Francese di Firenze dal 1964 al 1973, distaccato dall’Università di Grenoble. Si trovava quindi a Firenze quando gli avvenimenti narrati riguardanti l’Isolotto si svolgevano, e anche negli anni immediatamente precedenti, fondamentali per comprendere la svolta involutiva del crogiuolo fiorentino: gli anni della fine dell esperienza lapiriana e dell’aumento della conflittualità all’interno della diocesi.
Philippe Renard dimostra nel testo di aver conosciuto e visitato le realtà descritte: lo dimostra la precisione con cui descrive l’esperienza del- l’Isolotto e il profilo biografico di don Mazzi e degli altri sacerdoti, ma anche la chiarezza di particolari con cui parla della realtà delle Stinche, l’eremo nel Chianti di padre Vannucci e della sua comunità, e dell’esperienza di don Bruno Borghi. Come viene precisato nella quarta di copertina del libro, il suo lavoro «cerca di collocare i fatti, prima ricostruendo il contesto locale e nazionale, e le precedenti esperienze religiose poco conosciute in Francia, che hanno segnato il cattolicesimo toscano. In seguito narrando gli avvenimenti in modo preciso, citando i documenti, facendo luce sui personaggi – e l’autore conosce direttamente gli uni e gli altri.»
Sull’Isolotto Philippe Renard ha scritto in altre occasioni, come corrispondente di «Le Monde» e anche, con lo pseudonimo di Yves Monbrun, su «Esprit», e, nell’ottobre 1969, su «Témoignage chrétien».
La sua vita e il suo lavoro importantissimo di diffusione della cultura e della letteratura italiana in Francia – oggetto dei suoi studi furono anche Dante, Eugenio Montale, Umberto Saba, Leonardo Sciascia, Giuseppe Ungaretti – furono bruscamente interrotti per la morte improvvisa avvenuta in un incidente aereo nel gennaio 1992. In una raccolta di scritti in suo onore realizzata dall’Università di Grenoble un anno dopo la sua morte, la pubblicazione de L’expérience chrétienne de l’Isolotto è ricordata come «ad un tempo documento sociologico e testimonianza impegnata sulla rivolta di un quartiere popolare di Firenze», sottolineando come sia «necessario rileggere queste pagine per misurare quanto la sua passione intellettuale sappia unire la forza di convinzione e il rispetto dell’altro».
Condividiamo questo giudizio, ed è proprio per la passione intellettuale che Renard dimostra che oggi riproponiamo le sue riflessioni e il suo racconto, caratterizzato da una profonda partecipazione e comprensione della vicenda dell’Isolotto e delle storie personali e comunitarie che con essa si sono intrecciate, di grande attualità anche oggi, quando a distanza di molto tempo è più difficile cogliere l’intensità delle esperienze e delle scelte di vita.
Tra gli aspetti fondamentali della nostra esperienza che Philippe Renard ci sembra aver colto – e siamo consapevoli di quanto sia rischioso, soprattutto su un piano storico, riflettere su se stessi – c’è la sottolineatura dell’intensità dell’esperienza religiosa condotta in parrocchia, dello sforzo di rinnovamento, incompreso, portato avanti sul piano della liturgia e di un modo di vivere la religione non disgiunto dalla vita, da «un intero popolo» in quattordici anni di condivisione di riflessioni e di pratiche di vita. «Una nuova dimensione religiosa sta nascendo» è il suo efficace commento agli avvenimenti a cui stava assistendo.
Questa realtà, che la Comunità volle raccontare in prima persona con il libro Isolotto 1954-1969 (Laterza 1969) – e va ricordato che Philippe Renard contribuì alla conoscenza in Francia della vicenda dell’Isolotto anche suggerendo la tempestiva pubblicazione, ancora a cura delle Editions du Seuil (1970), della traduzione in francese del libro – venne compresa nella sua novità. Questo è tanto più importante per i protagonisti di quella esperienza, se consideriamo che in alcuni di loro è ancora vivo il ricordo del commento fatto dai nuovi sacerdoti che nel ’69 si insediarono nella chiesa dell’Isolotto, interrogati sul rapporto che pensavano di avere con la comunità: «… ma quale comunità? Qui c’è ben altro!», forse alludendo ambiguamente ad appartenenze ideologiche o politiche.
Questo è quindi anche un ringraziamento a chi ha intuito e saputo raccontare il “ben altro” che aveva portato una parrocchia a materializzare quell’idea di comunità cristiana indicata dal Concilio Vaticano II quale elemento primario per una rifondazione della Chiesa in “ecclesia” fedele al Vangelo.
La comunità dell’Isolotto / Archivio Storico
