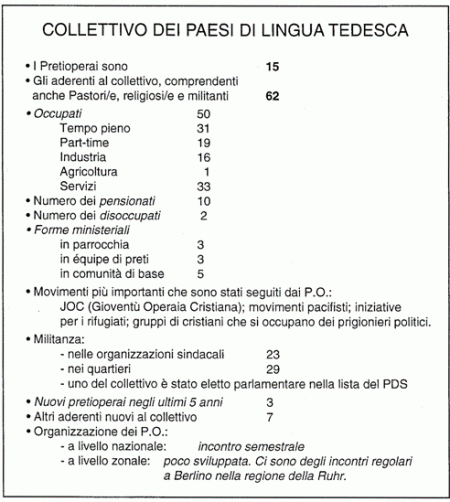STORIA DEL COLLETTIVO DEI PO
DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
(Questo contributo può essere letto in lingua francese aprendo o scaricando il file PDF del n.30-31 della nostra rivista: qui)
Introduzione
Questo contributo si inserisce nel progetto dei nostri amici italiani che hanno proposto di scrivere la storia dei PO in Europa, storia che vogliono pubblicare in un numero speciale della loro rivista “Pretioperai”.
Dei quattro elementi del titolo, per noi è valido solo l’ultimo: gli uomini e le donne di cui vi parleremo sono tutti di paesi di lingua tedesca: Svizzera tedesca, Austria, Germania. Costoro però non sono tutti preti. Nel gruppo ci sono certamente dei preti, diocesani e religiosi, ma anche dei religiosi non preti, delle religiose, dei laici, uomini e donne con una formazione teologica ed anche con esperienze in attività pastorali, e ci sono pure i pastori protestanti, uomini e donne. Non tutti vivono come operai nel senso di salariati in un’impresa industriale o nel campo dei servizi privati o statali o nell’artigianato. Chiaramente molti sono operai. Ma altri lavorano nelle iniziative di quartiere, all’interno delle istituzioni o movimenti che si occupano di soggetti emarginati, a tempo pieno o parziale.
E da ultimo, non si tratta di un collettivo nel senso di organizzazione ben strutturata, riconosciuta persino dalle autorità ecclesiastiche. Il collettivo non si presenta come una comunità vera e propria preoccupata di affermare la propria immagine pubblicando le proprie esperienze e rendendo note le proprie prese di posizione. Il gruppo piuttosto è un insieme di persone, la maggior parte delle quali si riunisce due volte all’anno per un weekend, chiamato “Arbeitergeschwistertreffen” (Geschwister = fratelli e sorelle).
In occasione del ventesimo anniversario di questi incontri, nel 1992 abbiamo pubblicato un opuscolo nel quale alcuni di noi narrano qualche momento della nostra storia. Nell’introduzione così si dice:
Arbeitergeschwister – che cos’è? degli uomini e delle donne formati come cristiani credenti, che si sono appropriati di un modo di pensare illuminato dal significato e dallo spirito della Bibbia; che in gran parte hanno fatto studi di teologia universitaria e che in seguito hanno svolto un ministero ecclesiale a tempo pieno; ma che un giorno hanno deciso di assumere lo stile di vita dei semplici operai.
Dopo venti anni essi continuano ad incontrarsi due volte all’anno per parlare insieme su questo tipo di vita che svolgono e sui problemi più importanti che emergono in questo strato sociale.
All’inizio erano solamente preti cattolici, diocesani o religiosi, per forza di cose uomini. Prima di iniziare questi incontri essi non si conoscevano. Seguendo l’esempio francese, essi si comprendevano come pretioperai e si dichiaravano tali. Un po’ più tardi vennero dei Piccoli Fratelli, poi delle Piccole Sorelle e dei laici, uomini donne che avevano un incarico pastorale. Da ultimo vennero anche dei pastori protestanti, uomini e donne.
Comune a tutti costoro era la volontà di condividere lo stile di vita dei semplici operai, e questo lo si è mantenuto, ed anche il bisogno di riflettere e di parlare insieme su questa esperienza.
Nel corso degli anni il gruppo è diventato un cerchio misto con una grande ampiezza di posizioni differenti sulla chiesa, sulla società…, e un’altrettanta ampiezza di obiettivi, derivati da queste opinioni.
1. LA STORIA
1.1 Nascita ed evoluzione del collettivo
1.1.1. È alla fine degli anni 60 che sorgono i primi PO in Germania. Si trattava di qualche prete diocesano che cominciava allora a vivere l’esperienza operaia; qualcuno di loro aveva appena terminato il proprio ministero di assistente nella Gioc. Indipendentemente da costoro alcuni religiosi fecero lo stesso cammino: appartenevano agli ordini dei domenicani, dei francescani e degli Oblati. Prima ancora, alcuni Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld erano arrivati in Germania. Si erano stabiliti a Duisburg e ad Amburgo; essi ebbero un provocatore effetto d’urto per non pochi cristiani e per preti in ricerca.
Occorre anche segnalare l’iniziativa di un pastore protestante di nome Horst Symanowski. Costui nel 1948 incominciò a lavorare a Mainz. Più tardi fondò un istituto di formazione nella stessa città, cambiando l’orientamento missionario nei confronti del mondo del lavoro. Molti pastori protestanti hanno ricevuto lì la loro preparazione per la pastorale nel mondo del lavoro. Per i pastori dell’ex RDA, questo istituto asssunse il ruolo di sfida e fu un luogo di accompagnamento per un’integrazione più esistenziale nel mondo delle fabbriche.
1. 1.2. Nel Giugno del 1972 si riuscì a riunire questi PO per la prima volta, nel convento dei Padri Oblati a Mainz. Richard Mayer, uno di loro, fu il promotore dell’iniziativa. Egli investì molto tempo ed energie per incontrarli ad uno ad uno, per parlare con loro e per proporre di fare questo primo incontro. In un rapporto di quel tempo Richard ha scritto:
«Durante questi contatti mi sembrava che ciascuno avesse l’impressione di essere l’unico prete operaio in Germania. Quando io parlavo degli altri e suggerivo la possibilità di incontrarsi, percepivo subito un grande interesse; tuttavia non è stato facile riunirli tutti insieme. Sono dei tipi originali, con caratteri non affatto facili che scelgono la “carriera di PO”. Non era dunque semplice riunire tali tipi».
Nel Giugno del 1972 dunque ci siamo ritrovati nel convento degli Oblati a Mainz con sette partecipanti. Questa volta e la successiva erano presenti unicamente dei PO in senso stretto, compreso qualche seminarista alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale, che aveva deciso di fare il PO. Poco dopo venne un rappresentante per ogni fraternità dei Piccoli Fratelli (preti o no). In poco tempo ci trovammo in una decina. Dopo la primavera del 1978 partecipò anche un rappresentante dei PO francesi e poco dopo anche un PO belga. Fin dagli inizi alcuni compagni della Svizzera tedesca e dell’Austria facevano parte del gruppo.
Nella primavera del 1983 avvenne un cambiamento: per la prima volta parteciparono le donne. In seguito aumentò il numero dei non preti. Fu così che dall’incontro dei PO si passò alla “Arbeitergeschwister-Konferenz”.
1.1.3. Dal Giugno del 1972 in poi questi incontri hanno avuto regolarmente luogo, uno in primavera, l’altro in autunno; fino al 1987 quasi sempre a Mainz. Dal maggio del 1988 gli incontri si tengono in una casa di formazione delle tre diocesi di Mainz, Limburg e Fulda, situata a Ilbenstadt, a nord di Francoforte.
Il numero dei partecipanti all’inizio cresceva continuamente; una volta eravamo più di cinquanta. Attualmente sono presenti in media tra le 30 e le 35 persone. Da sottolineare un fatto speciale: ad ogni incontro c’era qualcuno che partecipava per la prima volta. Un rinnovamento straordinario!
Naturalmente abbiamo anche conosciuto la tendenza opposta: alcuni si sono separati dal gruppo, due amici sono morti; altri ancora si sono stabiliti all’estero. Qualcuno ha cambiato la propria condizione di vita andando in pensione o abbandonando la condizione operaia. E ci sono state anche delle persone che non condividevano l’evoluzione del gruppo. Gli austriaci iniziarono un loro proprio incontro nazionale; da quel momento fanno parte del gruppo solo alcuni rappresentanti di quel paese. Uno di noi è andato alla loro riunione.
L’invito che avevamo fatto alla conferenza episcopale ha avuto come risposta la partecipazione abbastanza regolare di un collaboratore laico della segreteria episcopale: ma c’è voluto del tempo per reagire così. Una o due volte abbiamo avuto la visita di un vescovo ausiliare, incaricato tra l’altro della pastorale del mondo operaio.
Solo raramente abbiamo invitato alcuni esperti che avrebbero potuto aiutarci nella riflessione.
1.1.4. La struttura degli incontri è rimasta sempre la stessa:
Venerdì sera: arrivo e incontri informali.
Sabato mattina e spesso anche l’inizio del pomeriggio: la comunicazione individuale. Ciascuno ha l’occasione di raccontare gli elementi più importanti della sua vita avvenuti nel periodo precedente e di comunicare esperienze e posizioni attorno ad un tema precedentemente preparato.
Sabato pomeriggio: discussione e approfondimento in piccoli gruppi che si costituiscono a secondo degli interessi di ciascuno.
Sabato sera: la liturgia eucaristica, alla quale dedichiamo tutto il tempo necessario per la riflessione, la preghiera, i canti, la festa. Generalmente si tratta di un momento molto forte. Dopo la liturgia si condividono le informazioni più dettagliate, se qualcuno ha fatto un viaggio o delle esperienze straordinarie.
Domenica mattina: riunione pratica, in cui si trattano temi comuni generali riguardanti l’attualità, in cui si fa la valutazione dell’incontro e la preparazione di quello successivo.
1.1.5. La direzione concreta è affidata a un segretario, che cambia dopo qualche anno. Egli prepara l’incontro successivo con dei volontari di una regione e poi invia l’avviso. Questo gruppo di preparazione è responsabile del tema, della liturgia e dello svolgimento del weekend.
1.2. Provocazioni esterne
Nei primi tempi la provocazione esterna più importante era, senza ombra di dubbio, un certo clima di rinnovamento negli anni 60/70. Esso si è manifestato in diversi campi. L’anno 1968 è entrato nella storia come una sorta di punto culminante di questo clima: si parla di quelli del “68” come di un certo tipo di persone che cercavano di cambiare le situazioni.
– 1964/68/69 sono gli anni dell’irruzione sulla scena mondiale del movimento studentesco, espressione di un desiderio di cambiamento della società.
– Nello stesso periodo nascono nuovi gruppi e organizzazioni politiche, anch’essi con estensione mondiale. La loro nascita, almeno in parte, era motivata dalla separazione del PC cinese dal PC russo, che a quell’epoca aveva un ruolo egemonico: si pensi ai movimenti e alle organizzazioni maoiste, ai gruppi “K” (kommunistisch) in Germania.
– Nei paesi del terzo mondo si moltiplicano i movimenti di liberazione: Che Guevara, la rivoluzione cubana (1959) la rivoluzione nicaraguense (1979), la disfatta degli USA in Vietnam: tutto questo incoraggiava verso un nuovo inizio, verso una nuova speranza di poter creare modelli politici e sociali nuovi. Senza dimenticare la nascita dei grandi movimenti di solidarietà con il terzo mondo.
– In Germania si assiste alla fine dell’epoca Adenauer, l’ingresso dei socialdemocratici nel governo, all’inizio nella grande coalizione con i cristiano – democratici, e l’epoca dell’apertura politica verso i paesi dell’est realizzata soprattutto da Willy Brandt. Tutto questo significa una certa rottura con comportamenti precedenti ben radicati.
– La grave crisi economica e politica provoca in Germania nuove forme di resistenza: opposizione extraparlamentare (APO) e formazioni di lotta più dura (RAF).
– Il Concilio Vaticano II invita ad una rinnovata apertura verso il mondo. Ognuno si sforza di realizzare questo appello, cercando un nuovo luogo in cui incarnarsi e lottare soprattutto per la giustizia. Questa idea prende piede anche in alcune congregazioni come i Gesuiti, per esempio.
– La grande corrente della teologia della liberazione proveniente dal terzo mondo, esercita una potente forza provocatrice nel nostro paese. Viene messa in questione la posizione ufficiale della chiesa gerarchica. L’ortodossia di questa chiesa è problematizzata dalla ricerca dell’ orto- prassi.
– L’affermazione di movimenti come la Gioc, di luoghi di rinnovamento come Taizé hanno ugualmente giocato un ruolo provocatore.
Al di là di questi elementi legati al clima di rinnovamento, occorre anche segnalare, naturalmente, l’esistenza dei PO negli altri paesi, soprattutto quelli francesi, che erano più conosciuti di altri; e inoltre anche il movimento in crescita dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle.
Tutti questi elementi hanno continuato a svolgere un ruolo importante negli anni successivi; occorre aggiungere qui anche la possibilità per i seminaristi di poter passare una parte della loro formazione in un paese del terzo mondo. Qualcuno di loro è rientrato con l’esigenza profonda di pensare un’altra forma di esistenza sacerdotale o cristiana. Queste considerazioni valgono soprattutto per alcuni che erano stati in Brasile.
Per restare in questa condizione di vita o per entrarvi vi è un fattore molto importante da ricordare: il processo della rinnovata polarizzazione tra ricchi e poveri, che si è accentuata in questi ultimi anni. Il processo di esclusione si è accelerato e aumenta sempre più: la crescita della disoccupazione (sei milioni in Germania), dei senza-fissa-dimora, delle famiglie e degli individui che riescono a vivere unicamente in base ai sussidi sociali, i contratti di lavoro senza protezione, la precarizzazione, il numero crescente di rifugiati di ogni sorta. Il numero degli esclusi o marginalizzati continua a crescere mentre la qualità della loro vita continua a diminuire. Mediante la “colonizzazione” dell’ex R.D.A., questo processo assume delle dimensioni ancora più grandi. I rapporti sulla povertà nel nostro paese si moltiplicano. Alcuni cristiani più sensibili si lasciano condurre a nuovi stili di vita con nuove priorità. Ed anche coloro che già prima avevano deciso di vivere accanto alle vittime confermano l’impegno di restare nel luogo da essi scelto.
1.3. Motivazione interiore
Oltre ai diversi elementi che sono serviti da provocazione esterna, occorrerebbe certo parlare anche della sensibilità degli individui in rapporto a queste correnti. Bisognerebbe cioè scrivere le biografie dei membri del collettivo, per far conoscere le motivazioni più profonde della loro scelta di vita.
È per questo motivo che ci limiteremo ad offrire delle testimonianze personali. Anzitutto segnaliamo i due aspetti che formano il minimo comune denominatore del gruppo.
I membri del collettivo sono tutti segnati dall’esperienza della distanza fondamentale delle chiese gerarchiche e dei loro rappresentanti nei confronti di larghi strati della società, che sono emarginati. Essi sentono questa distanza come un tradimento che si rinnova ogni volta. Questo vale per il mondo operaio nella sua totalità: gli operai sono assenti dalle attività della Chiesa; la loro vita e le loro lotte non sono prese in considerazione e, soprattutto, non sono osservate dal punto di vista di coloro che stanno in basso. Accantonata una certa prossimità caritativa, la maggior parte degli esclusi dalla società sono ugualmente esclusi dalla Chiesa e dalla sua preoccupazione.
Dall’altro lato, i membri del collettivo hanno riscoperto nella loro relazione con Gesù di Nazareth una cosa che hanno profondamente interiorizzato: questo Gesù non è stato dalla parte dei potenti. Anche oggi occorre cercarlo dalla parte dei “non potenti”, nei gruppi emarginati. La risposta autentica all’invito di Gesù: “vieni, sono Io”, conduce a ricercare una vita più vicina ai poveri.
Nella vicenda di ciascuno il riferimento esplicito al Gesù del Vangelo si realizza secondo modalità molto differenti e con una diversa intensità. Ma la motivazione più profonda occorre cercarla qui. Qualche testimonianza:
Isolde:
Vi erano molte ragioni per decidermi ad affrontare questo cammino:
– il fatto che l’annuncio del Vangelo deve essere radicato in una partecipazione autentica alla vita, in mezzo alla gente.
– il fatto che noi ci rapportiamo innanzitutto a delle persone lontane dalla Chiesa più attraverso l’amicizia e la solidarietà che non attraverso il servizio sacerdotale e la catechesi.
– il fatto che il parlare e l’essere, il comprendere e l’esistere devono essere avvicinati l’uno all’altro per poter essere credibili.
Hans-Jörg:
gli è stata posta una domanda: il tuo libretto “ Fabrikerfahrung ” (esperienza di fabbrica è molto critico nei confronti della Chiesa: “la Chiesa annunzia una dottrina sociale. Tuttavia essa ha tradito Gesù Cristo. Ha fatto di Lui il servitore di una religione piccolo-borghese”. Oggi diresti ancora la stessa cosa?
Risposta: sì. Risponderei oggi come allora: la Chiesa ha tradito Gesù Cristo ed ha fatto di Lui un servitore di una religione piccolo-borghese. Anzi andrei più in là: qual è il compito della Chiesa? quello di mostrare la vita. Di creare comunione tra gli uomini. La comunità è già Dio. La Sua volontà e la Sua forza è già Dio.
Christian-Hans-Franz (della comunità dei Gesuiti di Berlino):
Dovremmo limitarci a fare ciò che è “kaputt”, ciò che non serve a niente, un Kreuzberg (monte della croce) sano e salvo? Noi non l’abbiamo fatto anche se qualcuno ce l’ha suggerito. Invece, noi siamo andati alla scuola dei nostri compagni di lavoro, dei nostri vicini. Non sono forse loro i poveri della Bibbia, il piccolo resto che si oppone ad ogni pianificazione, ai cosiddetti sforzi di miglioramento del mondo, ai piani di risanamento, di “risocializzazione” e di integrazione o comunque si voglia chiamare tutto questo? Non sono forse costoro il “santo resto” che si trova sotto la promessa e sotto la protezione speciale di Dio? (Il libro di cui si parla è stato pubblicato nel 1971; le domande sono state poste nel 1992).
Karl:
…e soprattutto, come può un operaio unire la sua vita quotidiana con l’annunzio del Vangelo? Noi annunciamo: l’uomo è il figlio amato di Dio, che tutto riceve dal Padre: grazia, vita, spirito. Ma l’operaio fa un’esperienza diversa: niente è donato, tutto deve essere comperato attraverso un duro lavoro, deve essere meritato grazie a molti sforzi.
Noi annunciamo: l’uomo è l’immagine di Dio, unica, insostituibile, chiamato alla libertà, al compito di costruire il mondo. Ma l’operaio sperimenta che la sua esistenza d’uomo si riduce al lavoro; e là, lui è sostituibile, a rigore, da una macchina. A lui non è permesso di creare qualche cosa.
Thomas:
Far carriera verso il basso, seguendo lo spirito del grande inno della lettera ai Filippesi. Cercare innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia.
Dio si è nascosto. Vieni, andiamo a cercarlo.
Renate:
È difficile parlarne. Si tratta innanzitutto di una “storia di vocazione”, di una “storia d’amore” tra Lui e me.
Voler essere un legame tra la Chiesa e gli operai, i poveri.
Roger:
Vivere sulle tracce del Gesù dell’Evangelo e sulle tracce di colui che si è messo alla sua sequela: Francesco d’Assisi.
Sperimentare il Regno di Dio, la presenza dello Spirito di Dio in mezzo agli uomini. Un sentimento che cresce sempre più: ogni ingiustizia, ogni violenza fatta a qualcuno ferisce anche me.
Cristian:
La curiosità di sapere come Dio visse facendosi prossimo ai poveri. A questo proposito non si trovano risposte negli studi di teologia.
Albert:
Il ritmo di lavoro mi ha sempre richiamato la vita religiosa, la ricerca di una forma soddisfacente in cui si accordano le visioni, la vita, il lavoro. Questa forma di vita è anche ricerca di Dio.
Georg:
Alla fin fine la motivazione è religiosa: cercare Dio presso i poveri, gli sfruttati, coloro che non hanno più diritti. Condividere la vita.
2. PREOCCUPAZIONI PRINCIPALI
2.1. Temi centrali
Per svolgere questo punto sono due le fonti scritte a nostra disposizione:
1) Per i primi cinque anni Richard Mayer ha raccolto i problemi principali di questo periodo, basandosi sugli appunti personali.
2) Esiste un elenco di temi proposti per gli incontri e che sono stati affrontati durante le riunioni, in modo più o meno profondo. Tentiamo ora di identificare le aree dei problemi principali.
2.1.1. I primi cinque anni.
Problemi riguardanti i lavori in fabbrica
– che cosa cerchiamo in fabbrica? cosa vogliamo raggiungere? come strutturiamo la nostra vita di ogni giorno?
– i compagni avvertono che noi siamo “diversi”; come ci spieghiamo questo fatto?
– dobbiamo assumerci compiti sociali? fare da ponte fra gli operai ed i padroni?
– fino a che punto dobbiamo entrare nelle lotte operaie? fino a dove impegnarci nei movimenti di lotta di classe?
– dobbiamo assumerci dei compiti fuori dalla fabbrica (es. con i senza fissa dimora): abbiamo le forze per fare questo? o al contrario: quante forze ci rimangono per l’impegno in fabbrica se noi ci prendiamo carico dei problemi esterni?
– dobbiamo comunicare in pubblico le nostre esperienze? come individui? o come collettivo?
Problemi riguardanti il nostro ministero sacerdotale
– come giustificare questo nostro nuovo cammino di PO? Nei confronti della Chiesa, nei confronti dei compagni? Il nostro cammino non è forse una nuova forma di clericalismo?
– qual è il nostro posto nella Chiesa? E il nostro compito? C’è un nuovo profilo professionale? Quale tipo di collaborazione nella Chiesa è desiderato? E quale è possibile? Dobbiamo fondare nuove comunità cristiane?
– quali sono le nuove forme espressive della nostra vita di fede che dobbiamo creare in questa situazione?
– che ne è del nostro mandato di annunziare la buona novella?
Problemi che insorgono dall’attuale situazione politica e sociale
– come siamo toccati dalle mutazioni sociali, i cambiamenti nel mondo industriale, nella nostra fabbrica?
– e i nostri compagni come sono toccati, o meglio sconvolti da tutto ciò che cambia attorno a loro? (confronta l’elenco nel capitolo sulle provocazioni esteriori).
2.1.2. La lista dei temi
Guardando a fondo l’elenco delle tematiche proposte nei nostri incontri si possono constatare sottolineature differenti:
– nei primi cinque anni innanzitutto le questioni riguardanti la comprensione o la definizione della figura del PO e del collettivo; allo stesso livello le questioni sull’impegno sul sindacato.
– Più tardi l’attenzione si sposta sulla realtà di fabbrica e del mondo operaio che è all’ordine del giorno nei nostri incontri: i problemi della disoccupazione, la riduzione dell’orario di lavoro, la settimana di 35 ore, la flessibilizzazione, le donne nel mondo operaio.
– In seguito le tematiche vengono affrontate in modo più vasto: i processi di cambiamento nella società, come le conseguenze dell’unificazione tedesca, gli attacchi più acuti del capitale, l’internazionalizzazione della strategia capitalista, la creazione del mercato comune “Europa 1992”, l’apartheid sociale ecc.
– Di volta in volta emerge il problema della nostra collaborazione nei movimenti e nelle organizzazioni politiche.
– Periodicamente ritorna il problema della fede nella nostra vita e nel nostro impegno speciale.
– Due o tre volte il collettivo si è occupato di documenti ecclesiali:
. La nota pastorale sulla disoccupazione (1983); e, in seguito, una discussione scritta con un vescovo ausiliare.
. L’attacco operato nei confronti della teologia della liberazione. Abbiamo mandato una lettera ai vescovi.
. A 100 anni dalla pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum.
– Il problema di una rinnovata descrizione del ruolo del prete è progressivamente sparito.
Ecco dunque il catalogo dei problemi e delle questioni elencate rapidamente. Il lettore vorrà naturalmente sapere quali siano state le risposte. Non abbiamo la possibilità di rispondere collettivamente a questa naturale curiosità. Ancora una volta occorrerebbe raccontare delle biografie.
Gli incontri sono soprattutto dei momenti di scambio; le risposte alle domande sono numerose e variegate come del resto le persone presenti. Le differenze a livello politico, ideologico, teologico, sono molto forti. Soprattutto nei primi momenti abbiamo corso il rischio della rottura dell’assemblea. Poco numerosi sono stati i tentativi di generalizzare, di arrivare a delle sintesi e alla loro pubblicazione. Molto pochi gli inviti rivolti a esperti che avrebbero potuto offrirci degli spunti di riflessione.
Di volta in volta emergeva il problema di una definizione più precisa del gruppo: chi può far parte del collettivo e chi no? È la storia che ha scritto la risposta. Il gruppo esiste. Continua a vivere. E perché le persone vengono? e ritornano? Fondamentalmente il motivo sta nell’interesse che ognuno ha per l’altro, per la sua storia e la sua evoluzione. Conta anche l’interesse di ricevere un incoraggiamento da parte dell’altro per poter continuare il proprio cammino.
2.2. I principali cambiamenti
Ciò che segue si limita a descrivere i cambiamenti avvenuti nel collettivo.
– Nel corso degli anni sono venute sempre più persone che non erano operai di fabbrica in senso stretto. Persone impegnate nei gruppi marginali. Il numero di coloro che lavoravano a tempo pieno in una fabbrica o in un’impresa di servizi diminuiva in rapporto agli altri. I più giovani di coloro che lavoravano in fabbrica hanno voluto che durante gli incontri ci fosse sempre un gruppo di lavoro e di discussione sui problemi della fabbrica e sull’impegno nella realtà industriale.
– Fin dall’inizio alcuni lavoratori di fabbrica hanno assunto alcune responsabilità nel quartiere in cui vivono. Costoro abitavano in comunità con persone senza fissa dimora o con una precaria situazione abitativa. Questo aspetto attualmente prende più spazio.
La stessa cosa va detta per l’impegno, a volte a tempo pieno, nelle organizzazioni o nelle istituzioni di marginali: disoccupati, tossicodipendenti, senza fissa dimora; ed anche nelle organizzazioni politiche come il movimento pacifista, la campagna contro le armi; ed infine i gruppi che si occupano dei prigionieri politici, dei rifugiati, degli extra comunitari, dei gruppi etnici perseguitati nei loro paesi e anche tra di noi come per esempio i curdi.
In tal modo il collettivo è un riflesso dell’evoluzione sociale per la quale una fetta sempre maggiore di popolazione viene marginalizzata. Questa mescolanza di interessi è risultata molto fruttuosa per il collettivo. L’impegno a senso unico nella fabbrica è stato problematizzato in modo naturale per la presenza di un’altra realtà sociale. D’altra parte il legame stretto, il processo di impoverimento sociale e le mutazioni delle imprese (parola chiave: “Lean production”) rimane ancora un dato di fatto.
– Quest’ultimo punto (i cambiamenti nell’industria) ha avuto le sue conseguenze all’interno del collettivo: la “deregulation” delle relazioni di lavoro produce la precarietà per non pochi dei partecipanti dei nostri incontri. Questo cambiamento è stato messo a tema in diversi incontri, come del resto anche la perdita di potere e di forza delle organizzazioni sindacali in questa situazione di crisi.
Il gruppo è diventato più internazionale. Il fatto che sono rappresentate tre nazioni (Austria, Svizzera, Germania) ha dato un carattere internazionale agli incontri fin dall’inizio. In questo senso vogliamo ricordare la partecipazione regolare degli amici francesi (Albert Mann, Alois Hornebeck). Ma è soprattutto la strategia globale delle imprese che ci spinge ad occuparci dell’internazionalismo come tema. Inoltre molti di noi sono attivi in organizzazioni internazionali che affrontano il problema delle imprese multinazionali nelle quali lavorano, a livello sindacale e ad altri livelli. Queste esperienze sono comunicate nelle riunioni ed esse assicurano un’apertura internazionale ai nostri incontri.
La presenza di PO stranieri ai nostri incontri è tanto efficace quanto la partecipazione del collettivo all’incontro dei PO d’Europa e soprattutto al grande incontro nazionale dei PO Francesi che assume un interesse crescente.
– E infine: il gruppo invecchia. La presenza dei capelli bianchi aumenta e con essi il numero di coloro che escono dall’impegno professionale. In parte costoro continuano le loro attività precedenti, e in più hanno del tempo per riflettere sul loro passato; altri iniziano nuovi impegni (per esempio un progetto nella foresta amazzonica); altri ancora rientrano nel servizio ecclesiale.
2.3. Temi di ricerca permanente
Oltre a quanto abbiamo comunicato fin qui, non c’è niente da aggiungere. Non c’è stata e non c’è tuttora una riflessione sistematica. Tuttavia c’è il perseverare nello sforzo di farsi carico delle sfide dei cambiamenti socio politici e di ricercare rinnovate forme di presenza nelle nuove realtà. Questo si realizza a livello personale, individuale, mettendo poi in comune le proprie decisioni.
2.4. Errori compiuti
Un collettivo di questo tipo, così colorato e così poco definito, non potrebbe compiere errori, in linea di principio; a meno di considerare questa assenza di precisione come l’errore fondamentale. Ma la maggior parte dei membri non la pensa così. Anzi!
Tuttavia ci sono delle carenze che certuni richiamano di volta in volta:
– mancanza di capacità e disponibilità nel fare una riflessione più sistematica, a livello politico e ideologico (cosa che noi non vogliamo affatto, dicono gli altri).
– assenza di lotte esterne a partire da prese di posizione assunte come collettivo (cosa da evitare assolutamente, dicono gli altri).
– carenza di coesione e di solidarietà durante gli incontri (ma noi non abbiamo bisogno di questo, dicono coloro che vivono in gruppo o in comunità).
2.5. Significato dell’esperienza di PO oggi
A questo proposito uno di noi scrive: «Per ora non ho altri obbiettivi che quello di “immergermi nel disordine” delle lotte della vita quotidiana o nella politica dalla parte degli impoveriti».
Ma su questo punto la penna del cronista deve bloccarsi almeno per ora.
3. OGGI E DOMANI
3.1. I nodi attuali
Proviamo ora a riassumere e completare ciò che abbiamo detto sino ad ora.
3.1.1. In relazione allo sviluppo della società capitalistica
– Nonostante che il sistema capitalistico sia sopravvissuto (ma non si tratta di una vera e propria vittoria) al confronto con il sistema socialista, esso mostra fenomeni di crisi radicali anche in nazioni ricche come la Svizzera, l’Austria e la Germania.
– La competitività sempre più acuta in atto nel mercato mondiale costringe le imprese a prendere delle misure sempre più brutali per diminuire i costi di produzione. In conseguenza di ciò aumenta nel settore pubblico e privato la richiesta di prestazioni sempre maggiori; si assiste poi alla distruzione dei diritti sociali acquisiti e dei diritti dei lavoratori. Sempre più gente fuori dalla fabbrica, sempre più lavoro per chi resta dentro. Questa è la linea generale.
– La conseguenza: un numero crescente di esclusi: la disoccupazione di massa è diventata un fenomeno strutturale. L’insicurezza pervade larghi strati sociali. Per molti giovani non esistono prospettive. Cresce l’indebitamento di molte famiglie e molti individui, ad Est come ad Ovest. Tutto questo caccia molte persone in situazioni disperate.
– La politica di cogestione portata avanti dai sindacati li priva del loro ruolo di contropotere sia in fabbrica che nella società.
– Una reazione sociale che si inquadra all’interno di questa evoluzione è il ritorno delle organizzazioni neo-fasciste (anche se nelle ultime elezioni, sono risultate perdenti). Ma il dato da sottolineare come il più inquietante è il crescere degli ideali nazionalisti e fascisti e dei comportamenti conseguenti in istituzioni statali come la polizia, l’esercito, nel campo della giustizia, negli ambienti universitari e in generale nella testa di non pochi cittadini.
Il considerare alla stessa stregua la dittatura di Hitler e la dittatura del comunismo di Stalin serve soprattutto a ridurre la gravità degli orrendi crimini compiuti dai fascisti. Tale situazione è alimentata ed accompagnata dalla passività e dalla paura della popolazione, che si rivelano soprattutto al momento degli attentati compiuti da bande di estrema destra.
– Lo stato, indebitato a sua volta, riduce i suoi interventi attraverso la privatizzazione delle istituzioni (poste, ferrovie, assistenza sociale, sanità…).
Per quanto riguarda la sicurezza di vita dei cittadini, si constata la nascita e la crescita di gruppi paralleli: polizia privata, gruppi di custodia quasi “paramilitare”.
– E tuttavia, nonostante che la crisi non scomparirà certo per lo sviluppo economico annunciato come forte ma rivelatosi lieve, la maggioranza della popolazione si trova bene in questo sistema capitalista. Per i più è assicurata la condizione materiale soddisfacente che procura una sorta di libertà di spostamento (viaggi, vacanze andando dove si vuole, nella misura in cui se ne hanno le possibilità), libertà di pensiero e di espressione. La maggioranza sente questo.
D’altra parte non esiste un movimento o un’organizzazione in grado di presentare un progetto alternativo di società e capace di realizzarlo. Questo progetto dovrebbe essere alternativo al capitalismo e allo stesso tempo capace di evitare tutti gli errori che la gran parte della popolazione ha vissuto sotto il sistema socialista.
– Malgrado ciò esistono dei fermenti in questa direzione, delle ricerche “a fuoco lento”, alcune piccole iniziative a livello locale. Le iniziative riformatrici dei verdi nei parlamenti regionali, al governo o all’opposizione; i risultati del PDS (ex SED ) nelle ultime elezioni regionali e nazionali, fanno sperare che la ricerca di un altro modello di società non sia del tutto abbandonata, quali che siano gli aggettivi con cui la si voglia caratterizzare: più democratica, più sociale, più ecologica, più socialista o tutto questo assieme.
In questa situazione in “ebollizione”, i membri del collettivo, vivono, sperano, lottano, secondo modalità differenti. Albert ha espresso questo come “vivere e lottare nel disordine delle lotte quotidiane”.
3.1.2. In rapporto alla Chiesa
Le chiese (cattolica e protestante) hanno in sostanza una posizione conservatrice, preoccupate dell’auto-conservazione.
Tuttavia negli ultimi tempi si possono cogliere nei rappresentanti delle chiesa dei segni che fanno sperare almeno un po’:
– Le organizzazioni caritative aiutano sempre più a svelare le dimensioni reali dell’impoverimento di gran parte della popolazione. Esiste un rapporto sulla povertà scritto dalla Caritas tedesca. Ha fatto molto scalpore. I cosiddetti partiti cristiani hanno fatto di tutto per impedirne la pubblicazione ma senza riuscirvi.
– Le due chiese stanno per pubblicare un documento comune sulla situazione socio-politica della nazione. Grazie ad alcune indiscrezioni, si è venuti a conoscenza di qualche testo preparatorio. Sicuramente la redazione finale del documento perderà molto quanto a forza e a chiarezza in confronto alle bozze preparatorie: il conformismo alle autorità politiche, che segna le due chiese, giocherà il suo ruolo. Ciò nonostante…
– Per quanto riguarda il campo dell’immigrazione, i rappresentanti delle chiese mostrano una certa solidarietà nei confronti degli extracomunitari. Si veda, per esempio, l’organizzazione “pro Asyl” molto attiva nella regione di Francoforte, presieduta da un prete diocesano. Si veda anche il fenomeno sorprendente di non poche parrocchie cattoliche e soprattutto protestanti che prestano asilo a persone minacciate di espulsione, alloggiandole negli edifici parrocchiali, e questo per settimane se non per mesi. Giuridicamente ciò non è corretto; ma finora la polizia non è intervenuta per sloggiare ed espellere queste persone.
– In generale la contestazione nelle chiese si limita ai problemi interni. Per esempio: la lotta per una conduzione più democratica delle chiese e inoltre, per quanto riguarda i cattolici: l’ordinazione sacerdotale delle donne, la proccupazione pastorale per i divorziati risposati, il problema dell’aborto.
3.2. Prospettive future
– Il clima generale, che si riflette naturalmente anche nel collettivo, non è certo caratterizzato dal grande evento del rinnovamento, come è successo negli anni 60/70.
– Per il futuro del collettivo dei PO questo significa che il numero dei preti o dei religiosi che fanno la scelta di lavorare non crescerà eccessivamente nei prossimi anni; al contrario, andrà verosimilmente diminuendo. Inoltre tra le vocazioni sacerdotali o religiose, si constata una tendenza più conservatrice e spiritualista. Uno di noi ha detto: “degli attuali seminaristi, nessuno farà la scelta di essere PO”.
– La maggior parte dei giovani non considera generalmente il mondo del lavoro come il luogo in cui potrebbe nascere un movimento di cambiamento. La classe operaia è sempre più ridotta, dispersa, parcellizzata e con lei anche i sindacati sono costretti a lottare in difesa. Il soggetto rivoluzionario, ammesso che ancora lo si cerchi, non lo si deve trovare qui o almeno non soprattutto o esclusivamente qui.
Tutto questo non toglie nulla dell’importanza fondamentale della classe operaia, della realtà economica come base della società e dei cambiamenti sociali. Ma la vita di fabbrica ha perso di fascino agli occhi dei giovani.
– Se è vero che la generosità rimane costante attraverso le generazioni, si pone il problema: dove si svolge l’impegno dei giovani preti in favore delle vittime dello sviluppo? Soprattutto nelle iniziative al di fuori delle fabbriche. In ogni caso è possibile che il collettivo riesca ad attirare qualcuno di questo gruppo.
– Tra di noi continua la ricerca sul “luogo autentico”, come l’abbiamo espresso attraverso un piccolo sketch durante l’incontro a Pommeaye. Vivere “con” (e non soltanto “per”) coloro che sono espulsi dall’attuale processo.
– In un certo senso a noi è chiesta la fedeltà. Anche se non si vivono nuove intuizioni o vocazioni in massa, il cammino incominciato deve essere continuato, con la maggior radicalità possibile, come un cammino di vita, che ci fa fondamentalmente contenti.
– La lotta con le vittime, lo stare dalla loro parte, questo è il nostro contributo per un mondo migliore. E questa sfida non ha perduto nulla della sua attualità.
Fritz Stahl
Mannheim 1 novembre 1994