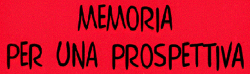
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1996
Alcune questioni di fondo
che mantengono intatta la loro attualità;
questioni indicate dai pretioperai
con la loro presenza in Italia e nel continente europeo
Premessa
Lo scorso anno ci eravamo dati questo appuntamento.
L’istanza emersa nasceva:
• dal bisogno manifestato di incontri nazionali ravvicinati per rendere più efficace la comunicazione tra di noi, a fronte di una situazione globale nella quale può essere fatale la “confusione mentale” e quindi l’impotenza al discernimento;
• dalla necessità di approfondire i contenuti e le finalità del nostro stare insieme a livello nazionale, prima ancora di scegliere gli strumenti operativi per una funzionalità del nostro gruppo.
Al Coordinamento Nazionale ed alla Redazione della Rivista era stato affidato il compito di preparare questo incontro, al quale si è dato un titolo chiaro e significativo: “Memoria per una prospettiva”.
Nel corso dell’anno ai singoli PO sono pervenuti degli strumenti di lavoro, il cui obiettivo era di stimolare la reazione e le riflessioni personali e dei gruppi locali. A me è stato affidato il compito di aprire questo incontro: indico subito l’articolazione dei lavori come è stata prevista; successivamente proporrò alcune brevi considerazioni suggerendo alcuni punti che ritengo utili al lavoro di questi giorni.
Articolazione dei lavori
In questo pomeriggio si intende offrire un sintetico, ma robusto, input iniziale in funzione dell’attività dei gruppi. A questo intervento di apertura seguiranno due contributi diversi, ma correlati. Riteniamo che proprio dalla loro creativa correlazione, nella recezione ed assunzione da parte dei partecipanti, dipenda in gran parte la fecondità di questo convegno.
• Il primo contributo offrirà una rilettura del nostro cammino, non come rievocazione, ma come memoria viva di quanto abbiamo vissuto e pensato a partire dall’impatto diretto con la condizione materiale di lavoro che ha determinato la svolta radicale nella nostra vita. La convinzione è che in questo crogiolo ha preso corpo un nucleo vitale la cui valenza mantiene ancora la piena ragion d’essere, pur in presenza delle modificazioni intervenute nel corso della nostra vita personale e nelle condizioni socio-politiche ed ecclesiali che oggi ci troviamo ad affrontare. Questa rilettura è stata curata dalla Redazione della Rivista.
• Il secondo momento prevede l’offerta di una griglia utile a contestualizzare il discorso sui processi economici e politici, la cui influenza è pesantissima non solo sulle condizioni di vita a livello mondiale e nazionale, ma anche sul futuro che si prepara per le nuove generazioni. Qualunque sia la condizione esistenziale,, il lavoro o il ministero in cui ora siamo impegnati, si ritiene assolutamente doveroso lo sforzo intellettuale per una lettura onesta della situazione globale nella quale siamo immersi, dalla quale non possiamo sottrarci con uscite di sicurezza sul fronte personale o religioso. Questo intervento è stato preparato dai PO milanesi.
Al termine delle relazioni ci sarà uno spazio per interventi integrativi o per richiesta di chiarimenti.
Pensiamo che, nelle condizioni nelle quali ci troviamo, la confusione sia il primo nemico da battere. Da questo lavoro comune ci ripromettiamo una migliore chiarezza in vista di scelte responsabili. Contestualmente la chiarificazione non è solo un processo mentale; essa è strettamente dipendente dall’azione nella quale responsabilmente si sta impegnando la propria esistenza.
• Il lavoro di gruppo è lo spazio nel quale si dovrebbero raggiungere i seguenti obiettivi:
— dare a ciascuno la possibilità di comunicare sul piano personale quello che ritiene più importante riguardo alla propria esistenza; confrontarsi seriamente sui contenuti offerti dalle relazioni tentando approfondimenti e focalizzando convergenze e diversità di posizioni;
— posto che ciascuno ricopre un proprio ambito di attività, anche con rilevanti diversificazioni interne, posto anche che i PO si ritrovano a livello regionale o locale con metodologie o campi di ricerca autonomi, mettere in luce il senso e il valore che nella attuale fase storica si riconosce al collettivo nazionale dei PO e gli obiettivi che si ritengono concretamente perseguibili;
— in subordine, valutare gli strumenti operativi e le risorse disponibili al servizio del collettivo medesimo.
• Nell’assemblea verranno riportati sinteticamente i contributi e le indicazioni dei singoli gruppi per arrivare a definire le scelte, il percorso futuro e gli strumenti.
Un patrimonio da non dilapidare
Le riflessioni che seguiranno non sono sintesi di un lavoro comune, anche se, ovviamente, attingono dal nostro contesto. Sono per lo più un contributo personale, esprimendomi in metafora, per …riscaldare i muscoli e avviare il volano di questo incontro. È un compito che mi è stato affidato e come tale accoglietelo. La mia intenzione è quella di indicare alcuni punti di riflessione, a mio avviso importanti, senza alcuna pretesa di completezza.
Sì, penso che la nostra vita, la nostra storia e la nostra attuale esistenza siano un patrimonio. Non solo perché la vita di ciascuno è custodita come “la pupilla dell’occhio” da Colui che ha cura perché anche la piccola fiammella non si spenga, ma come realtà collettiva che ha preso forma in questo mezzo secolo.
Il fatto che nell’Europa “cristiana” e “capitalista”, in un certo momento storico, centinaia di preti (cioè di persone preparate e programmate ad investire tutte le loro risorse ed energie in un ruolo sociale che coincide con una missione trascendente) decidano – ciascuno con decisione individuale – di cambiare radicalmente la struttura materiale della propria vita, assumendo la condizione di lavoro manuale e/o dipendente, in maniera permanente, come per tutti gli altri/e …fino alla pensione, o alla Cassa Integrazione, o al pre-pensionamento, o alla morte…, questo non è un fenomeno, la cui valenza essenziale possa essere semplicemente liquidata dalla storia, meglio, dai vincitori della storia. Mi ha colpito la considerazione di un PO belga: “per la prima volta nella storia, dei preti condividono la condizione abituale di donne e uomini del popolo, senza privilegi, senza diventare notabili”.
Al primo posto va messo l’evento che va colto come fenomeno globale, con una sua valenza oggettiva: un fatto che può essere legittimamente soggetto a più interpretazioni, non solo da chi lo consideri da esterno, ma anche da parte degli stessi protagonisti. Il numero monografico dello scorso anno sui pretioperai in Europa mi sembra che abbia ben evidenziato l’unità e la forza del fenomeno e la differenziazione nella interpretazione, legata al diverso humus culturale e teologico, alla storia nazionale o locale, alle tradizioni delle comunità cristiane, alle caratteristiche ed evoluzione del tessuto produttivo e del movimento operaio e soprattutto alle peculiarità dei soggetti concreti che in un certo territorio hanno dato corpo a quell’evento. Analoghe considerazioni valgono per la realtà italiana.
Diciamo che quello che rende unitario il fenomeno è l’ortoprassi: cioè il vincolo stretto tra vita vissuta nella concretezza quotidiana del lavoro e la fede vissuta da chi porta sulle spalle il “peso” di essere prete: una figura sociale carica di storia, di disciplina, di teologia e spiritualità, con un forte senso di una “missione” da compiere; ma anche carica di ideologia, di politica, di appartenenza ad un gruppo separato, con problemi mai apertamente e liberamente affrontati e dibattuti.
La mia convinzione è che la nostra comparsa in questo mezzo secolo di storia europea corrisponda ad una parabola evangelica, che mantiene intatto il suo valore, un valore indicativo, attraverso e oltre la caducità della nostra biografia di uomini. Questa parabola, sia pure con tutte le sue contraddizioni – un atomo sulla bilancia sul piano del potere fisico di pressione – rappresenta un indicatore di eventi grandi ed anche drammatici, le cui conseguenze sono ben lontane dall’essere adempiute. Un indicatore è un segnale; è in relazione con altri eventi di più estesa portata. La sua forza consiste nel segnalare fedelmente qualcosa d’altro. Per un indicatore vivente significa che la stessa esistenza è attraversata dal messaggio, anzi, diventa essa stessa messaggio. Dunque, il PO è indicatore di che cosa? Sottolineo tre nodi che, a mio avviso, portano con sé un carattere epocale. Sono solo accenni di capitoli grandi.
Urgenza del rinnovamento del cristianesimo storico
Il Vaticano II ha segnato con evidenza la crisi di un modello univoco e uniforme di cristianesimo cattolico, geloso e blindato nei suoi spazi di salvezza garantita. Il problema balza con evidenza da rapporti ormai necessari con i quali è impossibile non fare i conti. Per brevissimi cenni:
• con il mondo moderno uscito dall’illuminismo, quindi con l’autonomia della ragione in ordine a tutti gli ambiti della vita; ma anche con la crisi della ragione stessa e con le perversioni e le disumanità che il suo uso distorto ha provocato nella storia;
• con le altre Chiese cristiane, con la transizione dall’antagonismo escludente al riconoscimento, anche se parziale, della valenza intrinseca di cui esse sono portatrici e che la fede professata è costretta ad ammettere; in sostanza si è cominciato a riconoscere che i confini della salvezza non si identificano con quelli visibili della Chiesa cattolica. Il Dio creduto è oltre: oltre le Chiese, oltre le religioni, perfino oltre la dimensione laica della vita…
• con le culture di popoli e continenti che resistono ad un semplice processo di colonizzazione occidentale, culture che anzi arrivano a noi operando una certa “contaminazione”, ponendo confronti…
• con la presenza di colossali strutture finanziarie e produttive dalle quali ormai dipendono in grandissima parte le condizioni di vita e di sopravvivenza dell’intero genere umano, che condizionano i governi di qualsiasi paese e che impongono, tout-court, un assetto economico – e la connessa industria culturale – quale punto di arrivo, traguardo senza ritorno, della storia stessa.
Sono solo alcuni flash per arrivare al punto che qui ci interessa, cioè a dire che il modello secolare di cristianità (vedi Miccoli G., in Pretioperai, 28-29 /1994 pp.15-26: qui), cioè quel “modello di presenza cristiana che fu storicamente dominante…, che ha come sua irresistibile tendenza e aspirazione di fondo la traduzione dell’annuncio del messaggio in strutture organizzate”, con tutte le flessibilità, varianti ed adattamenti che ha conosciuto nella storia, sembra essere entrato in crisi. Anche i tentativi di riproposizione sembrano votati al suo fallimento sostanziale, nel senso che è un modello non più vitale, privo di una sua interna credibilità.
Tale modello storico di cristianità “il cui impianto concettuale e operativo è espressione e frutto di una teologia politica, ma anche di una ecclesiologia, di un’antropologia, di una visione del mondo e della storia…” è entrato in crisi non solo per cause esterne, ma anche perché trova nell’Evangelo stesso l’istanza critica di base.
Una pagina che ci ha richiamato Miccoli nel Convegno promosso da Pretioperai e da altre Riviste conserva una permanenza di attualità impressionante. Nel testo della perfetta letizia, nella sua versione originale e completa, “si delineano due condizioni esistenziali, di modi di essere e sentire, nettamente contrapposte… Il ‘sequi vestigia Christi’ (seguire le orme di Cristo) per Francesco non si realizza attraverso i trionfi della fede e dell’ordine, ma nell’accettazione piena della logica della croce; trova il suo sigillo di fedeltà ed ha il suo fondamento in una logica e in criteri di giudizio e di comportamento radicalmente diversi da quelli consueti nella quotidianità della storia e nella costruzione della società umana… In alternativa esemplare sulle tendenze della Chiesa e della società del suo tempo, Francesco propone l’affermazione di una presenza cristiana, incarnata nella storia, perché questa è la sua condizione e la condizione della sua visibilità, che però non ha per la storia altro progetto che non sia quello di restare se stessa, segno di ‘cieli nuovi e terre nuove’, che per essere tale (segno) non può ricorrere agli strumenti del potere, della forza, del successo per realizzarsi”.
“Che cos’è vera letizia”
“…Un giorno il beato Francesco a Santa Maria chiamò frate Leone e disse: Frate Leone, scrivi. Ed egli rispose: Sono pronto. Scrivi – disse – cos’è vera letizia. Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell’ordine; scrivi: non è vera letizia. E così pure tutti i prelati ultramontani, arcivescovi e vescovi; ed anche il re di Francia e il re d’Inghilterra: scrivi, non è vera letizia. E ancora, che i miei fratelli sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede; e ancora, che ho da Dio tanta grazia, che sano gli infermi e faccio molti miracoli; io ti dico che in tutte queste cose non vi è vera letizia.
Ma cos’è vera letizia? Torno da Perugia e in piena notte arrivo qui e il tempo d’inverno è piovoso e molto freddo, al punto che dei pendagli di acqua ghiacciata si formano all’estremità della tunica e percuotono continuamente le gambe, e sangue esce da tali ferite. E tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio vengo alla porta e dopo che ho bussato e chiamato a lungo arriva un fratello e chiede: Chi è? lo rispondo: Frate Francesco. Ed egli dice: Vattene; questa non è un’ora decente per andare in giro; non entrerai. E alle mie insistenze egli replica: Vattene, tu sei un semplice ed ignorante, non hai da venir da noi; noi siamo tanti e tanto importanti (“tot et tales”) che non abbiamo bisogno di te. Ed io continuo a starmene alla porta e dico: Per amore di Dio accoglietemi per questa notte. E lui risponde: Non lo farò. Vattene all’ospizio dei Crociferi e domanda là. lo ti dico che se avrò avuto pazienza e resterò calmo, che in questo è la vera letizia e la vera virtù e la salvezza dell’anima” (Opuscula sancti… Francisci, ed. C. Esser, “Bibliotheca franciscana ascetica…“, XII, Grottaferrata (Roma) 1978, p. 324).
Cito Francesco non certo per istituire un improbabile raffronto tra lui e noi, ma per affermare che il problema è antico e perché un tale input ci consente di ragionare in termini ampi ed epocali. Ci aiuta cioè ad andare oltre la nostra biografia o la nostra interna dialettica, per cogliere ed apprezzare una vera alternativa, culturale, esistenziale e teologale che investe il senso stesso del cristianesimo ed i modelli della sua incarnazione nella storia.
Mi sembra di poter affermare che l’ingresso e soprattutto la permanenza in condizione operaia, abbiano definitivamente segnato il nostro addio al modello della cristianità, peraltro in anni nei quali questo era il modello vincente. All’esterno il segnale è stato letto e riconosciuto. Un addio, da parte nostra, non solo intellettuale, ma concreto, fatto di prassi e di vita. Ecco, il preteoperaio indica con il suo stesso nome – ma il nome è il risultato di storie vissute – l’abbandono di un modello di cristianità e l’incarnazione di una modalità alternativa di esistere da cristiani e preti nel mondo.
La forza delle cose
Se prendiamo un campione rappresentativo di operai/e e lavoratori/ici dipendenti con le nostre classi di età e lo confrontiamo con noi ci accorgiamo che in moltissime cose è possibile una sovrapposizione. La loro storia di lavoro, o di espulsione dal lavoro, assomiglia alla nostra. Un riuscito processo di assimilazione…
Ecco. Abbiamo scoperto la forza della materialità della vita, cioè delle condizioni concrete nelle quali essa trascorre: l’intervallo tra l’ingresso e l’uscita dal posto di lavoro, la stanchezza fisica e psicologica, l’esperienza di essere un numero, di diventare un esubero, la concretezza dell’essere sulla stessa barca con altri compagni di lavoro, il desiderio e il timore della pensione… soprattutto il sentire che altri hanno il potere di costringerti a dispetto delle tue ragioni… Abbiamo provato il costo elevato della libertà di pensiero, di parola…
Proprio questi lunghi anni vissuti ci possono aiutare a capire quello che sta accadendo sulla pelle di generazioni di persone a livello mondiale, ci hanno resi sensibili ai significati ed ai trabocchetti del linguaggio usato (carità – giustizia – solidarietà…), alla mistificazione che avviene quando il linguaggio etico occulta, invece che rivelare, la realtà strutturale e le grandi decisioni politiche. Ci siamo resi conto della vacuità di un messaggio cristiano che non sa o non osa andare oltre il moralismo. A me sembra che il PO sia e debba essere un indicatore di un fatto semplice: la dimensione spirituale della persona avviene dentro la materialità della vita. Tanto che le costrizioni materiali possono annientare, e annientano di fatto, quell’unicità per la quale ciascuno è se stesso. In sostanza vi è una dimensione politica del vivere che non può essere rimossa, pena la caduta nella falsa coscienza e la conseguente mistificazione del linguaggio. Tale dimensione noi l’abbiamo appresa partecipando dall’interno al movimento operaio. La crisi del movimento sul piano della progettualità e dell’efficacia della lotta, a fronte della “dittatura del libero mercato” e del “declino della forza lavoro”, non possono giustificare la rimozione di questa realtà strutturale; tanto meno deve indebolirsi la nostra attenzione al bisogno di giustizia ed all’analisi delle cause che concretamente producono ingiustizia. Rimandando al successivo intervento dei milanesi, mi limito qui a richiamare un testo significativo presentato da Sandro al convegno dello scorso anno:
L’efficacia non si identifica solo con la vittoria.
Rileggendo la storia di tanti movimenti di ‘liberazione’ e del loro esito, viene a tutti da pensare alle tante vite spese nel progettare e nel costruire un progetto, che, non essendosi realizzato, appare fallito agli occhi di tutti.
Siccome la ‘vittoria’ alla lunga è andata ad altri, si potrebbe quindi concludere che tutto ciò che è stato fatto, essendosi rivelato inefficace è stato inutile.
Ma è possibile leggere in altro modo la storia complessiva di tutti questi multiformi tentativi di generare azioni politiche buone, e scoprire che una loro efficacia l’hanno comunque raggiunta. Soprattutto provando a pensare che cosa sarebbe stata la storia se essi non ci fossero stati.
Il flusso freddo che percorre la storia dell’umanità è contrastato dalla presenza, continuamente risorgente, di queste correnti calde che, or qui or là, irrompono sul palcoscenico del mondo. Esse si richiamano tra di loro, e pur non avendo vinto in nessun posto, la loro efficacia sta nel non essere mai state sconfitte del tutto e per sempre…
Inserire la propria vita in questa ‘corrente calda’ vuol dire lavorare per offrire agli umani di tutti i tempi una possibilità dignitosa di senso non alienato per la loro vita. Che altrimenti non sarebbe dato. Che è poi la loro dimensione trascendentale” (Pretioperai 32-33/1995, p.30).
Il coraggio della verità sul ministero
A me non pare siano stati i pretioperai, con le loro pratiche e le relative elaborazioni, ad inventare la crisi dei ministero ordinato. Caso mai il nostro è stato un tentativo, credo onesto, di uscire da una condizione ministeriale percepita come non autentica. La crisi viene da più lontano. Su questo punto lascio la parola a Giuseppe Dossetti, un testimone certamente non sospetto: “la crisi del clero e delle vocazioni sacerdotali e religiose, (era) certamente già iniziata in quasi tutti i paesi europei nel dopoguerra, prima ancora del Concilio, anche se si è manifestata in modo conclamato dopo il Concilio. È forse questo il punto sul quale, perciò, insiste con una apparente maggiore verosimiglianza la critica anticonciliare. Mi permetto, però, di ribadire la mia idea: e cioè che anche per questa crisi erano già in atto prima del Concilio le cause profonde e determinanti
Dossetti G., Il Concilio Ecumenico Vaticano Il, ed. S. Lorenzo, p. 8.
L’autore continua: “Posso al riguardo riferire un episodio. Quattro giorni prima dell’apertura del Concilio, fui ricevuto in udienza da Paolo VI, eletto da tre mesi, per riferirgli ed illustrargli le modificazioni al regolamento del Concilio, che aveva proposto tramite il card. Lercaro, per correggere lacune e imperfezioni rivelatesi durante la prima sessione. Esaurito felicemente l’argomento, accorgendomi che il Papa disponeva ancora di qualche momento per me, ne approfittai per parlargli di quella che consideravo la questione assolutamente più fondamentale in quel momento: cioè appunto le difficoltà crescenti che colpivano, a mio avviso, molta parte del clero, e che costituivano la causa più grave del declino delle vocazioni sacerdotali e religiose in Europa e anche in altre parti del mondo. Paolo VI mi ascoltò molto interessato e pensoso”…
Attualmente il panorama è sotto gli occhi di tutti.
Venendo a noi, in Italia non è stato riconosciuto il ministero dei PO dall’episcopato italiano. Vi è chi ricama sugli errori di tattica e strategia da parte nostra. Senza negare pregiudizialmente tali errori, io credo, invece, che i problemi di fondo effettivamente siano stati altri:
1. la nostra non affidabilità politica quando fare quadrato attorno alla Democrazia Cristiana era un dogma pratico;
2. il rifiuto da parte dei dirigenti della Chiesa di un modello di ministero ordinato, percepito come “alternativo” o sovversivo rispetto a quello che viene perseguito come ideale e previsto dalla disciplina;
3. l’autonomia complessiva (economica, sindacale, di pensiero…) che ha preso corpo in noi.
Anche sul piano del ministero ordinato, io penso che il PO sia indicatore della crisi del prete e della necessità di un ripensamento globale dei ministeri e del ministero ordinato nella Chiesa al servizio del mondo. Che significa un ministero ordinato in un cristianesimo storico senza il modello e l’ideale della cristianità? Cioè senza il modello ideologico che per secoli ha plasmato e incapsulato questa figura ministeriale? Alcune indicazioni preziose che vengono dalla pratica dei PO sottolineano:
— l’inserimento diretto del ministro ordinato nella realtà mondana mediante il lavoro;
— la condivisione delle stesse condizioni di vita, delle medesime lotte, successi e sconfitte; — un’esistenza che scopre la propria identità “nell’esistere-per-gli-altri”, non inseguendo un’essenza ricercata nell’avvitamento su se stessi
Cfr. la lettera scritta da Bonhoeffer il 21 luglio ‘44, il giorno dopo il fallito attentato ad Hitler di cui riporto uno stralcio. Resistenza e Resa, Paoline, p. 446: “Quando si è completamente rinunciato a fare qualcosa di noi stessi – un santo, un peccatore pentito o un uomo di chiesa (una cosiddetta figura sacerdotale), un giusto o un ingiusto, un malato o un sano – e questo io chiamo essere-aldiqua, cioè vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi e degli insuccessi, delle esperienze e delle perplessità – allora ci si getta completamente nelle braccia di Dio, allora non si prendono più sul serio le proprie sofferenze, ma le sofferenze di Dio nel mondo, allora si veglia con Cristo nel Getzemani, e, io credo, questa è la fede, questa è la metànoia, e così si diventa uomini, si diventa cristiani (cf. Geremia 45).
— la parola trova il proprio spessore, il proprio “essere carne”, nel contatto con la dimensione “materiale” della vita;
— superamento dello sdoppiamento delle due sfere: tra quello che si fa dentro il perimetro religioso e quello che si fa dentro il mondo;
— la dimensione della gratuità nell’esercizio del ministero, resa possibile dall’autofinanziamento assicurato dal lavoro;
— annullamento della separazione tra fede e vita, qualificata dal Vaticano II come uno dei più gravi errori del nostro tempo;
— la contemplazione vissuta nelle stesse condizioni materiali di chi lavora.
Questi elementi – altri ancora se ne potrebbero aggiungere – che incontrano tra di noi una sostanziale condivisione, non portano con sé delle valenze vitali, cariche di futuro, nella figura del mondo che si sta profilando?
Nel frammento… il compimento
Penso che ciascuno di noi ha vissuto, o vive, l’esperienza della frammentarietà della nostra vita. Citando Bonhoeffer, si può dire che vi sono dei frammenti che diventeranno spazzatura, altri invece lasciano balenare il disegno di una certa completezza.
Interrogandoci su una “prospettiva” che sia consanguinea con la “memoria” mi viene da suggerire tre spunti che, mi pare, indichino dei percorsi:
— dentro la storia umana: vi riporto un testo di Gianni Tognoni, rivolto circa 10 anni fa a noi PO della Lombardia:
“Essere pretioperai significa condividere la situazione dì tutti coloro che, nella loro microstoria, sono portatori di un’idea molto grande, tale da sfidare le regole della macro-storia. La scelta… è quella tra vivere questo stato di sproporzione o come ‘minoranza lievito’, o come ‘pretesa’.
• La minoranza-lievito è quella che trova in sé la giustificazione profonda, naturale, totale, di quello che si è;
• la pretesa è quella che, in un modo o nell’altro, dipende da un riconoscimento esterno, da un’istanza non necessariamente identificata, per poter vivere con pienezza di significato.
Essere portatori – nella microstoria – di una grande idea, coincide con l’essere membri e nodi di un popolo che ha come caratteristica quella dell’esilio, e perciò della nostalgia.
Questo popolo di esiliati – o di guerriglieri di una lotta di liberazione – è quello che fa la storia nel suo significato più essenziale, perché ne rivela il senso: cioè l’incompiutezza ed insieme il rischio, la tentazione, la violenza, di cancellare la nostalgia, il cammino in avanti.
Anche se li rimangia, la storia sarebbe deserta senza questi esiliati portatori dì nostalgia.
Perché essi dicono la storia che vorremmo vivere… ” (Pretioperai, n.0, p.65: qui).
— nella Chiesa: questo secondo spunto viene da un’associazione tra una mia esperienza personale e la narrazione del De vera laetitia. Quando all’inizio degli anni ‘70 ho iniziato il lavoro in ospedale psichiatrico, il numero 2 della diocesi mi disse: “tu sei inutile alla Chiesa!”. In fondo aveva ragione, dato che l’ipotesi di lavoro al quale riferiva l’utilità era una Chiesa organica al regime di cristianità. In tutti i casi da quei livelli, anche in questi anni, il messaggio che ho continuato a percepire è quello dell’inutilità. Mai una interrogazione su quello che posso aver capito della vita in 24 anni di attività lavorativa! Il fatto che lavoro o è un tabù o è semplicemente rimosso o forse altro ancora; in tutti i casi quel pezzo di vita non deve neppure essere nominato.
Non nego la permanenza in me di una certa ruggine, una sorta di reazione allergica… Forse non sono l’unico in questa compagnia ad essere affetto da una tale sindrome.
La nuova lettura del De vera laetitia mi ha offerto una illuminazione importante.
Nel racconto, a frate Francesco che chiede di passare la notte in convento, il fratello portinaio risponde: “Vade, tu es unus simplex et idiota; admodo non venis nobis; nos sumus tot et tales, quod non indigemus te”. (“Vattene, tu sei un semplice ed ignorante, non hai da venir da noi; noi siamo tanti e tanto importanti che non abbiamo bisogno di te”).
Nel rifiuto ricevuto, e nella sua serena accettazione, Francesco individua la “vera laetitia et vera virtus et salus animae”. In questa perfetta letizia abita la pratica di una suprema libertà nell’ambito
delle relazioni interecclesiali.
— nel segreto di Dio: solitamente quando si fa riferimento al profetismo biblico viene sottolineata la parola penetrante e forte che discerne la verità negata dall’oscurità e dall’ingiustizia della storia. Rivedendo il nostro cammino, spesso abbiamo trovato ispirazione in questa parola, optando decisamente, per così dire, per il modello “profetico” rispetto a quello “sacerdotale”. Non è certo un caso che una tale dialettica attraversi l’intero libro della Bibbia.
Vi è un altro aspetto del profetismo che ha un forte rilievo, tanto da diventare il criterio principe per le prime comunità cristiane alle prese con l’interpretazione della sconfitta, della condanna e dell’abbandono da parte di Dio subìti da Gesù di Nazareth nella consumazione degli eventi storici. In Geremia, nei carmi del Servo di Jahvé, in Ezechiele… la parola attraversa dolorosamente l’esistenza di chi la pronuncia provocando lacerazioni, gettando questi soggetti in situazioni di dura contraddizione. Si può dire, per citare un libro che descrive il pensiero di Simone Weil, che la condizione del profeta è quella di “abitare la contraddizione”. A Geremia Dio dice: “E tu vai cercando grandi cose per te? Non le cercare… io ti darò come bottino unicamente la tua vita ovunque tu vada” (c. 45). Come dire che nulla è garantito, se non la nuda vita, della quale anche i capelli sono contati.
Può perfino succedere come a Giona che, reduce da un viaggio di cui non capiva il senso e con una profezia sentita estranea – la profezia va oltre chi la pronuncia – si aggrappa ad una pianta di ricino da cui ricevere sollievo nel deserto. Ma nel deserto si secca anche quella. Di fronte alla morte invocata si chiarisce quel paradossale cammino, forse non ancora ultimato, con le parole della misteriosa Guida.
Conclusione
«Una voce dice: “Grida!” e io rispondo: “Che dovrò gridare?”» (Is. 40, 6).
Già, c’è una parola che dobbiamo gridare? Ce n’è una, anche una sola, che spetta assolutamente a noi insieme? Qual è?
A noi che siamo qui per cercarla può essere utile l’avvertimento di Sirio che troviamo nell’editoriale del n. zero di Pretioperai:
“Ciò che conta è essere una voce che grida: se poi questa voce che grida si perdesse nel deserto non ha poi tanta importanza. Anche perché i pretioperai ci sono abituati”.
