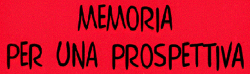«Sono venuto da voi con amicizia e con piacere»
di Paul Bernardin, segretario dei PO francesi
Cari amici, prima di tutto voglio rivolgervi i miei più sinceri ringraziamenti per il vostro amichevole invito, per la vostra gentile accoglienza e per la vostra simpatia prima e durante questo vostro Convegno. Già l’anno scorso avrei voluto venire al vostro incontro, qui a Salsomaggiore.
In questi anni, durante i quali ho prestato il mio servizio come segretario dell”équipe nationale” dei PO francesi, la scoperta dell’esistenza dei pretioperai in Italia, mi ha procurato un grande piacere e una grande gioia. Per questo sono venuto da voi, non per dovere, ma per amicizia e con piacere. Anche perché sapevo di poter incontrare di nuovo alcuni di voi, e in modo particolare Mario Pasquale, che ho conosciuto negli incontri di Pentecoste:
– a Dammarie, in Francia, nel 1985 e nel 1988
– a La Pommeraye, nel 1991 e nel 1994
– a Setubal, in Portogallo, nel 1993
– a Waterloo, in Belgio, nel 1995.
E dobbiamo rivederci di nuovo quest’anno, alla fine di maggio, a Roma.
Inoltre ho avuto il piacere e l’onore di essere accompagnato dal mio famoso e simpatico predecessore, il vostro “amico fedele” Jean Perrot. Ma non è vero che è lui che porta le valigie, le porto io stesso!
Le vostre ricerche e i vostri dibattiti “Memoria e Prospettive”, o piuttosto “Memoria per Prospettive”, non ci sono del tutto ‘estranei’. Come diceva all’inizio del Concilio uno degli osservatori invitati da Papa Giovanni: «Res nostra agitur!”.
Proprio l’anno scorso abbiamo fatto anche noi, in Francia, due seminari:
• uno a maggio, a Chantilly, vicino a Parigi, con la partecipazione di 35 PO;
• l’altro in dicembre a Francheville, vicino a Lione, con la partecipazione di 65 PO, su un tema molto vicino al vostro: “Prètres ouvriers, une intuition qui demeure, des trajectoires qui changent”, perché la società e la classe operaia sono cambiate molto, è cambiata anche la Chiesa dal tempo del Concilio, e cambiamo anche noi in questi anni!
Con il secolo 21° e il terzo millennio, arriviamo a un’altra tappa della storia. E tutti dobbiamo, dall’una e dall’altra parte delle Alpi, e con gli amici del Piemonte, ma ciascuno al suo posto di lavoro e con il suo ritmo, cercare, innovare, andare avanti per un servizio umile e fedele del Vangelo sempre nuovo, sempre buona novella, sempre “grande gioia per tutto il popolo”! (Lc.2,10).
Come ha scritto bene uno di voi:
“La memoria non può continuare ad essere semplice rievocazione di come eravamo… La memoria deve diventare attiva, capace di alimentare presente e futuro. Spingendoci a reagire e non a subire passivamente gli eventi… Aiutandoci a dotarci di un quadro mentale d’interpretazione di questa realtà che apra prospettive di cambiamento”.
A questo proposito voglio dirvi che ci interessa molto la vostra bella rivista “Pretioperai”, della quale siamo alle volte un po’ gelosi, benché ci siano dentro alcuni articoli dei quali si potrebbe dire, come confessava san Pietro a proposito delle lettere di san Paolo: “Ci sono dei punti difficili da capire…” (2Pt.3,16).
Mi dispiace sempre sentire qualcuno di noi, quando parla dei pretioperai degli altri paesi, dire: “stranieri”. L’ho detto nel mio discorso di accoglienza a La Pommeraye, due anni fa per il nostro ultimo Convegno nazionale: “Fra noi pretioperai, per motivi di solidarietà operaia come di fede, non ci sono stranieri!” (Cfr. Gal.3,28).
Poco tempo fa, quando parecchi emigrati africani sono stati cacciati fuori da una chiesa di Parigi dalla polizia chiamata, per nostra vergogna, dal parroco stesso e dal cardinale arcivescovo di Parigi, abbiamo avuto un’occasione imprevista, anche se molto spiacevole, di riferirci pubblicamente alle parole chiarissime e forti del Papa Giovanni Paolo (benché non siamo sempre d’accordo con tutto ciò che dice): “Nella Chiesa nessuno è straniero, e la Chiesa non è straniera a nessun uomo e in nessun luogo”.
Mi sembra che su questo punto dobbiamo essere tutti solidali e fermi, specialmente in questo periodo della nostra storia.
Permettetemi di fare mie, come militante operaio, ma anche come cristiano e preteoperaio, queste righe di san Paolo – del quale porto il nome dal giorno del mio battesimo – quando scriveva ai Romani che chiedeva da molto tempo al Signore:
“che finalmente mi si offra secondo il volere di Dio una bella occasione di venire da voi. Desidero infatti ardentemente di vedervi, allo scopo di provare in mezzo a voi la gioia e l’impulso derivanti dalla fede comune, vostra e mia” (1Rom.1,10-11).
Cammina sempre con noi il Cristo risorto, ma spesso succede che “i nostri occhi sono incapaci di riconoscerlo” (Lc. 24,16).
Non dimenticherò, infine, che la data di questo incontro è stata scelta bene, poiché coincide con la vittoria dell’Ulivo, che porta avanti tutte le vostre speranze e le vostre lotte, anche se questa vittoria non porterà sulla vostra terra italiana la pienezza del Regno di Dio. Ve lo dico basandomi sulla nostra amara esperienza francese. Durante tutti questi ultimi anni la sinistra era al governo, ma non è riuscita a “cambiare la vita”, come speravamo!…
Grazie a voi tutti! Ciao, amici e fratelli!
«Non presentarci in abiti di lutto»
Contributo dei PO piemontesi
1. Come siamo cambiati.
1.1. Umanizzazione: perdita di una situazione di «centralità»; riscoperta dei propri limiti umani; assoggettamento a condizioni di durezza di vita non solo fisica, ma morale, nella «obbedienza» imposta dal lavoro, dai suoi ritmi, dai rapporti e dalle situazioni di dipendenza che produce.
1.2. La fede: ricerca di essenzialità e di aderenza alla vita. I «gesti religiosi» diminuiscono in quantità, ma acquistano in peso e significato: nascono dall’esigenza di esprimere nella preghiera l’esperienza di vita e, soprattutto, dalla coscienza viva della presenza e dell’azione dello Spirito nella storia che viviamo insieme ai poveri di cui abbiamo voluto condividere vita, speranze, lotte, delusioni, sconfitte…
Tutto questo diventa oggetto di preghiera, per ritrovare nella quotidianità l’obbedienza alla Parola di Dio: fede vissuta nella «secolarità», fuori dagli «spazi sacri».
1.3. Rendere conto: esigenza di superare l’illusione che tutti stiano a sentirci solo perché siamo pretioperai: nella stessa classe operaia abbiamo sperimentato umiliazioni e incomprensioni che ci hanno aiutato a non correre il rischio di cercare nella fabbrica o nel movimento operaio quella «centralità» che abbiamo perduto nelle istituzioni di chiesa. Anche in classe operaia ci siamo trovati non di rado ad essere «voci nel deserto». Non possiamo neppur dire di aver avuto grossi «riscontri» alla nostra presenza: qualche interrogativo suscitato, molta curiosità: ma passava di lì la nostra evangelizzazione?
La speranza in Cristo ci ha sostenuti, non la pretesa di enumerare pretesi o reali successi: molto spesso abbiamo dovuto ricorrere alla fede per comprendere che «uno è colui che semina, un altro quello che miete»…
2. Cosa dire alla Chiesa.
2.1. Un impegno di essenzialità, dove si riscopre che l’«efficacia dell’evangelizzazione non è legata alla potenza delle strutture: questa anzi spesso allontana e presenta un falso volto della Chiesa.
2.2. Un impegno di evangelizzazione che miri a far nascere comunità fondate sull’amore e capaci di aprirsi a forme di solidarietà sempre più concrete e profonde. Comunità che raccolgono e fanno crescere persone sempre più capaci di vivere a fondo le solidarietà legate alla costruzione di un mondo sempre più in linea con le esigenze del regno di Dio; capaci di andare controcorrente là dove le solidarietà tendono a scadere nel corporativismo.
2.3. Il riconoscimento:
2.3.1. della varietà e della molteplicità dei carismi e conseguentemente dei ministeri nella Chiesa;
2.3.2. del carattere proprio del «ministero ordinato»: essere a servizio della varietà dei ministeri per farli crescere, invece di assorbirli e mortificarli con una clericalizzazione della Chiesa.
2.3.3. di una pluralità di forme di esercizio dell’unico ministero presbiterale, legata alla pluralità non solo dei carismi personali, ma dei bisogni e delle situazioni umane cui si è chiamati a dar risposta: la pluralità di carismi è suscitata dallo spirito anche all’interno dell’unico ministero presbiterale, in vista di queste esigenze molteplici e differenziate.
2.4. Un impegno di «profezia e denuncia», di stimolo e sostegno per «non lasciarsi vincere dal male, ma vincere il male con il bene»: la Chiesa è per il Regno di Dio, non per sé stessa. I ministeri suscitati in essa sono per la continuazione della Chiesa, in vista del Regno, a servizio della liberazione dell’uomo da un «mondo» (o una «mondanità») che tutto racchiude entro orizzonti terrestri, di sostanziale materialismo (anche quando fa professione di «rispetto» per la Chiesa e per i suoi «valori»), di ateismo pratico.
Si riscopre il senso dell’essere «piccolo gregge», minoranza tenace anche quando è inascoltata o osteggiata. Una realtà «sperimentata» anche in classe operaia, quando si ha il coraggio e la capacità di andare oltre momenti «di massa», cercando la solidarietà nel quotidiano, nel mutamento reale e costante dei rapporti non solo di lavoro.
2.5 Una capacità di parlare «a tempo e controtempo», meno preoccupata degli «indici di ascolto» delle piazze (e ancor più dei potenti), meno sollecita di far pesare (o peggio di imporre) le «sicurezze» di cui si sente portatrice, ma più attenta a far sì che crescano «adoratori del Padre in spirito e verità», nel concreto contesto delle loro esperienze di vita.
Il tutto in una prospettiva che non sia soltanto quella di una «chiesa dei poveri» (che però non mette in discussione le proprie ricchezze di mezzi e strutture…) ma nella prospettiva di una chiesa povera dove la povera gente possa (quando lo voglia) ritrovarsi «nella sua casa».
3. Futuro dei PO.
La constatazione amara della realtà (non ci sono giovani sulle nostre strade e le istituzioni ecclesiastiche non si dimostrano certo propense a favorire una continuazione della presenza dei PO) non turba la serenità della nostra scelta e della nostra «ostinazione» nel continuare.
Non era nostro scopo diventare «istituzione»; solo rivendichiamo la validità e la ricchezza del vivere il proprio ministero presbiterale nella condizione «anonima» del lavoro manuale dipendente.
D’altra parte, nella Chiesa stessa, pur nella nostra posizione di marginalità (e non di rado di emarginazione voluta), siamo stati «segno»: povero ma reale. Non fosse stato così non saremmo stati presenza «scomoda» da tenere a margine.
Di certo non siamo stati del tutto insignificanti, anche nel produrre stimoli di rinnovamento che hanno interessato anche altri preti, che per questo seguissero la nostra strada.
C’è un «essenziale» che sentiamo di aver cercato di vivere e crediamo di poter ancora comunicare ai preti e alle istituzioni di chiesa: l’amore concreto verso i poveri, che si traduce in solidarietà quotidiana, condivisione delle condizioni di vita, partecipazione alle speranze e alle lotte.
Sono strade percorribili anche dai giovani preti. Ci resta la responsabilità, nei loro confronti, di non presentarci in abiti di lutto che potrebbero far intendere che neppure noi siamo troppo convinti della validità di quanto abbiamo vissuto.
Le sette parole …viste dall’Africa
di Luigi Consonni
Tre anni di frequentazione del Rwanda e dintorni, seguendo i rifugiati hutu in Tanzania, mi fanno confermare il quadro che è stato descritto a grandi linee con le sette parole.
Quella piccola minoranza che ha deciso di cambiare il quadro del pianeta sembrerebbe aver dimenticato il continente africano. In realtà, è stato deciso che gli abitanti dell’Africa (a parte alcune aree) non contino nulla; mentre continuano a contare molto alcune aree africane, soltanto perché sono contenitori di enormi tesori.
Nel caso dell’area centrale dell’Africa, la “cassa del tesoro” è lo Shaba (la regione sud orientale dello Zaire, che in passato si chiamava Katanga), una delle zone minerarie più importanti del mondo. È su quella che puntano gli USA da circa 30 anni: si tratta di sottrarla al controllo degli europei che se ne sono impossessati nell’epoca coloniale.
Per questo lo Zaire di Mobutu è stato deliberatamente abbandonato, fino ad essere ormai ridotto allo sfascio. Per questo gli USA hanno finanziato, fin dagli anni ‘70, l’opposizione rwandese rifugiatasi all’estero ed egemonizzata dai tutzi, che nel ‘94 ha preso il potere a Kigali. Per questo la Francia (che è stata estromessa dal Rwanda nel ‘94; e ha scelto di rompere i rapporti con il Burundi poche settimane fa) sta sostenendo economicamente e militarmente gli hutu rwandesi e burundesi rifugiati in Tanzania e Zaire.
Nel futuro prossimo dell’area centroafricana c’è il riesplodere della guerra tra Francia e USA per il controllo delle ricchezze minerarie zairesi: probabilmente tutto sarà più chiaro alla morte di Mobutu, l’uomo della CIA portato al potere nel ‘65 dalle truppe francesi e belghe, che conserva il suo potere soltanto perché è il più grande contrabbandiere di diamanti esistente.
Tra parentesi: il colpo di stato del ‘93 in Burundi nascondeva un gigantesco scontro di interessi sul traffico dell’oro proveniente dallo Shaba (il Burundi è il terzo esportatore mondiale di oro, pur non producendolo).
Guerra tra Francia e USA, allora; ma giocata “per interposte etnie”, gli hutu e i tutzi: ed è così che ce la raccontano come una guerra etnica…
Se il quadro è questo, il futuro dei giovani rwandesi qual è, se non la guerra? Una guerra nella quale sono lanciati sempre più accanitamente, sempre più convinti delle buone ragioni dei leader della propria etnia. Non c’è per loro, dunque, un futuro prossimo né di pace né di giustizia. Come per il pianeta, a ben considerare le sette parole…
Insomma, sto dicendo che la situazione dell’Africa è molto grave; a conferma di quello che dicono le sette parole: la situazione del pianeta è grave…
Ci sono ormai diversi rapporti di scienziati di tutto il mondo (il Club di Roma, anni fa; il Gruppo di Lisbona; la Fondazione per il progresso dell’uomo (vedi Le Monde Diplomatique – il Manifesto dell’aprile ‘94): tutti avvertono che entro pochissimi decenni bisogna cambiare radicalmente rotta, se no la Terra è condannata al suicidio.
Prendere coscienza della gravità della situazione deve servire non a paralizzarci, ma ad allertarci. Oggi è più che mai necessario che esprimiamo con la nostra vita il massimo possibile di dissenso rispetto a chi sta guidando il pianeta verso la rovina. Non possiamo restare passivi di fronte a quello che sta avvenendo e tanto meno collaborare con chi ne è responsabile: in ogni caso sarebbe complicità.