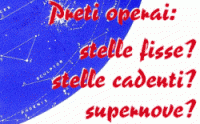
a cura dei PO del Veneto
OVUNQUE, MA NON IN QUELLA MANSARDA
Entrò nella mia camera e disse: « Miserabile, che non comprendi nulla, che non sai nulla. Vieni con me e ti insegnerò cose che neppure sospetti». Lo seguii.
Mi portò in una chiesa. Era nuova e brutta. Mi condusse di fronte all’altare e mi disse: «Inginocchiati». Io gli dissi: «Non sono stato battezzato». Disse: «Cadi in ginocchio davanti a questo luogo con amore come davanti al luogo in cui esiste la verità». Obbedii. Mi fece uscire e salire fino ad una mansarda da dove si vedeva attraverso la finestra aperta tutta la città, qualche impalcatura in legno, il fiume dove alcune imbarcazioni venivano scaricate. Nella stanza c’erano solo un tavolo e due sedie. Mi fece sedere. Eravamo soli. Parlò. Talvolta qualcuno entrava, si univa alla conversazione, poi se ne andava.
Non era più inverno. Non era ancora primavera. I rami degli alberi erano nudi, senza gemme, in un’aria fredda e piena di sole.
La luce sorgeva, splendeva, diminuiva, poi le stelle e la luna entravano dalla finestra. Poi di nuovo sorgeva l’aurora.
Talvolta taceva, prendeva da un armadio un pane e lo dividevamo. Quel pane aveva davvero il gusto del pane. Non ho mai più ritrovato quel gusto.
Mi versava e si versava del vino che aveva il gusto del sole e della terra dove era costruita quella città.
Talvolta ci stendevamo sul pavimento della mansarda, e la dolcezza del sonno scendeva su di me. Poi mi svegliavo e bevevo la luce del sole.
Mi aveva promesso un insegnamento, ma non m’insegnò nulla. Discutevamo di tutto, senza ordine alcuno, come vecchi amici.
Un giorno mi disse: «Ora vattene». Caddi in ginocchio, abbracciai le sue gambe, lo supplicai di non scacciarmi. Ma lui mi gettò per le scale. Le discesi senza rendermi conto di nulla, il cuore come in pezzi. Camminai per le strade. Poi mi accorsi che non avevo affatto idea di dove si trovasse quella casa.
Non ho mai tentato di ritrovarla. Capii che era venuto a cercarmi per errore. Il mio posto non è in quella mansarda. Esso è ovunque, nella segreta di una prigione, in uno di quei salotti borghesi pieni di ninnoli e di peluche rosso, in una sala d’attesa della stazione. Ovunque, ma non in quella mansarda.
Qualche volta non posso impedirmi, con timore e rimorso, di ripetermi un po’ di ciò che egli mi ha detto. Come sapere se mi ricordo esattamente? Egli non è qui per dirmelo. So bene che non mi ama. Come potrebbe amarmi? E tuttavia in fondo a me qualcosa, un punto di me, non può impedirsi di pensare tremando di paura che, forse, malgrado tutto, mi ama.
(Simone Weil, 1942 – in Quaderni , vol.I, ed. Adelphi)
ER CECO
| I. Su l’archetto ar cantone de la piazza, ar posto der lampione che c’è adesso, ce stava un Cristo e un Angelo de gesso che reggeva un lumino in una tazza. … Più c’era un quadro, indove una ragazza veniva libberata da un ossesso: ricordo d’un miracolo successo, sbiadito da la pioggia e da la guazza. … Ma una bella matina er propietario levò l’archetto e tutto quer che c’era pe’ dàllo a Spizzichino l’antiquario. … Er Cristo agnede in Francia, e l’Angeletto lo prese una signora forestiera che ce guarnì la cammera da letto. …… II. E adesso l’Angeletto fa er gaudente in una bella cammeretta rosa, sculetta e ride ne la stessa posa coll’ale aperte, spensieratamente….Nun vede più la gente bisognosa che je passava avanti anticamente, dar vecchio stroppio ar povero pezzente che je chiedeva sempre quarche cosa!..Nemmanco je ritorna a la memoria quer ceco ch’ogni giorno, a la stess’ora, je recitava la giaculatoria:…nemmeno quello! L’Angeletto antico adesso regge er lume a la signora e assiste a certe cose che nun dico! |
III. Er ceco camminava accosto ar muro pe’ nun pijà de petto a le persone, cercanno co’ la punta der bastone ch’er passo fusse libbero e sicuro. … Nun ce vedeva, poveraccio, eppuro, quanno sentiva de svortà er cantone ciancicava la solita orazzione coll’occhi smorti in quell’archetto scuro. … Perché, s’aricordava, da cratura la madre je diceva: – Lì c’è un Cristo, preghelo sempre e nun avé paura… … E lui, ne li momenti de bisogno, lo rivedeva, senza avello visto, come una cosa che riluce in sogno… …… IV. Da cinque mesi, ar posto der lumino che s’accenneva pe’ l’avemmaria, cianno schiaffato un lume d’osteria cor trasparente che c’è scritto: Vino. … Ma er ceco crede sempre che ce sia er Cristo, l’Angeletto e l’artarino, e ner passà se ferma, fa un inchino, recita un paternostro e rivà via……L’ostessa, che spessissimo ce ride, je vorebbe avvisà che nun c’è gnente: ma quanno è ar dunque nun se sa decide….In fonno, – pensa – quann’un omo prega Iddio lo pò sentì direttamente senza guardà la mostra de bottega. (Trilussa, Ommini e bestie |
ESPERIMENTI DI MONACHESIMO METROPOLITANO
a cura di Giorgio Scatto e Gigi Meggiato
PREMESSA
“Preti operai e preti monaci”
Ogni essere umano si ritrova, allo stesso tempo, come una singolarità unica, un tutto in sé, ma anche come parte di una totalità, data dall’insieme degli altri esseri. La stessa logica vale per gli ‘insiemi’ formati da più soggetti. Ogni gruppo sociale, politico, religioso… riflette e si esprime a partire dalla propria collocazione spazio-socio-temporale, che è, evidentemente, l’unico e il solo ambito nel quale poter percorrere fino in fondo il tratto di storia in cui è immerso. La ricchezza di vita e prospettive emergenti dal provissuto reca, nelle persone avvedute, la consapevolezza di essere affacciati ad una finestra tra le tante, della grande casa costituita dall’insieme di tutti i gruppi. Per non incorrere nell’inconsapevole e sempre presente tentazione dell’assolutizzare la propria angolatura e visuale è opportuno, forse necessario, il confronto con movimenti abbastanza vicini o affini nella ricerca o nella prassi. L’affinità evidentemente non svolge la funzione di trovare una sponda autocelebrativa e pertanto dannosa, ma cerca di parare il pericolo dell’autodissolvenza delle distanze abissali, facendo emergere subito i ‘paletti’ (perché visibili) delle differenze. La vicinanza inoltre permette una possibile comunicazione tra vissuti diversi, in modo che il parlare si estenda al dialogare che implica la consapevolezza delle proprie peculiarità.
“Parlare con un monaco”
La nostra esistenza è connotata dal lavoro, che ha trasformato non tanto il ritmo delle nostre giornate, o il nostro rapporto con la realtà ecclesiale, quanto piuttosto e più profondamente il nostro rapportarci con gli uomini e con Dio. Siamo persone (come la maggior parte) secolarizzate e desacralizzate senza nostalgia di ritorno. Ciò appare estraneo, se non contrapposto al modello di vita religiosa detto monastico; eppure nonostante tempi e prassi di vita ben differenti, riteniamo esistano elementi di affinità da produrre un incontro fruttuoso e gioioso con un monaco.
“Mondo”
Il monachesimo viene spesso percepito come la capacità della terra di innalzarsi fino a toccare il cielo: l’immersione nel verde della natura, il silenzio, la quiete del monastero divengono realtà-simbolo di una ‘fuga’ dalle incombenze, preoccupazioni, lotte, violenze insite nella quotidianità di ogni esistenza. Tale visione e lettura è rifiutata dai monaci. Affermano che bisogna fuggire non dal mondo (con le sue bellezze e cattiverie), ma dalla mentalità mondana dell’avere, del potere. Il monaco non deve fuggire dalle donne/uomini del suo tempo. Si tratterebbe di una fuga antievangelica e impossibile perché significherebbe negare la creaturalità dello stesso monaco e negare il fondamento della fede cristiana: l’incarnazione. E chi starebbe di fronte a Dio? Sostengono (e si può ben vedere nelle esperienze di taluni monasteri come Camaldoli, nella gente, nei suoi problemi, interrogativi, culture): la ‘fuga mundi’ va intesa come rifiuto della ‘mondanità’ (1Gv2,15-16), consapevoli però di portare nella propria carne i segni inestinguibili della debolezza e della peccaminosità umana. Compito del monaco, come di ogni credente, è convertirsi, meglio, lasciarsi convertire.
“Soggettività”
La vita monastica è una via per capire e accettare se stessi. Scoprire la propria soggettività rischiarata dalla luce dello Spirito, luce che fa sondare le profondità sconosciute allo stesso soggetto. Il monaco non ha l’assillo di convertire, di sentirsi evangelizzatore di professione, di predicare agli altri.
Padre Benedetto Calati sostiene che solo quando uno capisce il ‘Cantico dei Cantici’ allora “è monaco”. Il poemetto biblico racconta di una ininterrotta ricerca (e di un essere ricercato/a) amorosi e amorevoli; trovare e lasciarsi trovare; amare e lasciarsi amare. L’accoglienza amorevole di se stessi/e è grazia di Dio, perché fa gioire sentirsi amati prima ancora di poter ricambiare. Si è evangelizzati (in senso etimologico).
“Lavoro”
“Ora et labora”. Il motto attribuito a S. Benedetto e cardine della regola benedettina esprime la tensione tra ‘l’abitare la terra’ (Sal.37) e il lodare il Signore. Il lavoro è la vita. Nella sua durezza, fatica, insopportabilità, manifesta il travaglio del vivere, la necessità di lottare per costruire continuamente una storia diversa da quella cui siamo sottoposti; ma nei suoi spazi di creatività (purtroppo pochi), utilità, esprime la possibilità di plasmare la terra, la gioia contingente – ma unica – che ci è concessa nel vivere. Il lavoro è nuovamente posto all’attenzione del mondo monastico come avverte nella sua lucidità Calati (cfr. rivsta Esodo, 4/1992).
“Dio”
Un tema specifico della nostra situazione esistenziale sta nella ‘assenza / silenzio’ di Dio. “Di Dio si può forse vedere solo il lembo del mantello”. L’affermazione esprime che la pista di ricerca, anche del monaco, è posta nell’oscurità. Nessuno può dire ‘eccolo qua o là’ (Mt.24,23). Bisogna abitare il silenzio di Dio. Operare per la giustizia tra gli uomini; in specie per chi è nudo, emigrante, affamato… (Mt.25, 31ss.), come ha mostrato la grande tradizione monastica (vedi vita di S. Romualdo).
Gigi Meggiato
“FORSE DI DIO SI PUÒ INTRAVVEDERE SOLO IL LEMBO DEL MANTELLO”
di Giorgio Scatto (appunti)
Giorgio Scatto, prete di Venezia dal 1971. Vicario parrocchiale per un breve periodo. Iniziò la ricerca della via monastica con esperienze a Rossano Calabro, Roma, Palestina approdando al modello monastico proposto da Dossetti. La prospettiva dossettiana mette insieme il carisma monastico con l’essere inserito in una chiesa locale. Dal 1984 vive a Marango di Caorle (90 abitanti circa) dove è parroco. La comunità è composta da 6 persone; di cui 2 donne e 1 uomo neoprofessi (agosto 1996), un ragazzo con handicap. Una delle donne è maestra elementare in una scuola statale vicina.
a. Sposarsi con una terra:
ogni esperienza spirituale si situa in una terra. Simboli scritturistici della terra: giardino, luogo di schiavitù e di esilio, deserto, monte, città…
È l’orizzonte in cui definire e collocare la propria avventura spirituale, cioè collocarsi ‘nella terra di Zabulon e di Neftali’,
• una terra che ‘non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi’ (Is.53,2),
• una terra data più che cercata, offerta più che conquistata
• terra di lotta, come Giacobbe (Gen.32,25),
• terra di esilio, come Israele in Egitto (Es.3).
Così c’è una fede impastata dai ritmi e dai colori di questa terra concreta (Marango), strappata al mare con la bonifica e la fatica degli scarriolanti, e il lavoro dei mezzadri.
b. La chiamata ad una ‘vita comune’,
non ad una vita inizialmente ritagliata su misura.
“La chiave dell’esistenza è offerta all’uomo proprio tra le cose senza storia e senza dramma: lavoro, fame, povertà, solitudine, ciò che realmente si chiama: vita comune” (Thomas Merton).
“Lo scopo della vita religiosa è raggiungere la massima semplicità” (Sorella Maria, eremo del Clitunno).
c. La via della minorità
Condurre la vita dei più piccoli, dei pellegrini, dei deboli a una ‘fuga mundi’ intesa come fuga dalla mondanità, da un universo di menzogna e di potere che talvolta inquina anche la Chiesa.
Diventare ‘minores’ per permettere alla Chiesa di salvarsi e di salvare il mondo attraverso questa via (Mt.25).
«I frati non facciano liti, dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amor di Dio e confessino di essere cristiani. Quando vedranno che piace al Signore, annunzino la Parola di Dio, perché credano in Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, e siano battezzati e si facciano cristiani» (S. Francesco, Regola non bollata).
d. La lode
‘Dio abita la lode di Israele’ (Sal.22).
• Le porte della lode aprono largamente verso l’esterno, verso colui che è al di là delle cose e di noi stessi.
• La lode innalzata in mezzo ai popoli è per noi la ‘Dominici schola servitii’ di cui parla S. Benedetto.
• Dal ‘Dio ignoto, absconditus, al ‘Dio conosciuto in Giuda’, attraverso la via della lode.
• La lode come ascolto della Parola, che culmina nell’Eucarestia. La Parola e l’Eucarestia sono i due poli attraverso i quali viene tesa la nostra vita di discepoli.
“Le due realtà vanno insieme: la Parola di Gesù e il sangue di Gesù. Fra l’una e l’altro seguono tutte le lettere dell’alfabeto, tutti gli affari della vita individuale, domestica, sociale, tutto ciò che è importante fare, ma è secondario in ordine al destino eterno dei figli di Dio, e che non vale se non in quanto è sostenuto dalle due lettere terminali: cioè la Parola di Gesù, sempre risonante in tutti i toni della santa Chiesa dal libro sacro, e il sangue di Gesù nel divino sacrificio, sorgente perenne di grazia e di benedizioni”. (Angelo Roncalli, La S. Scrittura e Lorenzo Giustiniani, Venezia 1956).
e. Presenza nella città dell’uomo e Xenetéia (estraneità)
Attesa di un altrove, sradicamento.
Verginità come de-strutturazione, povertà ontologica guarita solo da una presenza ‘Altra’. Un vuoto, un’assenza che evoca, nella carne trasfigurata e redenta, la pienezza di un ‘tu’.
Patria, presenza, cercata come obbedienza alla Parola. La tentazione è sempre quella di sottrarsi ad essa, o renderla vana.
“Una lettura credente e orante, memore e amante… Occorre che la Scrittura appaia sempre più quello che è, cioè un’unità vivente, anzi il Vivente stesso, Cristo crocifisso e glorioso: che in ogni versetto della Scrittura tocchiamo e ascoltiamo, o meglio ci tocca, ci monda, come ha fatto con il lebbroso, ci trasforma e progressivamente ci assimila a sé e ci conduce al Padre: così tutta la Scrittura diventa un grande sacramento di Cristo” (G. Dossetti, Il Regno 19/1986).
f. un cammino spirituale ‘nella Chiesa’
• attraverso l’Eucarestia, che genera ‘l’una, santa’
• in riferimento ad un vescovo “Strettamente congiunti a Lui, come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutto sia concorde nell’unità” (Ignazio, ad Ef.5).
• Attenti alla profezia dei martiri e dei piccoli
g. Due le idee guida di questo cammino
“in comune, da cristiani” (Bonhoeffer)
• La dialettica feconda Chiesa/mondo: la scoperta dell’esistenza di
una realtà umana imponente, diversa dalla Chiesa, nella quale essa è chiamata a vivere e operare.
Non più una Chiesa di fronte al mondo, ma una chiesa nel mondo e dal mondo.
La chiesa come ‘questo mondo’ che, illuminato da Cristo, diventa frammento e anticipo del Regno
• La necessità che la Chiesa sia una chiesa ‘locale’, impegnata nella evangelizzazione di un popolo e di una terra.
Concludendo
La domanda era questa: come cercare, dopo la stagione dell’assolutismo e del verticalismo, nuovi stili pastorali dell’annuncio della Parola, di celebrazione corale della fede, di testimonianza semplice del vangelo, di condivisione della condizione umana? Erano gli anni, dopo una fugace primavera, delle grandi crisi, della ‘diaspora’, della frustrazione di una possibilità di partecipazione e di comunione, ben presto negate.
Come la Chiesa poteva stare in compagnia (cum-pane) degli uomini, senza assumere la ‘mondanità’ e senza diventare soggetto di legittimità della società civile, fondandone i valori? (i regimi di cristianità).
Ho tentato la risposta riaffermando
– il primato della Parola sulla Chiesa stessa;
– l’urgenza dell’annuncio ai poveri come primi destinatari del Vangelo stesso.
«Il mistero di Cristo nella Chiesa sempre è stato ed è, ma oggi lo è particolarmente, il mistero di Cristo nei poveri: in quanto la Chiesa, se è la Chiesa di tutti, oggi è specialmente ‘la Chiesa dei poveri’». (Card. Lercaro)
Temi emersi dal dibattito successivo alla relazione
• Dio si può vedere solo di spalle
• Dio rimane sempre al di là e altrove
• Forma teologica opportuna: apofatica
• Pericolo di creare nuovi santuari
• Essere avvertiti circa la profanazione della fede e l’utilizzazione della fede
• Vivere la fede nella profanità consegnando l’uomo e la storia a se stessi
• La religione può essere equivoco e idolatria: viverla come realtà contingente, le sue forme sono ‘congetture’
• Difficile tenere insieme fedeltà a Dio e all’uomo con cui vivi
• Segni della fede sono grazia o solo strada per rimanere aperti alla grazia?
• Riscoprire di ‘essere solo uomini normali’.
Bibliografia
• B. Calati, Sapienza monastica (Roma 1994).
• I. Balan, Volti e parole dei padri del deserto romeno, ed. Qiqajon.
• L. Tolstoj, Padre Sergej, ed. Einaudi o Feltrinelli.
• Florenski, La vita di P. Isidoro, ed. Qiqajon.
• Il Chiostro e la strada, ‘Esodo’ n.4,1992.
• F. Dostoevskij, Ifratelli Karamazov, ed, Einaudi o Garzanti (sul tema monaco-mondo e, come film, di A. Tarkovskij, ‘Andrej Rublev’).
• Dal libro di Tolstoj è stato tratto il film “Il sole anche di notte”, regia dei fratelli Taviani.
SIMONE WEIL
PENSIERI SUL VISIBILE E SULL’INVISIBILE
Non vi è giustizia senza fede, e la fede è la credenza nelle cose invisibili: ‘prova delle cose che non vediamo’ (Ebr.11,1).
Abramo ‘per fede obbedì al comando di partire… e partì senza sapere dove andava’ (Ebr.11,8).
Il buon ladrone. Si tratta di qualcosa di ben diverso dalla fede che si ha oggi nella Chiesa che è visibile.
«Ho battezzato il 18° adulto…». Mediante il numero, il tesoro dell’avaro s’introduce in tutte le cose, comprese le più sante. Questo può, ad esempio, rendere ciechi sulla qualità di un battesimo.
Gli unici sforzi puri sono quelli senza scopo, ma sono umanamente impossibili.
Legame tra verità e obbedienza. La certezza è l’obbedienza dell’intelligenza (e nient’affatto la sottomissione a un’autorità esterna, anche accettata per fede).
Il disagio dell’intelligenza nel cristianesimo, che dura da 20 secoli, deriva dal non aver saputo stabilire un modus vivendi soddisfacente, basato su una visione esatta delle analogie e delle differenze, tra lo Spirito Santo che parla al corpo della Chiesa e lo Spirito Santo che parla all’anima. Il Corpo mistico non è che un corpo. L’anima nello stato di perfezione è l’immagine stessa del Cristo.
Il grosso animale ha come fine l’esistenza. «Io sono colui che sono»: anche lui lo dice. Gli basta esistere, ma non può né concepire né ammettere che altro esista. È sempre totalitario.
La Chiesa è stata un grosso animale totalitario. Essa ha dato inizio al rimaneggiamento di tutta la storia dell’umanità a fini apologetici.
dai Quaderni (Adelphi), vol II e III
DIO USATO E CONSUMATO,
NON L’OGGETTO DA ARREDAMENTO
È possibile che non si sappia nulla di fanciulle che pure vivono? È possibile che si dica “le donne”, “i bambini”, “i ragazzi” senza il sospetto (nonostante tutto il sapere, senza il sospetto) che da lungo tempo queste parole non hanno più alcun plurale ma solo innumerevoli singolari?
Sì, è possibile.
È possibile che ci sia gente che dice “Dio” e pensa a qualcosa che apparterrebbe a tutti? E guardiamo anche solo due scolaretti: uno si compra un temperino, e l’altro se ne compra uno uguale. Il medesimo giorno. E dopo una settimana si mostrano l’un l’altro i due temperini, e accade che i due oggetti ormai si rassomiglino solo molto alla lontana, tanto diverso ciascuno è divenuto in mani diverse. (Sì, aggiunge la madre di uno dei ragazzi: anche se voi, tutti e due uguali, dovete logorare sempre tutto!).
E allora: è possibile credere di poter avere un Dio senza che divenga usato e consumato?
Sì, è possibile.
R. M. Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge, Garzanti
NON ESSERE ARROGANTI
Colui che veramente sa non diventa arrogante,
Né con le opinioni né con i pensieri: egli non è di quella specie;
Non dagli atti rituali né dalla tradizione si fa condurre,
Non è egli tale da farsi indurre a tali sedi di riposo.
Per colui che è libero da concezioni non esistono legami,
Per colui che è libero mediante gnosi non esiste offuscamento:
Coloro che, invece, sono afferrati a concetti e teorie,
Costoro girano il mondo infastidendo la gente».
Suttanipata, Canone buddista vol II Utet – vedi Matteo 23,15
Ciò che chiamiamo paganesimo, in tutte le sue forme, non può essere altro che una degradazione, non qualcosa di primitivo.
Se invece di sradicare le popolazioni nel tempo, i preti dicessero: «Noi vi portiamo quel che i vostri antenati hanno creduto, e che voi avete dimenticato». È certamente questo che il Cristo avrebbe voluto. L’imperfetto procede dal perfetto e non inversamente.
Se la rivelazione di Adamo ha comportato la possibilità dell’incarnazione e della passione – il totemismo si spiega considerando il sacrificio come una figura di questo mistero.
S. Weil, Quaderni, vol.III
TRAFFICO, TRAFFICI
L’Osservatore Romano riprende quei non pochi intellettuali (Arbasino, Malerba, Ferrarotti…) che dimostrano poca simpatia per il Giubileo, ne misconoscono il messaggio universale, anche extracristiano, e magari progettano di trascorrere il Duemila a Saint Moritz piuttosto che nella pia bolgia romana. Gli intellettuali, si sa, sono snob: ma preferire una passeggiata feriale in Engadina a un ingorgo millenarista romano, diciamolo, è una scelta così condivisibile da rischiare la popolarità di massa.
Arbasino è stato, nella circostanza, più ovvio di Baudo, facendo recuperare alle famose élite con la puzza sotto il naso, in un colpo solo, molti punti nella classifica della normalità. La spiritualità, la speranza, l’amore universale: diamine, se ne servirebbero! È che nell’imbuto centralista della città santa (e della Mecca, e del Gange), gomiti, sudore e claustrofobia rischiano di generare un malaugurato odio dei fratelli per i fratelli.
Un giubileo federalista, distribuito qui e là, magari anche via Internet, fino agli infiniti terminali della fede di chi ne ha, con Roma in cd-rom portata ovunque: come sarebbe giovevole ai nostri spiriti inariditi! Vacanze romane, intendo per i romani.
Michele Serra, L’Unità del 9 giugno ‘94
«Anno Santo e Giubileo sono storicamente legati all’applicazione delle indulgenze, di cui le nostre chiese hanno sempre contestato la legittimità evangelica».
Così recita l’ordine del giorno approvato ieri sera dal Sinodo delle chiese valdesi e metodiste riunite a Torre Pellice per la massima assise dei protestanti italiani.
dai giornali del 28 agosto ‘96
