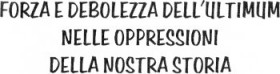
Incontro PO italiani ed amici
Viareggio, 20-21 aprile 2002
Nei testi introduttivi proposti come provocazione iniziale del convegno, pur condividendo l’intenzione di fondo, ritengo ambigua la concezione dell’atto etico proposta attraverso i testi di Arturo Paoli.
L’affermazione per cui l’atto etico ha come fondamento il riconoscimento del bisogno dell’altro è rischiosa perché presenta l’altro fondamentalmente come povero e bisognoso.
Credo che la critica che G. Angelini fa di questa affermazione possa essere illuminante e chiarificatrice.
Pur non essendo riferita esplicitamente ad Arturo Paoli, ma alle opere di A. Rizzi l’oggetto della critica è lo stesso.
L’affermazione per cui l’atto etico ha come fondamento il riconoscimento del bisogno dell’altro è rischiosa perché presenta l’altro fondamentalmente come povero e bisognoso.
Credo che la critica che G. Angelini fa di questa affermazione possa essere illuminante e chiarificatrice.
Pur non essendo riferita esplicitamente ad Arturo Paoli, ma alle opere di A. Rizzi l’oggetto della critica è lo stesso.
“La radice della religione biblica è da cercare in Rizzi nell’esperienza etica, la rivelazione darebbe in tal senso nome ad un’esperienza universalmente umana. “C’è identità reale – egli scrive espressamente – tra parola di Dio ed esperienza etica. Per questo la religione biblica sarebbe anche religione ‘laica’, emancipata cioè da quel codice ‘sacro’, che è invece caratteristico della religione antica. La rivelazione biblica non presuppone in alcun modo la notizia di ‘Dio’ alla conoscenza del suo imperativo. (…)
Rizzi svolge una concezione dell’uomo e della società rigorosamente ricondotta all’identificazione del diritto (o del giusto o addirittura del sacro, o comunque di ciò che merita supremo ed incondizionato rispetto) con il bisogno dell’uomo. Al rapporto io-altri si sostituisce il più radicale rapporto tra mia responsabilità e bisogno dell’altro. (…)
Il pensiero di Rizzi disegna una teoria che legittima la risoluzione di tutta la morale cristiana – poi anche della pastorale ecclesiastica – all’imperativo categorico della compassione. (…)
Senza potere qui cimentarci con la questione più radicale, quella cioè della pertinenza del suo pensiero sotto il profilo della comprensione della fede cristiana rileviamo come nella concezione che Rizzi ha della carità manchi di essere riconosciuto l’originario aspetto della “prossimità” tra gli uomini. Tale aspetto non è certo quello che scaturisce dalla risposta, soltanto successiva, all’interpretazione etica che a me viene dal bisogno dell’altro. Si configura invece prima di tutto come accadimento sorprendente di una reciprocità che meraviglia, che appare come grata e insieme promettente, che quindi suscita un consenso facile e spontaneo. Esattamente nella prospettiva della fedeltà a tale primo ed inconsapevole consenso all’evento grato della prossimità, quindi alla promessa di sé iscritta in tale consenso, occorre intendere la stessa verità dell’imperativo morale. Esso non può in tal senso essere subito descritto quasi estraniasse l’uomo da una sua supposta identità originaria di segno egoista; articola piuttosto il compito della libertà che è quello di passare dalla condizione infantile e psichica alla condizione dell’uomo che sa promettere.”
Rizzi svolge una concezione dell’uomo e della società rigorosamente ricondotta all’identificazione del diritto (o del giusto o addirittura del sacro, o comunque di ciò che merita supremo ed incondizionato rispetto) con il bisogno dell’uomo. Al rapporto io-altri si sostituisce il più radicale rapporto tra mia responsabilità e bisogno dell’altro. (…)
Il pensiero di Rizzi disegna una teoria che legittima la risoluzione di tutta la morale cristiana – poi anche della pastorale ecclesiastica – all’imperativo categorico della compassione. (…)
Senza potere qui cimentarci con la questione più radicale, quella cioè della pertinenza del suo pensiero sotto il profilo della comprensione della fede cristiana rileviamo come nella concezione che Rizzi ha della carità manchi di essere riconosciuto l’originario aspetto della “prossimità” tra gli uomini. Tale aspetto non è certo quello che scaturisce dalla risposta, soltanto successiva, all’interpretazione etica che a me viene dal bisogno dell’altro. Si configura invece prima di tutto come accadimento sorprendente di una reciprocità che meraviglia, che appare come grata e insieme promettente, che quindi suscita un consenso facile e spontaneo. Esattamente nella prospettiva della fedeltà a tale primo ed inconsapevole consenso all’evento grato della prossimità, quindi alla promessa di sé iscritta in tale consenso, occorre intendere la stessa verità dell’imperativo morale. Esso non può in tal senso essere subito descritto quasi estraniasse l’uomo da una sua supposta identità originaria di segno egoista; articola piuttosto il compito della libertà che è quello di passare dalla condizione infantile e psichica alla condizione dell’uomo che sa promettere.”
Quando a Gesù viene espressamente chiesto chi è il prossimo, racconta la parabola del samaritano e propone il samaritano stesso come prossimo: colui che mi apre ad un rapporto grato con la vita, è lo straniero che si fa prossimo quando io sono nel bisogno .
Non il bisogno dell’altro mi apre all’atto etico, ma la reciprocità che l’altro suscita in me. L’atto etico (buono) per eccellenza può essere il matrimonio in cui due reciprocità meravigliate e stupite si sanno promettere fedeltà eterna nel segno della scoperta originaria (l’innamoramento) dell’altro come dono.
Allora la conoscenza di Dio non coincide con la nostra giustizia (essere giusti-buoni), ma piuttosto con la scoperta sconvolgente della nostra giustificazione: (essere fatti giusti-buoni). Allora quando Paoli afferma che per poter costruire la nostra esistenza etica dobbiamo partire dalla consapevolezza della colpevolezza dell’occidente e nostra, possiamo ben affermare che il punto di partenza per ogni conversione e ogni accusa di colpevolezza o di peccato deve essere preceduto dall’esperienza dell’altro, degli altri e del mondo come dono sorprendente e promettente.
La liturgia insegna che il primato di ogni riconoscimento di colpa è preceduto e sostenuto dalla misericordia e dalla grandezza di Dio. Nella terza formula dell’atto penitenziale l’oggetto delle affermazioni è sempre Dio, mai il nostro peccato. Un esempio:
Non il bisogno dell’altro mi apre all’atto etico, ma la reciprocità che l’altro suscita in me. L’atto etico (buono) per eccellenza può essere il matrimonio in cui due reciprocità meravigliate e stupite si sanno promettere fedeltà eterna nel segno della scoperta originaria (l’innamoramento) dell’altro come dono.
Allora la conoscenza di Dio non coincide con la nostra giustizia (essere giusti-buoni), ma piuttosto con la scoperta sconvolgente della nostra giustificazione: (essere fatti giusti-buoni). Allora quando Paoli afferma che per poter costruire la nostra esistenza etica dobbiamo partire dalla consapevolezza della colpevolezza dell’occidente e nostra, possiamo ben affermare che il punto di partenza per ogni conversione e ogni accusa di colpevolezza o di peccato deve essere preceduto dall’esperienza dell’altro, degli altri e del mondo come dono sorprendente e promettente.
La liturgia insegna che il primato di ogni riconoscimento di colpa è preceduto e sostenuto dalla misericordia e dalla grandezza di Dio. Nella terza formula dell’atto penitenziale l’oggetto delle affermazioni è sempre Dio, mai il nostro peccato. Un esempio:
Signore che sei pienezza di verità e di grazia abbi pietà di noi
Cristo che ti sei fatto povero per arricchirci abbi pietà di noi
Signore che sei venuto a fare di noi il tuo popolo abbi pietà di noi
Cristo che ti sei fatto povero per arricchirci abbi pietà di noi
Signore che sei venuto a fare di noi il tuo popolo abbi pietà di noi
Proprio perché preceduto da un amore promettente diviene ancora più scandaloso il peccato dell’uomo, infatti l’altro non è un poverino da aiutare, ma Dio stesso carico di doni e promesse mantenute, che rende ancora più sconcertante l’insofferenza e l’indifferenza degli uomini per un mondo che bussa alla porta della coscienza.
A questo punto diviene particolarmente illuminante l’immagine della sposa del cantico; quando sentendo bussare lo sposo alla propria porta, pensa:
A questo punto diviene particolarmente illuminante l’immagine della sposa del cantico; quando sentendo bussare lo sposo alla propria porta, pensa:
“Mi sono tolta la veste;
come indossarla ancora?
Mi sono lavata i piedi;
come ancora sporcarli?”.
come indossarla ancora?
Mi sono lavata i piedi;
come ancora sporcarli?”.
Questa immagine credo dica con forza l’atteggiamento di noi cristiani d’occidente impigriti ed incapaci di riconoscere chi è Colui che bussa, incapaci di lasciare tutto e seguire malati d’amore lo sposo che viene.
L’ultimum è così il dono di contemplare l’altro, anche quando bisognoso, come radicalmente promettente perché ad immagine e somiglianza del dono ultimo e definitivo: DIO.
L’ultimum è così il dono di contemplare l’altro, anche quando bisognoso, come radicalmente promettente perché ad immagine e somiglianza del dono ultimo e definitivo: DIO.
