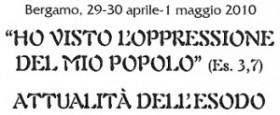
Prima relazione
1°. Le tappe dell’Esodo
Voglio anzitutto commentare le quattro tappe dell’Esodo. Esso ha un carattere universale, un paradigma che non riguarda solo Israele ma tutta l’umanità, non solo gli individui religiosi, ma anche i laici. Ernst Bloch, ebreo, fa una lettura prettamente atea dell’esodo. (Non mi riferisco solo al libro dell’Esodo ma anche agli altri libri come il Levitico e soprattutto il Deuteronomio).
Parlo di 4 tappe. Tappe cronologiche, geografiche, ma soprattutto culturali e teologiche.
1. Nella prima tappa c’è la rivelazione di chi è Dio. Es 2, 23- 25: “Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamenti e il loro grido salì a Dio”.
Il grido sale a Dio, ma non è ancora una preghiera: gli israeliti se ne sono dimenticati; è Dio a ricordarsi di Abramo, Isacco e Giacobbe. Un riferimento analogo può essere fatto con il piccolo Ismaele che nel deserto non ha più da mangiare e piange. Dio ascolta quel pianto.
L’iniziativa non è da parte dell’uomo con una preghiera, ma è un’iniziativa di Dio. E’ Dio che viene colpito nel suo orecchio da quel grido e decide di intervenire. L’iniziativa divina viene poi ribadita nel versetto 14 del capitolo 3: Dio dà l’incarico a Mosè di far uscire dall’Egitto il suo popolo. E Mosè domanda: “Mi chiederanno: chi te l’ha detto?”. Dio allora si presenta come “Colui che sono”. . Su questa autodefinizione di Dio sono stati versati fiumi di inchiostro. Ma non si tratta di Dio come Essere perfettissimo – come l’Essere sussistente – ma come l’”Esserci”. E’ quell’”esserci” di quando chiamo al telefono cercando un amico e chiedo al figlio che mi risponde: “C’è papà?”. “Sì, c’è”; vale a dire: “è presente”.
Questo “esserci” di Dio dice la sua presenza; ed è una presenza – stando al significato dei verbi ebraici – non solo puntuale, ma che vale per oggi e per domani. Quindi “Io ci sono” è anche “Io ci sarò”.
Questo fatto viene attestato dalla presenza che è partita da Dio e quindi è gratuita; ma quando aggiunge: “ Io ci sono e ci sarò” , diventa promessa, dunque un amore giurato, che si esprime attraverso diversi sostantivi: uno in particolare, che è hesed. Esso ricorre 245 volte nella Bibbia; almeno una trentina di volte è unito a emet = fedeltà: un amore dato per l’oggi, ma anche per il domani. Questa promessa viene mantenuta: Dio dà la sua parola e la mantiene; è un Dio “di parola”.
Mi pare che questo sia il senso più autentico, oggi riconosciuto dalla maggior parte degli esegeti. Un Dio che ama gratuitamente, e che mantiene questo amore per mille generazioni. Del resto anche nel Deuteronomio è detta la stessa cosa: “Il Signore Dio si è legato a voi e vi ha scelto, non perché siate più numeroso degli altri popoli, ma perché il signore vi ama, ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri” (Dt 7, 7-8).
Questo nella sostanza è il primo momento che ci dice chi è Dio. Questo Dio promette a Israele la liberazione dall’Egitto; e Israele, una volta ottenutala, applaude cantando l’inno di Miriam.
Ora gli israeliti sono liberi. Ma che cosa vuol dire “liberi”? Chi vorrebbe quella libertà? Hanno ragione nel protestare, si trovano liberi in un “non paese” , in un luogo dalla invivibilità umana, in una terra dove non si può costruire, dove non c’è nulla da mangiare, dove ci sono serpenti… Gli Israeliti non sono ancora Israele. Finora ha fatto tutto Dio con la mediazione di Mosè. Ora si tratta di costruire Israele. Il popolo che evocato nell’esodo non è una realtà fattuale, ma una possibilità, una vocazione, una prospettiva, l’apertura di un cammino. Ma fin qui non c’è Israele, fin qui c’è la “libertà da”; ma non la libertà “per “: per che cosa Dio lo ha liberato dall’Egitto? Per farlo morire di fame?
2. Nella seconda tappa Dio inizia la costruzione di Israele, e quindi la libertà trova il suo “per”: libertà per essere il popolo di Dio, per passare dalla servitù al servizio (è il titolo di un commento all’Esodo). Questa costruzione avviene in due tappe: la prima è quella del deserto.
Dopo l’inno di Miriam gli israeliti si inoltrano nel deserto (Es 15, 22ss.): “Camminarono per tre giorni nel deserto senza trovare acqua, arrivarono a Mara, ma non poterono bere le acque di Mara perché erano amare. Allora il popolo mormorò contro Mosè: Che cosa berremo? Egli invocò il signore il quale indicò un legno, lo gettò nell’acqua che divenne dolce. In quel luogo il signore impose al popolo una legge e un diritto, in quel luogo lo mise alla prova”.
Tutti i 40 anni del deserto saranno una continua riedizione di questa prova. Ed è per questo che si spiega la nostalgia dell’Egitto: là avevano almeno da mangiare, qui invece si muore di fame. Il deserto diventa la lezione della fede, del credere che anche qui Dio interverrà; anzi, che la prima dimensione di costruzione del suo popolo è insegnare a credere: non aderendo a un corpo di dogmi, ma dandogli fiducia, dandogli credito.
Nella lezione che Dio dà nel deserto viene investito il quotidiano, in particolare nell’episodio di Esodo 16: la manna (termine che viene dall’ ebraico man-hu: “che cos’è questo?”), il pane quotidiano che durerà per un giorno solo (due giorni soltanto per il sabato). Diversamente, se fanno la scorta per il giorno dopo se la ritroveranno avariata, piena di vermi. La quotidianità del vivere la fede, nel “ noi continueremo a vivere, giorno dopo giorno, perché Dio ci nutrirà”
Ma non basta. La lezione del deserto è vista anche in funzione del domani, quando Israele sarà nella terra promessa. Nel Deuteronomio, capitolo ottavo, c’è un’anticipazione che viene messa sulle labbra di Mosè ma a partire dalla lezione che verrà data nella terra promessa. Qui gli israeliti si accorgeranno che è più facile seguire i baalim, gli idoli, seguire gli dei delle nazioni cananee, perché quelli sanno cosa vuol dire vivere da sedentari mentre il Signore Dio era idoneo soltanto a guidare Israele nomade nel deserto. Adesso bisogna imparare le tecniche dell’agricoltura, ma queste non si imparano se non imparando anche i miti. Tutto questo è anticipato e messo sulla bocca di Mosè per dare una lezione: dovranno vivere nella terra promessa “con un cuore di deserto”.
In che senso? In questo: che in tutto ciò che viene dalla terra c’è dietro quello stesso amore di Dio che li ha mantenuti nel deserto. Ecco allora la seconda lezione di fede: voi avrete tutto quello che sarà necessario per vivere e campare, ma anche per godere della bellezza di quei frutti. Sulle labbra di Gesù tornerà questa lezione nel discorso della montagna: “Non preoccupatevi per quello che mangerete o berrete… guardate i gigli del campo e gli uccelli dell’aria…” . Ed ecco allora la lezione integrale della fede: la fiducia in Dio, perché egli è fedele – è il Fedele – , mantiene la sua parola e porterà gli israeliti e li farà vivere nella terra promessa.
3. Il terzo momento è la salita all’Horeb. Qui vi propongo due testi. Il primo è quello di Esodo 19,3-8 :Mosè salì verso Dio e il Signore chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a me. Ora se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Ecco quel che devi dire agli israeliti. Mosè andò, riunì gli anziani del popolo e riferì loro tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Tutto il popolo rispose ad una sola voce e disse: “Noi ubbidiremo agli ordini del Signore”.
Ecco allora “voi sarete mia proprietà”: la promozione a un servizio regale e santo (“un regno di sacerdoti e una nazione santa”).
Cosa significa tutto questo? Lo troviamo in Deut. 6,4-6, ed è il credo di Israele:
“Ascolta Israele: il signore è il nostro Dio, unico è il Signore”. Questo è l’unico dogma per Israele: la unicità di Dio, il monoteismo. Poi il testo viene subito alla pratica: “Amerai il Signore tuo dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le tue forze. Questi precetti che oggi ti do, iscrivili nel tuo cuore: le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando ti corichi e quando ti alzi. Le legherai come segno sulla tua mano e le porterai come un pendaglio davanti agli occhi”.
Questi precetti sono la Torah, sono il decalogo. Qui c’è la sostanza: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. C’è l’imperativo categorico dell’amore, c’è quell’”amore comandato”, che per noi può sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è: l’amore come comandamento.
Da qualche anno ho ritrovato una formula che usavo in passato ma che avevo dimenticato. Invece di dire “amore comandato”, dire “amore dovuto”, che forse suona meglio. Il comandamento sembra dire qualcosa di esterno, mentre l’amore dovuto è come il “grazie” vissuto, è riconoscere il debito dell’amore. Ma al tempo stesso: come possiamo dare a Dio questo amore che gli dobbiamo? Certo, cantare l’azione di grazie come fanno ampiamente i salmi. Ma cosa possiamo dare?
Ho ritrovato un testo del Vangelo di Giovanni: “Figlioli miei, per poco sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma ora dico anche a voi quello che ho già detto ai capi ebrei: dove io vado voi non potete venire. Io vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri, amatevi come io vi ho amato” (Gv 13, 33-34). Sembrano due cose slegate: “io me ne vado ma voi non potete venire dove sono io”, e poi Gesù passa ad altro :”amatevi gli uni gli altri”. Il grande esegeta Cerfaux suggerisce che il collegamento tra il primo versetto e l’altro è questo: “guardate che voi non potete raggiungermi subito, ma nel periodo in cui siete sulla terra vi affido di amare i vostri fratelli”. Proprio come se richiedessimo a Dio: sì io devo tutto a te, ma per te non posso fare nulla. E lui ci risponde: puoi fare tante cose, guarda i figli miei.
In questo modo la lezione della fede si salda con la lezione dell’amore, dell’ “amare Dio con tutto il cuore” , incarnando questo amore con l’amore verso il prossimo. L’amore dovuto a Dio è dato ai suoi figli.
4. Ed eccoci al quarto momento: vivere sulla terra promessa. Quando Israele vi giunge crede di essere arrivato; in realtà non sarà mai “arrivato”. La duplice lezione che Dio ha dato nei lunghi 40 anni nel deserto e sul monte Sinai va tradotta e vissuta giorno dopo giorno.
Noi continuiamo giustamente a dire “la terra promessa”, perché la terra resta ancora promessa, perché la costruzione del popolo di Dio, di Israele come popolo di Dio, va messa in pratica nella vita quotidiana. Ogni giorno, come dicono alcuni esegeti, Israele si trova portato al di là del Giordano, e ogni giorno deve di nuovo guadarlo e ritornare sulla terra promessa. E’ una bella immagine per dire che quello che ha vissuto lo deve rivivere, è come se cominciasse da capo ogni giorno. Non si è mai arrivati definitivamente sulla terra promessa.
2°. Attualizzazione
Israele rappresenta tutta l’umanità, è un segno della vocazione universale all’alleanza, cioè alla fede e all’amore. Come tale, esso rappresenta un “terzo popolo”: il popolo dell’utopia biblica.
E gli altri due popoli dove sono?
Mi sono portato un piccolo riassunto di un’opera classica della sociologia, di Ferdinando Toennies, dal titolo Comunità e società. (la prima edizione dell’opera risale alla fine dell’Ottocento). Questo autore spiega bene i primi due modelli.
Il modello comunità: la comunità è la consociazione umana naturale perché ha come base la nascita che radica l’esistenza umana nella universale vita vegetativa. Dentro la comunità gli individui sono come organi del corpo, dal momento che questo è un organismo vivente. Cellula della comunità è la famiglia in quanto relazione di sangue, che spontaneamente si dilata nella relazione di vicinato, nell’appartenenza alla stessa terra; e, su un piano più alto, nella comunità dello spirito, il cui tessuto connettivo è costituito dalla lingua materna, dall’ethos e dal diritto comunitario.
Trovo vero questo modello perché ho studiato abbastanza da vicino diverse tradizioni comunitarie, e in particolare le due dell’America Latina: gli Incas del Perù e gli Aztechi del Messico, e trovo che nella sostanza questa definizione funziona. E questo spiega perché in Egitto, pur essendo rimasti per alcuni secoli, gli israeliti sono sempre rimasti stranieri. Perché cittadini si nasce, si ha la terra (la terra del Nilo), il popolo, l’ethos, la politica (il faraone); e si hanno gli dei. Gli dei degli egiziani sono dei egiziani (così come gli dei dei cananei sono dei cananei, e così via). E’ chiaro che ogni cultura, ogni civiltà resta chiusa in se stessa. Può essere la piccola tribù, può essere un grande impero, ma resta chiusa nella proprias naturale identità.
Il secondo modello è la società. Essa è un prodotto artificiale in quanto prodotto della volontà di individui che vivono prima separati, in relazione ai propri beni; perciò la formula esemplare della società è, in analogia con lo scambio dei beni, il contratto. Se la comunità è volontà essenziale, l’equivalente psicologico dell’organismo umano, la società è volontà arbitraria radicata nel pensiero riflesso e nella decisione in cui il soggetto individuale si costituisce signore della realtà.
Noi oggi siamo in pieno in una “società”, in una disgregazione dove c’è di tutto e il contrario di tutto, e che io vorrei descrivere brevemente mettendola a confronto con la tripletta dell’ideale della rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité.
Dentro quell’utopia vediamo come è stata la realizzazione storica.
La libertà: se leggiamo l’articolo 4 della Dichiarazione dell’uomo e del cittadino (26 agosto del 1789), troviamo che la libertà è “fare tutto ciò che non nuoce agli altri”. Cosa vuol dire? Non è libertà di poter fare tutto ciò che si vuole; c’è un limite, ed è l’altro, sono “gli altri”. Naturalmente questo limite vale anche per ognuno di loro. Ognuno è un io che può muoversi liberamente, e questa libertà definisce l’individuo. Ma questa libertà ha dei limiti dati dalla libertà dell’altro: non devi invadere lo spazio dell’altro. Abbiamo un “io” che è libertà, un io per il quale il rapporto con l’altro è vissuto come uno stop.
La libertà del popolo di Dio non è di questo tipo: è libertà “per” il servizio, libertà dove il rapporto con l’altro è un rapporto positivo. La differenza sta proprio qui: tra chi considera l’altro come un limite alla propria libertà e chi lo considera anzitutto come un bisogno cui venire incontro, un bisogno da servire. Libertà come responsabilità, come un rispondere di qualcosa davanti a Dio, un rispondere dell’altro. La libertà dove l’essere prossimo non è più un punto di partenza, ma un punto di arrivo: è il “farsi prossimo”, è amare come ha amato Dio, Certamente, l’altro può avere qualcosa di amabile, mi posso persino innamorare dell’altro, ma non è questo che fa la sostanza del rapporto. La sostanza del rapporto è quando io mi faccio prossimo all’altro nella sua alterità da me., quando mi metto al suo servizio secondo le sue necessità.
L’uguaglianza : non è solo l’uguaglianza di fronte alla legge, un’uguaglianza che riguarda solo il cittadino non l’uomo. Qui vale la lezione marxiana: bisogna liberare la vera uguaglianza, l’uguaglianza delle condizioni di vita. Essa deve riguardare la situazione esistenziale, i bisogni, non solo l’essere uguali di fronte alla legge.
La fraternità: Marx l’ha tentata nel 1870 nella Comune di Parigi, ma mi pare sia durata un mese.
La fraternità è il popolo chiamato alla libertà come responsabilità, all’uguaglianza reale, e alla fraternità: perché quell’imperativo dato da Dio, che è l’imperativo categorico dell’amarlo con tutto il cuore, è, prima ancora, il suo indicativo. Lui ha amato l’umanità con tutto il cuore, e noi possiamo far nostro quel suo agire solo assumendolo come imperativo .
Libertà, uguaglianza, fraternità. Dicevo di Marx: nella comunità di Parigi tentò di costruire una anticipazione minima di quella sua utopia della società comunista che egli definì nel programma di Gotha: in quella società “ognuno darà secondo le sue capacità e riceverà secondo i suoi bisogni”.
Le capacità saranno per l’altro: l’amore in quanto attivo: e la fede: dar credito che l’altro farà lo stesso con me (riceverò secondo i miei bisogni). Questa è l’utopia biblica della terra promessa: vivere in fede e amore.
Marx ha visto bene l’utopia biblica (non è un caso che egli fosse ebreo, benché ateo); ma quell’utopia è il frutto. Ciò che Marx non ha visto è il seme. Ha creduto nella società organica, totalizzante, anche se non più di un organismo statico, ma dialettico, storico. Ha creduto nella violenza come “levatrice della storia”, come il negativo che prepara il positivo, l’antitesi di prepara la sintesi.
Ma l’utopia biblica è diversa. Uso due espressioni, una di Lévinas: “Ognuno di noi è il messia che porta sulle spalle il mondo” , e l’altra della tradizione ebraica. “Salvare un uomo è salvare il mondo”.
Ognuno di noi non è un seimiliardesimo di umanità, una piccolissima parte che scompare nel tutto; ognuno di noi è il messia che porta sulle spalle il mondo: cioè: ognuno di noi ha qualcosa da fare che può fare solo lui/lei. Dall’altra parte, salvare un uomo è salvare il mondo: è lo stesso principio trasferito dal soggetto dell’amore al suo destinatario.
La Bibbia chiama “cuore” l’uomo come soggetto dell’amore dovuto, e chiama “carne” l’uomo come soggetto di bisogno, l’uomo nella sua fragilità. Ora, la “carne” è portatrice di diritti, il “cuore” è soggetto di doveri; poi so benissimo che anch’io ho dei bisogni e potrò rivendicarli come diritti; ma allora si apre la dimensione di quali sono i diritti giusti, e qui lascio la parola al giurista.
Quando diciamo che vogliamo un’etica personalistica, si può parlare di “persona” in due accezioni: la persona-soggetto, che è portatrice di doveri, e la persona-destinatario, che è portatrice di diritti. E’ il “terzo popolo” che non è né organico né individualista ma responsabile e solidale.
Una notazione essenziale. Tutto questo è detto, in sostanza, nell’Antico Testamento; non c’è bisogno di appellarsi al Nuovo. E allora Gesù Cristo?
La risposta – telegrafica – è la seguente: Israele – e tutta l’umanità che esso rappresenta – ha tradito, rinnegato l’alleanza di fede e amore; ed è giunto a trasformare il proprio cuore in un “cuore di pietra”. Gesù è colui che, con la sua morte e risurrezione, ha ricreato il cuore dell’umanità, le ha dato un “cuore di carne” (che qui significa un cuore nuovo, un cuore vivo). E la chiesa, di questo cuore non è la detentrice ma il testimone.
Armido Rizzi
