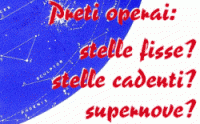
a cura dei PO del Veneto
«…A NOI NON HA DETTO NIENTE NESSUNO!»
Francesco, appena convertito, abbandonò la casa paterna e, tutto pieno di entusiasmo, si presentò ad una massa di poveri; mendicanti fuori della città.
Disse loro:
“Poveri! Dio mi ha appena convertito e, mandandomi a voi, mi ha detto di essere povero come voi poveri!”
Uno si alzò dal gruppo di mendicanti e disse: “A noi non ha detto niente nessuno!”.
(da T. Altan)
IL TESTAMENTO DEL MAESTRO
Monaci di questo monastero di montagna, ricordate che vi trovate qui per la religione e non per le vesti e il cibo. Finché avrete le spalle, [cioè il corpo], avrete vesti da indossare, e finché avrete una bocca avrete cibo da mangiare.
Ricordate sempre, nelle dodici ore della giornata, di dedicarvi allo studio dell’impensabile. Il tempo passa come una freccia: non fate che la vostra mente sia disturbata dalle preoccupazioni terrene. Sempre, sempre, state attenti.
Dopo la mia morte, alcuni di voi dirigeranno cinque templi in condizioni prosperose, con torri, sale e libri sacri decorati in oro e argento, in cui i devoti si affolleranno rumorosamente: alcuni passeranno le ore leggendo i sutra e recitando i dharani, e seduti a lungo nella contemplazione non si faranno mai prendere dal sonno; mangiando una volta al giorno e osservando i giorni di digiuno, praticheranno tutte le azioni religiose nei sei periodi della giornata.
Ma pur dedicandosi così all’ideale, se i loro pensieri non dimoreranno nella misteriosa e intrasmettibile via dei Buddha e dei Padri, ignoreranno la legge della causalità morale e finiranno nella completa rovina della vera religione.
Tutti costoro appartengono alla famiglia degli spiriti del male; per quanto lunga possa essere la mia assenza dal mondo, non potranno chiamarsi miei discendenti.
Fate però che uno solo viva in solitudine, in una capanna coperta da una fascina di paglia, e passi i suoi giorni mangiando radici di erbe selvagge cucinate in una pentola con le gambe rotte: se si applica con concentrazione ai suoi affari [spirituali], sarà l’unico a parlare tutti i giorni con me e a sapere come essere grato alla vita.
Chi potrebbe mai disprezzare una persona simile? Monaci, siate diligenti, siate diligenti.
Il consiglio di Daito Kokushi, maestro zen giapponese (1235-1308)
in D. T. Suzuki, Manuale di Buddhismo zen, ed. Ubaldini
DIO.
UNA CAPRA, UN BUFFONE,
UNA CANDELA, UNA VACCA
“Arrivano i miliardi alla ‘Viva il Parroco’. Stipulata ieri a Venezia tra il Credito Sportivo e la diocesi lagunare una convenzione per la rinascita degli oratori”.
dal Gazzettino di Venezia del 6 luglio 1996
«Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me».
Questi fanno di Dio una capra, e la nutrono con le foglie delle loro parole.
Fanno anche di Dio un buffone, cui regalano i loro vestiti vecchi e di poco valore.
M. Eckart, Commento alla Sapienza , ed. Nardini
Sappi che se cerchi in qualche modo il tuo bene proprio, non troverai mai Dio, perché non cerchi soltanto lui. Se cerchi qualcosa insieme a Dio, è proprio come se tu facessi di Dio una candela con la quale si cerca qualcosa, e quando si trova la cosa che si cerca, si getta via la candela.
M. Eckart, Opere tedesche , Nuova Italia
Certa gente considera Dio con gli stessi occhi con cui considera una vacca; ama Dio come ama una vacca. Tu ami la vacca per il latte e per il formaggio e per il tuo utile. Così fanno tutti quelli che amano Dio per la ricchezza esteriore o per la consolazione interiore; essi non amano veramente Dio, ma il proprio utile.
Sì, lo dico in verità: tutto ciò verso cui si dirige la tua intenzione, e che non è Dio in se stesso, non può mai essere tanto buono da non ostacolarti verso la più alta verità.
M. Eckart, Opere tedesche , Nuova Italia
«La religione fa nascere l’amore, ma il lavoro fa nascere il diritto, il rispetto della persona umana, l’uguaglianza; ed è per questo che la cooperazione fa nascere un’amicizia schietta che nulla può sostituire… È quest’amicizia che crea la pace. Non gli affetti che legano la famiglia, gli amanti, una certa specie di amici, e gli uomini che praticano la stessa religione… Questi affetti si nutrono troppo di un delizioso accordo che genera tutte le guerre.
«Così i fautori della pace non possono riunirsi in cerimonie religiose per cantare insieme… possono riunirsi solo per lavorare. Da qui il servizio civile.
«La cosa più difficile nell’amicizia sta nel vietarsi di amare il delizioso accordo; ma il fatto è che, se non ci si vieta questo, ogni amicizia va in rovina».
S. Weil in S. Pétrement, La vita di S. Weil, Adelphi
“E IO LAVORAVO CON LE MIE MANI E VOGLIO LAVORARE…”
(dal Testamento di S. Francesco)
VITA FRANCESCANA ED ESPERIENZA OPERAIA
(a cura di fr. Mario Faldani)
Premessa
Una comunità francescana a Porto Marghera
Nel 1970 la chiesa veneziana affidava ai frati minori conventuali il compito di seguire pastoralmente la complessa realtà del polo industriale. Si dava, con questa scelta, una certa stabilità ai vari tentativi volontari di “cappellani del lavoro” che già negli anni precedenti, in varie forme, avevano preso cura di tale problema.
La casa della diocesi è in una posizione strategica, in zona industriale, vicino alla stazione ferroviaria di Mestre ed al cavalcavia per Venezia, consente di essere raggiunta facilmente. Per questo è diventata “luogo” di incontro per vari gruppi.
Dal 1974 anche i PO Veneti hanno tenuto quasi tutti i loro incontri zonali in questa struttura.
Nel 1973 la comunità dei frati prende una sua fisionomia che la caratterizzerà per i successivi anni fino ad oggi.
Quale testimonianza francescana possiamo dare?
Quale forma di vita?
Decidiamo, interpretando la regola, vedendo l’esempio dei PO, di vivere col nostro lavoro e fare l’apostolato gratuitamente.
Da allora Luciano lavora come infermiere al Policlinico S. Marco di Mestre, Mario per 17 anni nella mensa di una grande fabbrica metalmeccanica (l’Italsider: poi varie denominazioni, fino alla cessione a privati) ed ora da più di 4 anni nella mensa (sempre a sopravvivere nei continui cambi di appalto) della centrale termoelettrica ENEL di Fusina.
Angelo e Tarcisio, liberi dal lavoro salariato, svolgono a tempo pieno la loro attività di Cappellani del lavoro.
Spesso nei nostri incontri PO la figura di S. Francesco si presenta come “icona” su cui meditare. E questo, secondo lo snodarsi dei vari temi: pluralità di lettura che storicamente è stata fatta della sua vita.
• S. Francesco tra “chiesa” e “vangelo”,
• movimento e successiva istituzione,
• laici e chierici,
• lavoratori o mendicanti,
• la rilettura del dialogo con Frate Leone sulla perfetta Letizia,
•la scelta della povertà, testimonianza, predicazione, eremo.
Per questo nella nostra ricerca abbiamo inserito una riflessione su S. Francesco. Ad aiuto abbiamo chiesto la presenza di uno studioso di S. Francesco e del periodo medievale: P. Vergilio Gamboso, conventuale, da poco insignito della laurea “honoris causa” per i suoi studi ed i suoi scritti sui primordi della nascita del francescanesimo. Dell’incontro con lui parliamo qui di seguito.
Relazione incontro con Padre V. Gamboso (5 maggio 1996)
Sono state due ore di colloquio. Non un’esposizione cattedratica, ma un ricchissimo “florilegio” di sottolineature, di approfondimenti su frate Francesco storico, come è possibile ritrovarlo attraverso le “vite” ufficiali, il suo testamento, e gli altri scritti dell’epoca successiva alla sua morte.
La “questione francescana”
Il capitolo Generale di Pisa nel 1263 approvò la “Legenda maior” di S. Bonaventura, ne distribuì una copia a ciascuna delle 34 provincie dell’Ordine. Il capitolo di Parigi (1266) decretò la distruzione di tutte le precedenti vite di S. Francesco. Per secoli Francesco fu visto con gli occhi teologici di S. Bonaventura.
Paul Sabatier, pastore protestante, innamorato di S. Francesco, nel 1894 scrisse la “Vie de saint François”. Per il Sabatier lo “Specchio di perfezione” fu scritto nel 1222 e quindi il Cel 1 fu la risposta ufficiale voluta dalla Chiesa e dai superiori dell’Ordine per coprire il dramma di un S. Francesco che negli ultimi anni della sua vita non ritrovava più nel suo ordine gli stimoli iniziali del suo vivere evangelico. Successivamente il Sabatier riconosce di aver sbagliato nel datare lo “Specchio di perfezione”, ma continua ad affermare che S. Francesco nel suo Testamento lasciava trasparire quel dramma tra il suo ideale e l’impostazione che l’Ordine stava assumendo per le imposizioni della curia romana.
La questione si può riassumere: il Cel 1 e gli scritti ufficiali ci presentano il vero S. Francesco, oppure sono le compilazioni anonime, non ufficiali a rappresentarcelo?
Ancora oggi per alcuni il Celano non conobbe S. Francesco, ne fece una versione ufficiale per dare man forte alla corrente vincente e normalizzatrice dell’Ordine.
Per l’altra parte il Celano è la prima fonte storica ed autentica. Noi possiamo porci a metà strada: il Celano ci presenta Francesco in un modo scrupoloso, ma seguendo i canoni agiografici del tempo e deve essere integrato da elementi delle fonti non ufficiali, dagli stessi scritti di S. Francesco e da documenti che non contraddicono gli scritti.
Forma di vita
“Nessuno sapeva dirmi cosa avessi da fare. Fu l’Altissimo stesso a rivelarmi che dovevo vivere a norma del S. Vangelo”.
Il regista è l’Altissimo. Il movimento penitenziale di Assisi è opera di Dio. Francesco non si guarda attorno, non contesta la “corruzione” della chiesa, non spinge lo sguardo nel passato per trovare “una regola”, un maestro, predecessori o esperienze analoghe. “Rivelare”, più che un gesto soprannaturale, sembra essere l’atteggiamento di umile ascolto del Vangelo.
“Feci scrivere con poche parole un testo, e il signor Papa me lo confermò”. È la cosidetta Protoregola: frasi ricavate dai vangeli. Questo storico promemoria non ci è stato conservato: esso è stato per i primi anni del movimento dei penitenti continuamente “riletto”, accresciuto di passi biblici e di adattamenti secondo le esigenze della rapida evoluzione, fino ad approdare alla Regola non bollata, come formulata nel Capitolo del 1221.
“Confermò”. È il carisma di Pietro (Lc.22,32): “Conferma i tuoi fratelli”.
Ma questa regola non piacque perché faceva troppo affidamento a ispirazioni soggettive: “Come lo Spirito Santo ispirerà …“. Immaginiamo un legislatore che stabilisce una norma, ma preveda che se per caso lo Spirito Santo ispira diversamente, uno ne può fare a meno! Crolla tutto l’impianto giuridico.
Era questa la preoccupazione della Curia romana e di parte dei frati colti. Infatti nella redazione della “Regola bollata” del 1223, vengono eliminati molti degli aspetti di questa curiosa concezione dell’ordinamento della vita religiosa.
Francesco visse lui stesso il fallimento del suo progetto iniziale. Forse, percependo la necessità storica di quel che avveniva, si isolò, si ritirò alla Verna. Non fece il contestatore, abbandonò ogni potere nell’Ordine, e nel Sacro Speco cercò la sua “conformazione” a Cristo che si materializzò nelle stigmate.
L’utopia di Francesco muore con lui? Fede è anche “memoria” che sa riscoprire nei meandri del passato i punti caldi in cui fiorì l’esigenza evangelica.
Testamento…
(un ricordo, un’ammonizione, un’esortazione).
Francesco parla in prima persona della santa utopia da lui vissuta in persona e in gruppo. Arrivato al traguardo vuole richiamare e ribadire alcuni punti essenziali del suo neo-evangelismo: si sente come indebitato verso la sua famiglia, così cresciuta e problematica. Non c’è tono di commiato: il Serafico si sente fisicamente affranto, ma non ha smesso la speranza di una ripresa fisica.
Non, dunque, una serie di “ultime volontà”; bensì un appello pressante a non scordare le origini, così sofferte e fervorose, a ritrovare gli slanci e la generosità che gli anni sono venuti appannando, un rinnovato confronto con la dedizione della prima ora. “Sii quello che hai cominciato ad essere”.
Precedentemente i vari movimenti “penitenziali” o si erano monasticizzati ed avevano finito la predicazione itinerante, o si erano opposti al clero indegno e divennero eretici.
Il problema per i francescani non era tanto quello di cadere nell’eresia, dato l’atteggiamento cristallino di rispetto e devozione a tutti i sacerdoti e alla gerarchia, quanto quello di “conventualizzare” il movimento. Il Papa e la Curia indubbiamente favorirono l’evoluzione verso la clericalizzazione e l’Ordine accettò questa normalizzazione. Nel corso del 1300 gli “Spirituali” videro in questa evoluzione il tentativo interno all’Ordine attuato dai capi contro il volere di Francesco.
Vari storiografi moderni, a partire dal Sabatier, invocano materiali provenienti dal gruppo dei “compagni” di Francesco per vedere nell’evoluzione dell’Ordine il tradimento del carisma originario.
Già S. Bonaventura rispondeva così: anche la Chiesa iniziò da semplici pescatori e via via si perfezionò sino all’età di dottori famosissimi, così è avvenuto nella religione di frate Francesco.
Damnatio memoriae
Lascia sconcertati la damnatio memoriae in cui vediamo cadere la famiglia di Francesco. Spariti. In deroga alla norma “nemo propheta in patria sua” Francesco nacque, visse la maggior parte dei suoi giorni, morì, fu sepolto e glorificato ad Assisi. Troviamo descritta a colori roventi la scena del diseredamento, mai ci imbattiamo in una parola di superamento della crisi. Lui che è l’apostolo della pace. È il suo dramma segreto. Un rappacificamento può esserci stato, ma nessuno ha perso tempo a registrarlo. Pensiamo però che Francesco ci tenesse ad osservare i comandamenti!
E per chiostro il mondo
Il “Sacrum commercium”, (non nozze mistiche, come poi fu interpretato e dipinto da Dante e Giotto, ma “patto sacro” con Madonna Povertà), si chiude con la richiesta, da parte di lei, di vedere il chiostro dei frati. La condussero su di un colle e le mostrarono il panorama tutt’intorno dicendo: “Questo è il nostro chiostro, Signora”.
Un ordine mendicante? Il lavoro
Nella “Regola bollata” (1223) il lavoro viene considerato un’attività occasionale, un esercizio esemplare per combattere l’ozio: non a caso nell’evoluzione dell’Ordine quando si parlerà di lavoro si intenderà lavoro intellettuale o “apostolico” non più manuale, riservato quest’ultimo al “servitium” dei fratelli laici via via meno numerosi e quasi esclusi dalle “cariche” riservate ai chierici.
Nel testo, invece, della “Regola non bollata” (1221) un intero capitolo riguarda l’attività usuale dei frati. “Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino …“.
Laboritium: un lavoro a giornata, precario, che spesso non dà a sufficienza neppure per mangiare, e solo allora … mendicare di porta in porta. In un’economia di sopravvivenza, com’era allora in Europa, la “mendicità” era un fenomeno normale. Unica eccezione alla povertà è la proprietà degli strumenti di lavoro (la vanga, la zappa …).
“Siamo minori”. Si dà concretezza al messaggio evangelico della povertà: rifiuto della proprietà, pratica del lavoro precario, “mendicità”; quando non si guadagni abbastanza, come accade agli altri poveri.
S. Francesco intende collocarsi tra le classi subalterne, identificate in quel tempo oltre che dalla povertà materiale anche dall’impotenza. Il contrario di “pauper” nel lessico medievale è “potens”.
Nel Testamento (1226), documento importante, scritto da una persona malata, a pochi mesi dalla morte. “Io lavoravo, e voglio lavorare, con le mie mani”. Il lavoro intellettuale non viene preso in considerazione. In una società analfabeta è una discriminante.
S. Francesco e i saraceni
Al tempo delle crociate anche Francesco prima della conversione aveva tentato di andarci. Dopo la conversione, riesce ad imbarcarsi, ma va senz’armi, insiste per andare dal sultano e riesce ad arrivare a lui come uomo di pace (1219). Nella Regola del 1221 ci sono delle norme per i frati che vogliono andare tra i saraceni che sembrano condensare la sua esperienza personale. Chiede ai suoi frati di vivere con mitezza, servendoli e semmai convertendoli con l’amore. Vede la possibilità di parlare agli infedeli in maniera pacifica, di rendere udibile la parola evangelica.
Oggi quasi tutti siamo convinti che la fede implichi il rispetto dell’uomo, il dialogo tra le varie fedi, e che le vie della salvezza possono passare anche fuori della Chiesa. Ma ci è voluto il Vaticano II !
Conclusione
Se Francesco tornasse? Troverebbe una sua collocazione all’interno delle molteplici attività dell’ordine dei frati minori: il penitenziere in un santuario, il parroco, aprirebbe un centro per riabilitare gli handicappati o i tossicodipendenti? Farebbe il preteoperaio? Chissà! A tutti chiederebbe se la forma vitae è l’evangelo.
P. Chenu nel n. 9 di Concilium/1981… paragona l’impatto dei penitenti di Assisi alla nascita dei PO in Francia. Ma con una grande differenza. I penitenti d’Assisi fu un movimento di laici che volevano, vivendo la forma di vita evangelica, fare la Chiesa altra, e che la Chiesa ha clericalizzato; i PO sono un movimento di “chierici” che vuole declerizzare la Chiesa favorendo una forma di vita evangelica.
Dal seminario di Lonigo ci è venuta forte la riflessione di tener presenti sempre le due icone S. Pietro e S. Giovanni. Una è legata all’altra. Istituzione e mistica per vivere hanno bisogno di convivere.
Un “pazzo” da slegare
Francesco da slegare dalle leggende e anche, per così dire, dalla santità collocata in una nicchia. È un santo da far ricircolare, perché nel suo modo di avvertire una Chiesa diversa e di voler testimoniarla, non c’è soltanto una mirabile espressione delle possibilità umane scritte nel passato, c’è uno spezzone di futuro”. (E. Balducci in “Francesco ‘pazzo’ da slegare”).
”CHI NON VUOL LAVORARE NON MANGI…”
Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino per servire presso altri o per lavorare, non facciano né gli amministratori né i cancellieri, né presiedano nelle case di coloro a cui prestano servizio; né accettino alcun ufficio che generi scandalo o che porti danno alla loro anima; ma siano minori e sottomessi a tutti coloro che sono in quella stessa casa.
E i frati che sanno lavorare lavorino ed esercitino quel mestiere che già conoscono, se non sarà contrario alla salute della loro anima e che onestamente potranno fare.
Infatti dice il profeta: Se con la fatica delle tue mani, mangi, beato sei e t’andrà bene; e l’Apostolo: chi non vuol lavorare, non mangi. E ciascuno rimanga in quel mestiere e in quella professione cui fu chiamato. E per il lavoro prestato possano ricevere tutto il necessario eccetto il denaro.
E quando sarà necessario vadano per l’elemosina come gli altri poveri.
E possano avere gli arnesi e gli strumenti necessari al loro mestiere.
(S. Francesco, Testamento)
MERCANTI IN FIERA
I «ricordini» che un’agenzia pubblicitaria aveva fatto confezionare e messo in vendita in occasione del viaggio del capo della chiesa cattolica sono rimasti massicciamente invenduti. Non si trattava di poca cosa: il magazzino dei gadgets papali comprendeva la bellezza di 250mila articoli, che i berlinesi, ma anche i fedeli venuti da altre città tedesche e dalla non lontana Polonia, hanno snobbato clamorosamente. Così delle 40 mila candele papali da usare per il rito allo stadio e poi tenersi in ricordo, ne sono state smerciate appena 900. Delle 12mila magliette bianche e gialle con le chiavi di S. Pietro, 11 mila sono rimaste sulle bancarelle. Né meglio è andata con gli ombrelli, le borse, le monete-ricordo, i berrettini.
dai giornali del 18 agosto ‘96
Primo S. Antonio. Seguono di stretta misura la Madonna di Pompei e la Madonna dell’Arco. Sono loro tre a guidare la hit parade dei tremila santi in archivio alla B. N. Marconi, azienda tipografica genovese leader in Italia del settore pubblicazioni sacre, specie per quanto riguarda il segmento «santini». Dalla B. N. Marconi parte la quasi totalità di immaginette sacre destinate alle parrocchie italiane. Senza contare quella buona parte di produzione che viaggia verso l’estero, secondo le richieste di un mercato all’apparenza tutt’altro che statico, specie da quando guarda ad est senza più nessuna cortina di ferro a fare da barriera.
dai giornali del 22 febbraio ‘96
È costume, dice quest’Anima, dei mercanti, che nel mondo sono detti villani, e villani sono, poiché certo un gentiluomo non sa impicciarsi di mercanzie, né essere per se stesso. Ma vi dirò, dice quest’Anima, che riguardo a tal gente mi darò pace, perché, sire Amore, sono estromessi dalla corte dei vostri segreti, così come lo sarebbe un villano dalla corte d’un gentiluomo in un giudizio tra pari, dove nessuno può stare, se non è di lignaggio – per lo meno alla corte del re.
Margherita Porete, Lo specchio delle anime semplici, ed. Paoline
CHE DIRANNO PRETI, FRATI, SUORE E MONSIGNORI?
Amico, che diranno le beghine, e la gente di religione, quando udranno l’eccellenza della nostra divina canzone? Le beghine dicono che erro, e preti, chierici e predicatori, agostiniani carmelitani, e i frati minori, per ciò che scrivo dello stato dell’Amore nobilitato. E non salvò la loro Ragione che li fa attribuirmi queste cose. Desiderio, Volontà e Timore certo tolgono loro conoscenza, e l’affluenza e l’unione nell’altissimo lume dell’ardore del divino amore.
Margherita Porete, Lo Specchio delle anime semplici, ed. Paoline
SAN FRANCESCO E IL LAVORO
Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione, così che, allontanato l’ozio, nemico dell’anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre cose temporali. Come ricompensa del lavoro per sé e per i loro frati ricevano le cose necessarie al corpo, eccetto denari o pecunia, e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.
Testamento, V, 2-5
E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare, e tutti gli altri frati voglio che lavorino di lavoro quale si conviene all’onestà. Coloro che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l’esempio e tener lontano l’ozio.
Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l’elemosina di porta in porta.
Testamento. VI, 24-26
