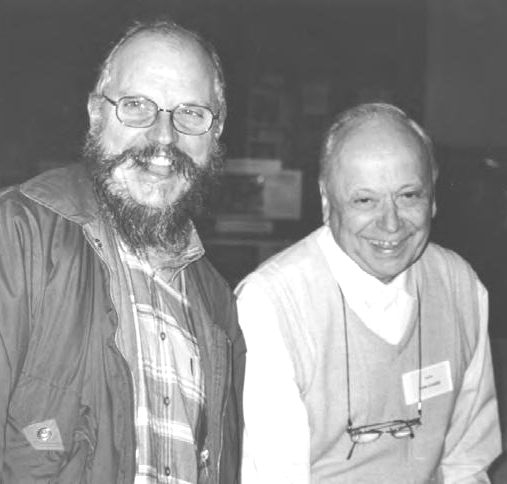Scritti di Carlo Carlevaris (2)
Uno scritto pubblicato sulla nostra rivista nel maggio 1995.
L’avvio della presenza di preti in fabbrica era cominciata nel 1942-43 con dei generosi sacerdoti che durante quel periodo di guerra avevano scelto di stare accanto ai lavoratori nelle fabbriche, sotto i bombardamenti, in situazione di sfollamento serale dalla città, in un tempo di fascismo esaltato agli inizi della guerra, nel tempo del “vincere”, e sospettoso all’epoca del “resistere”, negli ultimi mesi del conflitto. Qualcuno di loro era in rischioso contatto con le organizzazioni della Resistenza facendo anche da collegamento tra la fabbrica e i partigiani in montagna.
Alla fine della guerra, in epoca di Consigli di Gestione, formalmente guidati dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) ma controllati dal PCI, questi preti – Cappellani del lavoro – ebbero momenti difficili, ma gli operai stessi li sostennero riconoscendo la loro dedizione e coraggio durante la guerra e la Resistenza.
L’opera dei Cappellani del lavoro continuò sino agli anni del Card. Pellegrino con difficoltà, critiche e pesanti interventi del padronato e della Chiesa. Attualmente è notevolmente ridotta, pressoché inesistente.
La “Missione operaia” degli anni ‘66 prevedeva la presenza dei PO all’interno di una diversa “strategia” della Chiesa locale, non più orientata prevalentemente alla “pastorale” nel senso tradizionale, ma all’“evangelizzazione dei poveri” individuati in modo particolare negli operai, venuti dal sud per lo sviluppo delle aziende piemontesi.
Nel 1967 per interessamento di P. Pellegrino, Giovanni Carpenè e Luisito Bianchi furono accolti come pretioperai dal Vescovo di Alessandria e nel 1968 Carlo Carlevaris ottenne di andare al lavoro entrando in un’azienda metalmeccanica.
Negli anni successivi, ‘70-’75, la presenza in fabbrica dei PO si consolidò in particolare a Torino, ma anche ad Alessandria, Casale, Ivrea, arrivando a oltre venti-venticinque.
Alcuni chierici che, nell’ambito della Missione Operaia, avevano accettato di lasciare temporaneamente il seminario nel 1966 per andare a vivere in quartiere, gestendo la propria vita in piccole comunità e lavorando in fabbrica, divennero preti: con alcuni di loro si avviò la Gioc.
Attualmente i PO in Piemonte (Torino, Alba, Ivrea), collegati nel collettivo regionale, sono sedici, di cui tre pensionati e alcuni in CIG. Da diversi anni non abbiamo avuto nuove presenze.
I nostri rapporti con le comunità sono vari: alcuni sono in parrocchia, altri fanno riferimento a comunità di base, o sono impegnati nella Gioc e nel movimento degli adulti ex-giocisti. La maggioranza ha responsabilità nelle organizzazioni sindacali.
Il collettivo si riunisce regolarmente un giorno al mese e riflette sulla vita di lavoro e sul rapporto con la chiesa e la società.
L’anno ‘54 è stato per me la svolta della mia vita, il momento in cui mi si aprivano le porte della fabbrica. Iniziavo allora un tempo, che non è ancora finito, in cui una conversione profonda di idee e sentimenti, una scelta di stili di vita, una concezione nuova di presenza nella società e nella Chiesa hanno accompagnato e trasformato la mia esistenza.
Da assistente di Azione Cattolica ad accompagnatore di gruppi di militanti giovani ed adulti, da cappellano del lavoro a preteoperaio, da prete “per” gli operai a delegato sindacale: sono stati questi i successivi passaggi all’interno di un contesto sociale che si modificava e di una Chiesa che precedeva il Concilio e da cui veniva trasformata.
All’epoca del mio ingresso in fabbrica come cappellano nel 1954, si parlava dei pretioperai come di uno strano fenomeno tipicamente francese, in un tempo in cui quella chiesa era all’avanguardia nella ricerca pastorale, formulava ipotesi di parrocchie missionarie ed esperienze di ardite sperimentazioni liturgiche.
A guardare a quelle realtà mi spinsero le difficoltà a vivere le condizioni di oppressione del neocapitalismo aziendalista in Fiat nei confronti dei militanti di sinistra, ma anche la constatazione dell’inefficacia dei metodi pastorali ed educativi della pastorale della Chiesa che cresceva dei buoni “servitori” dell’istituzione, ma non preparava dei militanti operai per il sindacato e per la politica, cioè per la doverosa lotta per la giustizia nella società.
.
Ho tra le mie carte una raccolta di articoli di vari giornali italiani e francesi che si apre con uno scritto di M. Georges Hourdin dell’8 ottobre 1953. Quei fogli ingialliti sono l’espressione sincera di un uomo di studio che ha conosciuto direttamente alcuni pretioperai, di cui descrive con ammirazione la dura e semplice vita di quartiere, ma anche di un curioso giornalista che si interroga sul significato della presenza della Chiesa nella società, di un suo nuovo modo di essere missionaria in un contesto di scristianizzazione della classe operaia.
Sono i giorni che seguono gli interventi del Vaticano (27 luglio ‘53) che proibiscono ai seminaristi di andare a lavorare in officina come operai, e ritardano l’apertura del Seminario della Missione di Francia a Limoges.
La Missione nata nel 1943, formata da preti e seminaristi che intendono dedicarsi agli ambienti non cristiani, seguita nel 1944 dalla Missione di Parigi, aveva previsto e realizzato degli “stages” di seminaristi al lavoro nelle fabbriche. L’intervento del Card. Pizzardo giunse non improvviso, ma ugualmente sconcertante. Molti vi scorsero la decisione di sopprimere i pretioperai, già ormai presenti da almeno 10 anni; altri si rifiutarono di ritenere vera quest’intenzione.
Daniel Rops ne “Il Nostro Tempo” di Torino dell’11 ottobre 1954 scriveva:
“Nulla è dunque più assurdo che immaginare che i vescovi di Francia possano rinunciare da un giorno all’altro a queste forme nuove di apostolato e che la Chiesa ricada in una sorta di inerzia che converrebbe a qualcuno!”
Il 1° di novembre “L’Unità” riporta un articolo di Gianni Rocca che cita l’intervento di un preteoperaio:
“La nostra fede cristiana non ci impone nessun orientamento sistematico sul piano temporale. Essa non ci impone di essere conservatori, riformisti o rivoluzionari, ma esige che lealmente e seriamente ci occupiamo dei problemi che incontriamo e di cui cerchiamo generosamente le soluzioni che ci sembrano migliori. Ci si accusa spesso di fare il gioco del comunismo; bisogna però cercare, se vogliamo essere obiettivi, di non fare neppure il gioco della reazione, della repressione e di tutta una serie di ingiustizie e di miserie”.
La citazione del giornale del PCI è certamente interessata, ma l’intervento del preteoperaio risentiva dell’atmosfera che circondava la loro condizione.
È di quei giorni un importante intervento di P. Yves Congar, citato da Giovanni Barra su “Il Nostro ‘Tempo”, 11 ottobre:
“È evidente che la gerarchia mandandoli nelle fabbriche non aveva previsto tutte le conseguenze effettive del loro impegno. Essi stessi, del resto, come potevano prevederle? La gerarchia non aveva potuto prevedere né avallare parecchie modalità concrete di questo impegno, riguardanti la forma di vita e i modi di tener fede agli impegni fondamentali del sacerdozio… Succedeva che, in certi pretioperai, lentamente l’operaio corrodeva il prete… L’identificazione in una determinata classe sociologica pare avesse, almeno in alcuni, obnubilato il sentimento della trascendenza del sacerdozio… Diciamo tuttavia che, per parte nostra, quando abbiamo verificato alcuni fatti conclamati, il loro contesto e il loro senso ci sono sembrati ben diversi da quelli che si attribuiva loro”.
Daniel Rops nel citato articolo concludeva:
“Allora ci si domanderà: che cosa significano i recenti avvenimenti? La risposta è estremamente facile da ammettersi da uno spirito non prevenuto. Tutti questi tentativi nuovi sono, per loro natura, giovani ed audaci; gli uomini che ci si impegnano scendono in battaglie alle frontiere del cristianesimo, in condizioni difficili, in cui devono improvvisare costantemente e risolvere da soli innumerevoli problemi nuovi. È dunque normale che ci siano stati dei passi falsi, degli errori di visuale, delle prese di visione che la Chiesa, nel suo insieme, non può ammettere. Nessuno, e prima di tutti coloro che sono impegnati in questi tentativi, negherà che sia necessaria una battuta di arresto per fare il punto e ricominciare quindi da nuove basi.
”Questo procedimento è normale, diremo costante, nella Chiesa da sempre. …L’abate Godin, che fu all’origine di molti di questi tentativi giustamente parlando dei vescovi che ‘essi sono ai freni, noi al motore; le due guide sono indispensabili’…”
“Ma, conclude D. Rops, “chi crede che un gran frego verrà tirato su dieci anni di storia cristiana, avrà il torto di essersi rallegrato troppo presto: gli avvenimenti futuri potrebbero deluderlo”.
La “Gazzetta del Popolo” del 6 novembre scrive della visita in Vaticano dei cardinali Liénart di Lilla, Gerlier di Lione, Feltin di Parigi per riferire sull’Assemblea dell’episcopato francese nella quale è stato esaminato anche il problema dei pretioperai e dell’Azione Cattolica Operaia. Il comunicato citato nell’articolo diceva tra l’altro:
“I delegati dell’assemblea presenteranno a Roma le conclusioni del loro lavoro e questo vuol dire soltanto che i desideri dell’Episcopato francese sono diretti a mantenere le speranze di coloro che hanno fiducia nei pretioperai…”
“La Stampa” a Torino il 29/10 in un articolo a cinque colonne firmato da Sandro Volta e titolato: “Il Vaticano contro l’episcopato francese. Lo spirito del cristianesimo e l’attività dei PO”, scriveva:
“Con la vita esemplare sono riusciti a suscitare la confidenza e l’affetto della gente infelice, ma sono accusati di aver sposato la lotta di classe”.
L’articolo cita la visita del Nunzio Mons. Marella ai vescovi di Parigi, Lione, Tolosa, e altri “con il conseguente suo invito a richiamare quei preti facendoli rinunziare al loro apostolato tra le masse”, e dice della reazione negativa dell’episcopato e “l’attesa del giudizio definitivo del Santo Padre”. L’articolo cita pure G. Houdin e “lo spirito di larga comprensione dell’episcopato francese”.
Altre voci si levarono in quei giorni in Italia. “Il Nazionale” il 25/10 era uscito con un articolo di Giulio Castelli: “Cappellani del lavoro e non pretioperai”. Vantandosi di aver previsto “il grave pericolo rappresentato da questa ‘novità’ che riscuoteva le simpatie del giovane clero francese”, vedeva nei provvedimenti della Chiesa “la più ampia e autorevole conferma”.
Questo pericolo era tanto più evidente per il fatto che
“i giornali sinistroidi, che all’inizio dell’esperimento avevano gridato contro il subdolo tentativo dei preti di penetrare sotto mentite spoglie nelle officine per impaurire gli operai…, oggi appaiono stranamente concordi nell’affermare che il divieto del Santo Ufficio è indice della perdurante mentalità antiquata della Chiesa contro la classe operaia, e sopratutto del timore – che la Chiesa ha – che il clero, messo a contatto con la vita dura del lavoratore, ne sposi la causa e ne accetti le dottrine materialistiche”.
L’articolista propone l’alternativa della figura del Cappellano del lavoro e cita i tre presenti in Fiat.
È vero che prima dell’esperienza dei PO, in Italia Mons. Baldelli fin dal 1928 aveva
“avvertito la necessità di portare l’insegnamento e il conforto religioso tra gli operai nelle fabbriche…, affidando così al sacerdozio quel nuovo compito cui oggi attendono, bene organizzati e diretti, i Cappellani del Lavoro”.
Noi eravamo fra quelli e abbiamo ritenuto per alcuni anni che quella fosse la più avanzata presenza tra i lavoratori nelle fabbriche: il passare la giornata con loro, il mangiare col gavettino il pasto portato da casa e consumato seduti al “refettorio” o per terra vicino ad una macchina conversando con essi, il partecipare a infinite discussioni sulle loro vite e sulle loro condizioni di lavoro, il consentire più tardi alle loro sofferenze in una libertà sindacale soffocata, il restare fuori dai cancelli con loro nello sciopero per i licenziamenti, era allora quanto sapevamo fare.
Lo stalinismo nelle fabbriche prima e la repressione delle direzioni aziendali dopo incidevano profondamente in noi e ci costringevano ad una continua revisione del nostro ministero.
Il comunismo che abbiamo vissuto negli anni ‘50 non è quello degli anni ‘70, nè tantomeno quello di oggi: questo, forse, hanno difficoltà a capire quanti, preti o laici credenti, sono entrati nell’impegno nella seconda fase, dopo lo stalinismo. Ma anche gli anni ‘60, caratterizzati dalla reazione del padronato nei confronti dei sindacalisti comunisti e non, sono stati un crogiuolo di idee e di sentimenti, di grandi sofferenze e sacrifici sino all’essere stati buttati fuori dalla fabbrica con le stesse accuse con cui in Francia erano stati soppressi i pretioperai.
Fu a questo punto che l’idea di saltare il muro, di assumere la condizione operaia, di superare l’essere “per” loro e “con” loro, che avevano già faticosamente vissuto e pagato, e di incominciare ad essere “come” loro, divenne irresistibile. Da cappellano del lavoro a preteoperaio: da solo, tra l’incredulità dei più e l’ostilità di molti.
Tutta la vicenda dei pretioperai francesi e belgi che ero andato a conoscere negli anni precedenti mi era chiara davanti. Quello che non avevo saputo allora e potuto fare più tardi, adesso mi era possibile grazie ad un vescovo eccezionale, Padre Pellegrino, che come Suhard e Feltin rischiava l’impopolarità e si metteva sulla loro strada. Nacque la Missione Operaia.
Nel 1966 undici seminaristi di teologia lasciarono il seminario per andare in fabbriche, quattro suore insegnanti divennero operaie, una decina di operai tentarono con i pretioperai la strada verso il sacerdozio restando al lavoro (operai-preti), la Gioc iniziò il suo cammino in Italia.
.
Trovo ancora, tra le mie carte, un articolo di Louis Rétif, parroco nella periferia di Parigi, pubblicato da “Adesso” nel 1953: è una meravigliosa e pacata testimonianza. Parla dei due pretioperai che vivono con lui in parrocchia e dei quali dice:
“mi hanno insegnato a guardare con occhio nuovo la vita operaia… sotto la loro influenza imparai di nuovo a credere nell’uomo… un’esperienza umana mi sembra indispensabile per la maturità del sacerdote”.
Credo di dovere in buona parte a L. Rétif, con cui ho convissuto alcuni periodi nei momenti più difficili della mia vita, l’avvio della scelta operaia.
.
Tra le carte trovo ancora numerosi articoli dal ‘53 al ‘59.
Ci sono note che confrontano i pretioperai con i “missionari del lavoro”, i preti del “Mondo migliore” di P. Lombardi, i Cappellani di fabbrica in Inghilterra e la contrapposizione con le “équipes dei laici missionari nelle fabbriche” di Pio XII.
C’è anche un articolo di Lorenzo Bedeschi (Il Nostro Tempo 3/54) che riferisce di un incontro con A. Depierre, una delle più luminose figure dei primi PO. Racconta di François Mauriac che dopo aver partecipato alla Messa in casa di Depierre scrisse sul Figaro:
“… mai il mio spirito si era così intriso di mistica cristiana del mistero”.
Ma l’articolo terminava con un pesante giudizio sulla decisione di Depierre espressa in quelle sofferte parole:
“Io obbedisco, ma non si deve condannare chi seguirà la propria coscienza”.
Forse Bedeschi non aveva sentito le parole di Feltin che di fronte alle recriminazioni di molti benpensanti, aveva detto:
“i pretioperai hanno bisogno più del nostro affetto e delle nostre preghiere che delle nostre critiche”.
Anche noi, pretioperai di oggi, risentiamo rarefarsi l’aria intorno. Non siamo più criticati aspramente come un tempo, forse siamo ritenuti più innocui, forse ruderi, memorie del passato, troppo pochi per contare… ma continuiamo ad “aver bisogno di affetto e di preghiera”, mentre perseveriamo in sintonia con i PO francesi, che dopo le tremende prove del ‘54 e del ‘59, hanno continuato o ripreso la loro vita di lavoro, di testimonianza e di annuncio del Vangelo in una classe operaia che ha riconosciuto e apprezzato ampiamente la loro presenza, in una Chiesa che li ha accettati con riserve e sospetti, ma in cui molti credenti, vescovi, preti e laici li hanno sentiti compagni di vita e di fede.
CARLO CARLEVARIS
CFR PRETIOPERAI N. 30-31 / MAGGIO 1995