CONVEGNO DI BERGAMO 2011
Il lavoro in carcere dovrebbe essere innanzi tutto un percorso di recupero delle persone. La pena inflitta, in generale, dovrebbe tendere a questo fine.
Il carcere di Lucca è il più antico di Italia. Era, come molti altri in origine, un antico convento. Tradizionalmente in questo carcere i detenuti impagliavano sedie, rilegavano libri, facevano lavori di falegnameria, sartoria, ecc. Tutto questo è completamente finito. Perché? Semplicemente perché non ci sono i locali e gli impianti a norma, e quindi non si può più fare niente. Addirittura la sezione femminile, che è una sezione bellissima a fronte di quelle maschili tuttora aperte, è chiusa perché le finestre danno sul corridoio e non direttamente nelle celle. Così le donne di Lucca che scontano pene definitive sono a Massa o a Pisa.
Ci sono leggi garantiste che vengono applicate praticamente alla lettera e finiscono per impedire la applicazioni di leggi davvero importanti come quelle che riguardano il recupero morale delle persone.
Quindi ora il lavoro all’interno del carcere di Lucca non c’è. O meglio, è ridotto alle poche possibilità che la stessa vita carceraria offre. C’è quindi lo “scopino” che fa le pulizie degli ambienti “a comune”, lo “spesino” che raccoglie gli ordini dei detenuti allo spaccio interno, lo “scrivano”… pochi lavori che vengono proposti in turnazione ai tanti che sovraffollano il carcere.
Il sovraffollamento non è fuorilegge (!). Il regolamento carcerario dice che ogni detenuto dovrebbe avere 7 mq a disposizione, mentre attualmente un detenuto a Lucca ha tanto spazio quanto l’interno di una cabina telefonica.
I detenuti possono uscire dal carcere per lavorare fuori con il cosiddetto articolo 21, ma l’iter burocratico è veramente complesso e in assenza di un lavoro di sensibilizzazione sul territorio le possibilità di lavoro offerte sono minime. Anche le disposizioni sulle misure alternative cozzano contro la realtà di tanti detenuti che non hanno un domicilio. E quindi se, come ora, nel Paese diminuiscono le possibilità di lavoro e di alloggio per tutti, quanto più la crisi si abbatte su coloro che sono svantaggiati e verso cui c’è diffidenza e pregiudizio.
Recentemente ho reso disponibili dei beni donati alla Parrocchia di cui sono incaricato, una grande casa e un ampio terreno, per trasferirvi un’opera diocesana, la Casa S. Francesco, che viene sfrattata dai locali in cui è nata. Così possono trovare alloggio, e quindi detenzione domiciliare, 18 persone e si apre la strada ad una cooperativa agricola per il lavoro dei campi dati in comodato gratuito.
Si tratta comunque di una possibilità offerta a pochi. Il carcere di Lucca è stimato dal Provveditorato della Toscana di una capienza variabile tra 90 e 110 detenuti, estensibile in emergenza a 135. Attualmente ce ne sono costantemente più di 190 con punte di 215.
Questo il problema del lavoro in carcere e del “dopo” carcere.
Ci sono poi i problemi della vita in carcere in generale. Personalmente all’inizio volevo rimanere cappellano volontario. Poi ho riflettuto sul fatto che solo chi appartiene alla struttura penitenziaria può essere libero e visitare ogni ambiente carcerario, anche il più chiuso, e ho deciso di essere cappellano a tutti gli effetti. Quindi posso avere contatto con tutti i detenuti, anche con quelli in punizione o in isolamento. Rimane il fatto che comunque, in quanto cappellano del carcere, sono lì per assicurare il diritto del culto per i cattolici. Cosa che ha dell’assurdo e chiama in causa la persona con la propria coscienza e il senso della libertà.
Io ho rapporti con tutti. Con un certo orgoglio dico che l’anno scorso ho avuto su domanda dei detenuti 2374 colloqui. Vengono tutti. L’ascolto permette di lavorare prima di tutto sulla presa di coscienza della loro condizione, della loro storia (che hai fatto?) per poter prendere una strada diversa (anche la vita carceraria ti spinge a prendere coscienza di quello che hai fatto, ma per insegnarti a non farti prendere sul fatto un’altra volta….). Prendere in mano le proprie relazioni e rileggere le “strutture interne” degli affetti, delle speranze che ognuno ha. Non è facile; soprattutto metterle in relazione con il dato religioso che stimo essere mio compito. C’è un 50%, ma forse meglio un 55% di detenuti di fede islamica. A loro mi rivolgo e cerco di fare questo lavoro parlando del Corano, che conosco e mi sono sforzato di conoscere sempre meglio, cercando una lettura non fondamentalista ma aperta ai valori e alle proposte. Sono contenti, in generale, e ritornano al colloquio ringraziando. Mi possono anche prendere in giro, ma altri segnali mi inducono a non credere sia così. Con altri, rumeni ortodossi per esempio, non c’è nessun problema a partecipare un discorso di vita che trova i suoi punti di forza nel credo religioso. Così con i protestanti.
Ritorno sul discorso del lavoro perché quando dei detenuti ottengono il permesso e trovano da lavorare fuori, sono diversi. Tra l’altro tutto il lavoro in carcere e fuori deve essere secondo i termini delle leggi, assicurato e garantito nei diritti sindacali. I detenuti al lavoro per esempio riscuotono anche la cassa integrazione. La retribuzione è comunque inferiore di un terzo rispetto a quella praticata in generale. Il fatto di poter avere anche quel briciolino di soldi che poche ore di lavoro permettono una vita diversa ai detenuti che ne godono la possibilità.
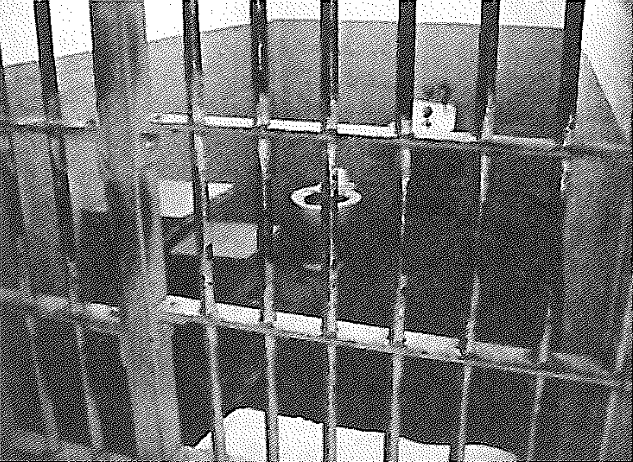
A chi entra in carcere, infatti, l’amministrazione penitenziaria da un materasso e un guanciale di schiuma di lattice, due lenzuoli, una federa, una coperta, un certo numero di piatti e posate in plastica, carta igienica e una saponetta. Se uno ha da lavarsi gli abiti (non c’è servizio di lavanderia), se non glielo fanno da casa, bisogna si compri il sapone. Se uno vuol prendere un caffè, fumare una sigaretta, se lo deve comprare. La lotta più grossa che si deve fare all’interno di un carcere è il controllo dei prezzi della spesa, e io di tanto in tanto mi rivolgo al Direttore e agli incaricati perché non ci deve essere approfitto in quel campo lì. Dall’esterno non può entrare dentro nulla che non sia strettamente controllato e ammesso da un rigido regolamento. Il problema più grosso è la droga: ho visto delle cose impensabili, le batterie delle radioline riempite di droga, bambine con la pallina di hashish attaccata alla passatina sui capelli in modo che il padre con una carezza se la porta via…
Tutto questo porta ad una situazione di restrizione per cui chi non ha soldi non fa niente. La prostituzione nasce di lì. Per avere qualcosa prima fai le pulizie, poi lavi i pantaloni, poi fai qualche servizietto e finisci per prostituirti a chi ti fa fumare, ti fa il caffè, ecc.
I detenuti non tengono soldi, c’è un conto corrente interno gestito dal personale amministrativo e chi ha soldi sul conto può fare la spesa. Io, per evitare il fatto umiliante di venire a chiedere soldi al cappellano, due volte al mese metto 10 euro sul conto di chi ha meno di 3 euro. L’anno scorso ho speso 20300 euro e rotti per questo. Naturalmente ho bussato alla Caritas, all’8 per 1000, alle parrocchie… ho messo le mani ovunque potevo tirar fuori soldi, perché io ritengo che sia un dovere di giustizia. Non è tanto, ma 20 euro al mese a chi non ha nulla, consente quel briciolino di dignità che ti impedisce di essere totalmente dipendente dagli altri e quindi schiavizzabile da altri.
Sono due anni e mezzo che vivo questa situazione e mi sono reso conto di queste povertà così esasperate dall’essere dentro una struttura che toglie la libertà.
C’è il problema dei suicidi, anche delle guardie si sono suicidate. Una situazione disumana.
Quello che conta è un minimo di rapporto umano. A Livorno, faccio un esempio, c’è un nuovo carcere, Le Sughere, e i detenuti che hanno conosciuto la vita del vecchio fatiscente carcere lo rimpiangono. Nel nuovo carcere sono cresciuti tutti i disagi. I nuovi carceri son fatti con dei moduli in cemento armato che convergono al centro, tutti dotati di cancelli elettrici con comando a distanza, telecamere da tutte le parti, una guardiola difesa da vetri infrangibili che impedisce anche il solo contatto con le guardie. Tra le guardie ci sono persone brave, meno brave, poco brave. Pessime non ne ho trovate, poco brave sì. Ma anche il conflitto verbale è una forma di rapporto. Quando io devo parlare con un altoparlante, l’ambiente è sovraffollato e invivibile comunque per la ristrettezza degli spazi, si rimpiange il vecchio carcere dove almeno un contatto umano con le guardie era inevitabile.
In un mondo di tale povertà, l’unica maniera di essere “ascoltati” è il suicidio o l’autolesionismo. Non è raro trovare detenuti che spezzano una lametta di rasoio e si incidono la pelle tagliuzzandola a volte con grave rischio per la vita o per lesioni permanenti.
Solitudini che gridano, tentativi un po’ furbeschi di passare qualche giorno in infermeria, tentativi di suicidio per richiamare l’attenzione finiti tragicamente magari perché chi doveva guardare non ha guardato… Storie che si ascoltano dai detenuti stessi che ne sono protagonisti.
Ci vorrebbe un lavoro molto più attento… io faccio quello che posso. Per il “trattamento” ci sono 3 educatori, ma di fronte a oltre 200 persone, cosa possono rappresentare?
