DON BORGHI NELLA GERMINAZIONE FIORENTINA
Il contesto (1)
Sono entrato in Seminario a novembre del 1962. Della Chiesa di Firenze non sapevo praticamente nulla. Qualche nome di riferimento: don Facibeni e il Cardinale Elia Dalla Costa; i ricordi dell’infanzia e della scuola e poco più.
In Seminario trovai “ragazzi” che discutevano su tutto, vivacissimi e pieni di curiosità, ed un grande Rettore: Monsignor Bonanni. Chiamati da lui per incontri, lezioni, ritiri, frequentavano il Seminario Padre Vannucci, Giorgio La Pira, Padre Balducci, don Borghi ed altri. Don Lupori e don Chiavacci erano insegnanti di teologia, don Parenti, Prefetto degli studi e Cappellano della FUCI. Da lui ho ascoltato una lezione sull’evoluzione della specie che ancora ricordo. All’inizio ho pensato che tutto dipendesse dal Concilio e dall’aria nuova che aveva messo in circolazione. Ma era vero solo in parte.
A Firenze si è sempre discusso di tutto, una tradizione con radici lontane, e Firenze non è mai stata clericale. A suo tempo il “non expedit” non ebbe alcun risultato ed i gruppi cristiani d’impegno sociale, promossi all’epoca da Roma, ebbero pochissimo successo.
Sia prima che dopo la seconda guerra mondiale avevano animato la città uomini e idee che attraverso riviste-cenacolo, incontri e confronti, avevano creato un humus che arrivava fino alla periferia. Una sequenza significativa di fogli e pubblicazioni: Giovani della FUCI; Vita cristiana dei domenicani di S. Marco, dalla quale filtrarono le idee d’oltralpe di Maritain, Mounier, Lagrange, Chenu, Congar e della Théologie nouvelle; Città di vita dei Francescani; Politica, il periodico di Nicola Pistelli; L’Ultima di Oxilia e Gozzini; fino a Testimonianze, orientata da Padre Balducci e da laici come Danilo Zolo e Luciano Martini; per non parlare della Libreria Editrice Fiorentina dei fratelli Zani, con le sue pubblicazioni.
Era una costellazione che faceva riferimento ad alcune figure di prima grandezza: Padre Coiro dei Domenicani di S. Marco, Don Barsotti e la mistica ortodossa a Settignano, Padre Vannucci e Padre Turoldo alla Santissima Annunziata, Padre Lupi e i suoi giovani alle Caldine, il Cenacolo di Padre Ciolini a Santo Spirito, gli incontri a Villa Lorenzi promossi da don Zaccaro della Madonnina del Grappa.
Erano incontri religiosi, politici, interculturali che calavano nel concreto come nei dibattiti degli “Incontri internazionali della pace e civiltà cristiana” del 1952-55, e poi in quelli dei “Colloqui mediterranei”. Questa circolazione delle idee si traduceva anche nella politica della città con La Pira sindaco di Firenze, alimentando i sogni, le speranze di singoli e di gruppi di laici e di giovani preti come don Borghi e don Milani, o divenendo azione pastorale in diverse parrocchie della periferia come la Comunità della Resurrezione a Rovezzano, ispirata da don Luigi Rosadoni, o quella del nuovo quartiere di case popolari – la città satellite – dell’Isolotto, dove erano parroci don Mazzi e don Gomiti.
Il Cardinale Dalla Costa sapeva apprezzare, anche da vecchio, queste iniziative. Egli fu in questa “germinazione fiorentina”, come la chiamò La Pira, una figura chiave, non perché fosse particolarmente progressista, ma perché lasciava spazio, perché capiva che erano fermenti utili per il futuro.
Sostenevano questa sua linea i Rettori del Seminario, Monsignor Bartoletti e Monsignor Bonanni, e due grandi figure di preti: Don Bensi a S. Michelino, sotto la cupola del Brunelleschi, dove passarono e si confidarono centinaia di persone di Firenze e di mezza Italia, e Don Facibeni, parroco del quartiere operaio di Rifredi, con i suoi orfani.
Sull’altro versante, “quello ghibellino” riviste come Solaria, degli anni trenta e quaranta, legata all’attività di sodalizi come il Gabinetto Vieusseux, criticamente aperta alle idee europee; e Il Ponte, d’ispirazione liberal-socialista, sotto la guida di Calamandrei e di Enriques Agnoletti, favorirono il confronto tra “umanesimo laico” e “umanesimo cristiano”, che fu la costante di quegli anni.
La Chiesa fiorentina, o meglio la parte più viva di essa, non difendeva se stessa, ma cercava l’incontro con gli altri. La fede era un argomento di confronto e non la soluzione dei problemi.
La situazione non era tutta rose e fiori. La grossa parte della Chiesa di Firenze, più tradizionalista, si riconobbe nell’azione del Vescovo Florit, che si diceva mandato da Roma come ausiliare per affossare La Pira e Padre Balducci ed in sostanza per contraddire l’operato del Cardinale che invece li aveva sorretti in vario modo.
I motivi dominanti della contrapposizione erano l’apertura ad una cultura laica e alla sinistra e alla nascita di un centrosinistra, a cui si opponeva il Vaticano, e quindi anche all’idea di una Chiesa non barricata in se stessa, ma che, anzi, si apre a proposte culturali diverse, sotto il segno di un’apertura mentale e spirituale verso gli altri.
In questa parte di Chiesa anche dopo il Concilio non ci furono significativi passi avanti, per il timore di ciò che le aperture del Concilio potevano portare. Il Cardinale Florit rimase il difensore della grande tradizione clericale, gradita al Vaticano. La spaccatura s’indurì e porto al grosso scontro sulla questione dell’Isolotto. Ma siamo ormai alla fine degli anni sessanta e inizia un’altra storia!
Renzo Fanfani
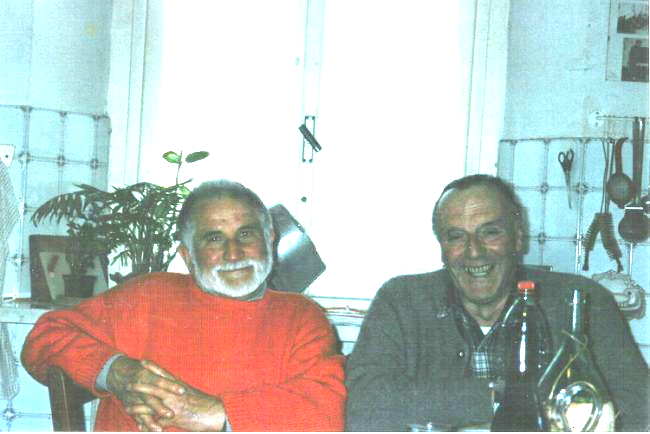
Bruno Borghi con Renzo Fanfani
