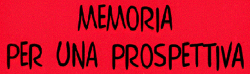
CONVEGNO NAZIONALE PRETIOPERAI
Salsomaggiore 25-27 aprile 1996
Presentazione di questo numero
Queste pagine riportano quanto i pretioperai italiani si sono scambiati nell’aprile scorso a Salsomaggiore in occasione del loro incontro nazionale […] L’incontro di aprile aveva come tema quello che viene riportato nel titolo di copertina: “memoria per una prospettiva”. Tale tema comporta una molteplicità di piani e di letture che, pur nella distinzione, si intrecciano insieme.
La prima lettura, la più immediata ed esistenziale per i partecipanti, si riferisce alla vicenda/storia dei pretioperai italiani che, se da un lato presenta caratteri di singolarità ed originalità rispetto ad analoghe esperienze fiorite in altri paesi del continente europeo, dal-l’altro ne condivide a fondo ispirazione ed orizzonti.
Fare memoria non significa abbandonarsi ad una equivoca nostalgia, ma riscoprire la linfa, l’energia interna, quella forza vitale ed originaria che un’esistenza fedele porta con sé, proprio nel mutare delle stagioni della vita e delle condizioni storiche.
Così la prospettiva non consiste tanto nell’immaginare forme di sopravvivenza della nostra “specie non protetta”, ma nel continuare a partecipare a quel “fiume di gente che, nelle condizioni subalterne, ha alzato la testa accettando il conflitto”, rifiutando il processo di “omologazione”. La prospettiva rimane quella che don Sirio indicava per se stesso in un libro di tanti anni fa:
«Dentro questo povero mondo, per dare tutto me stesso, non chiedendo assolutamente niente. Niente, nemmeno la simpatia, nemmeno perché credano quello che io credo. Solo la gioia, semplice e povera e bellissima, di trovarsi – ed è sempre con immensa sorpresa – sulla povera strada polverosa, perduto dentro queste folle sterminate, che camminano faticosamente…». (Uno di loro. Pensieri ed esperienze di un prete-operaio, Gribaudi, pag. 28).
Così la memoria per una prospettiva si propone e diventa interrogativo sul cammino di un mondo che sta rapidamente cambiando. “Si possono dire molte cose. Ma non si può dire che la situazione mondiale non stia cambiando. Nel mondo. Ed in Italia”.
Come articolare nel discorso questo cambiamento? Che parole usare per descrivere quanto sta accadendo così da avere lucidità e coscienza in vista di un’azione responsabile?
Anche se “sembra un’impresa impossibile il dire in poche parole ciò che sta succedendo nel mondo”, tuttavia è ricominciata la ricerca “delle parole giuste”.
Al termine del convegno ci si è lasciati con più chiara consapevolezza di questo compito che attende. Le “sette parole del nostro tempo”; la relazione di don Cesare, sono un tentativo di linguaggio comune, un vocabolario per una ricerca che ponga al centro l’interrogativo sulle prospettive che si profilano per i popoli che abitano questo mondo. Un vocabolario che è tutt’altro che elenco neutrale di parole. Esso è già una lettura fatta sotto il segno di una fortissima ed inquietante impressione: «sembra che una nuova dittatura, anonima e sottile, derivata da pensatori liberali fortemente ispirati dal culto della libertà, si stia imponendo: dittatura fra le più feroci, le più impietose, responsabile di milioni di persone stritolate sotto le ruote del “libero mercato”, elevato a divinità imparziale, oggettiva, implacabile».
Memoria e prospettiva vengono, infine, giocate per formulare ancora una volta l’interrogativo antico e sempre nuovo: “con quale volto il cristianesimo deve proporsi dinanzi al mondo e dentro il mondo?”.
È sconvolgente riascoltare l’alternativa semplice ed esemplare proposta da Francesco nel testo della vera letizia nella sua versione originale e completa. Tale alternativa non si coglie veramente, se si confina il messaggio nell’ambito di un ascetismo riservato a pochi eletti. Essa viene tradita quando se ne fa un uso perverso per iniettare rassegnazione politica nelle classi subalterne. La vera posta in gioco è la qualità stessa del cristianesimo nella sua incarnazione storica e nella sua più autentica identità.
Quale presenza storica in questo mondo che cambia? Come seguire le orme di Cristo nella concretezza della vicenda umana, in mezzo “alle folle sterminate che camminano faticosamente?”. Come stare dentro “al fiume di gente che ha alzato la testa accettando il conflitto?”.
Il mondo sta cambiando rapidamente. Quale cristianesimo storico e in funzione di quale prospettiva per i popoli che abitano la terra? Chiudo lasciando la parola ad una predica di Bonhoeffer del ‘32. Una profezia tragica, che non ha esaurito la sua attualità e che nella sua parte finale trova una singolare coincidenza con una nota pagina dì don Milani.
«È mai possibile infatti che il cristianesimo iniziato in modo così rivoluzionario, ora sia per sempre conservatore? Che ogni nuovo movimento debba aprirsi la strada senza la chiesa, che la chiesa intuisca sempre con un minimo di venti anni di ritardo ciò che è effettivamente accaduto? Se davvero è così, non dobbiamo meravigliarci che anche per la nostra chiesa torni il tempo in cui sarà richiesto il sangue dei martiri. Ma questo sangue, ammesso che abbiamo ancora il coraggio, l’onore e la fedeltà di versarlo, non sarà così innocente e luminoso come quello dei primi testimoni. Sul nostro sangue ci sarà il peso di una nostra grande colpa: la colpa del servo inetto, che viene buttato fuori nelle tenebre» (Scritti, Queriniana, pag. 153).
