Editoriale
«Padre Karl Rahner usava volentieri l’immagine della brace che si nasconde sotto la cenere. Io vedo nella Chiesa di oggi così tanta cenere sopra la brace che spesso mi assale un senso di impotenza. Come si può liberare la brace dalla cenere in modo da far rinvigorire la fiamma dell’amore?». Sono le parole del card. Martini, rilasciate nella sua ultima intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 3 settembre scorso.
Questo quaderno è nato dal lavoro di raccolta di testimonianze che narrano una storia d’amore, strana e unica, come ogni vera storia d’amore: sotto la cenere, come mille altre vite di cui nessuno parlerà mai, lontane dai riflettori. Ma qui gli amici si sono dati da fare per rompere il silenzio della morte e con la parola scritta e le immagini raccolte soffiano via la cenere perché la brace possa brillare nei cuori e nelle memorie e diffonda il calore anche su chi non ha conosciuto don Renato.
Anche su me che l’ho incrociato tanti anni fa nei convegni dei preti operai. Dopo aver perso i contatti, di nuovo ci siamo rivisti lo scorso anno e abbiamo a lungo parlato per telefono raccontandoci un po’ della nostra storia. Nella piccolezza e fragilità di una vita che si spande nella quotidianità, in somiglianza dei tanti che assaporano la fatica del vivere, avviene qualcosa di universale, un disvelamento che nella sua unicità attinge alla sostanza della rivelazione biblica ed evangelica. Da lui stesso, dalle parole che ci ha lasciato, vorrei cogliere qualche spunto che aiuti a intravedere il prezioso tracciato di questa vita.
Lo scherzo dei vescovi al Concilio
Renato scriveva al vescovo Bettazzi: “Sono tra quelli che non hanno capito che scherzavate, al Concilio, quando parlavate della Chiesa dei poveri… Siamo partiti da qui, dalla necessità di uscire dalla cultura e dalle istituzioni ecclesiastiche per capire il mondo a cui ci avete mandati; per fare nostre e rivivere con fede «le angosce, i dolori, le gioie e le speranze degli uomini, soprattutto dei più poveri…»”.
Un modo per dire che lui, come tanti altri, ha preso sul serio il Concilio, quello che Papa Giovanni XXIII chiamava una nuova Pentecoste. E non solo il Concilio, ma pure la parola di Paolo VI che nel suo documento del 1971 Octogesima adveniens annunciava a tutto il mondo l’invio di preti a condividere la condizione operaia: “Non è forse per essere fedele a questa volontà (diffondere le energie del Vangelo) che la Chiesa ha inviato in missione apostolica tra i lavoratori dei preti che, condividendo integralmente la condizione operaia, ambiscono ad esservi i testimoni della sollecitudine e della ricerca della Chiesa medesima?”.
Un dato di fatto, cioè una storia partita dalla Francia negli anni ’40, sospesa per decisione delle autorità ecclesiastiche romane nel 1954, seguita da un documento del Santo Ufficio del 1958 dove si sosteneva l’incompatibilità tra la vita del prete e dell’operaio; ma poi di nuovo l’apertura, la legittimazione, anzi l’impulso a questa nuova forma di ministero presbiterale ad opera del successore di Pietro. Quindi un impegno e una promessa dinanzi al mondo del lavoro.
Questo genere di preti sono sorti in quasi tutta Europa, nell’Europa che dopo la tragedia della guerra diventava una potenza industriale con il lavoro, tanto lavoro. In molti siamo partiti e con decisione personale. Per la maggior parte di noi italiani la partenza è avvenuta attraverso uno strappo. Vescovi e chiese locali, salvo qualche eccezione (card. Pellegrino, mons. Bettazzi), erano lontani mille miglia dal condividere davvero questa scelta.
Almeno in Italia, Paolo VI è stato come Giovanni Battista “vox clamantis in deserto”.
Se vogliamo un’immagine, può essere utile quella del deltaplano. La corsa con le proprie gambe e poi il lancio nel vuoto e il sostenersi nell’aria in una solitudine senza paracadute, certo anche con altri compagni di viaggio, ma ciascuno dovendo volare da solo, contando sulle proprie forze e dovendo tracciare la rotta in mezzo alle correnti d’aria favorevoli o contrarie.
Renato racconta come è cambiata la vita e anche il modo di vivere e di esprimere la fede. L’Evangelo non è nato nel tempio, nel culto organizzato, nella ritualità religiosa. È sorto all’aperto, in cammino, nell’incontro con la gente dove vive e abita, in riva al lago o sulla montagna, non nelle regge e nei palazzi dei potenti, ma nel contatto quotidiano con i poveri e le donne, con i malati impuri esclusi dal culto. Ma anche prima, nei lunghi e misteriosi anni vissuti da Gesù a Nazareth, conosciuto come “il falegname” (Mc 6,3).
E quando si seguono queste rotte, avviene una certa connaturalità con lo stile sobrio del Vangelo, e si sente tutta la pesantezza dell’organizzazione cultuale, del baricentro ecclesiastico che sostituisce quello del Regno di Dio, di cui è imbevuta la parola evangelica. E si respira la libertà dei figli di Dio che accompagna la nuova povertà scoperta non nell’isolamento monacale, ma condividendo la vita degli umani nella loro fatica di vivere e lavorare.
Dentro la fabbrica, e anche fuori
“Ho scelto la vita semplice, la vita dei poveri, quando ho avvertito il distacco storico tra la chiesa e il mondo operaio. Non me la sono sentita di restare fuori dallo scontro storico tra operai e padroni, lontano dalla lotta di classe”. Sono parole tratte da una sua intervista, riportata in questo quaderno, che risale all’estate del 1977 durante uno scontro durissimo con la direzione della Wierer, fabbrica di una multinazionale, da cui subì anche il licenziamento in quanto delegato sindacale.
Renato conosceva bene il valore delle parole. L’uso che ne faceva non era una ripetizione meccanica di slogan ricorrenti nel mondo operaio, ma era la fotografia della realtà in atto. Quando dice padroni rispecchia esattamente il dominio e l’imposizione determinata da interessi contrapposti, dove il lavoro umano è semplicemente una merce, una variabile economica. I lavoratori vengono presi in considerazione solo in base alla funzione e ai costi che comportano.
La poesia ispirata alla Bibbia che parla del lavoro umano quale collaborazione con il Creatore all’adempimento della creazione è lontana anni luce, mentre più realistico è il richiamo al “sudore della fronte” per dissodare una terra avara. Ma qui non è avara la terra, ma la sete del profitto da moltiplicare che agisce come un virus che a tutt’oggi contamina tutte le latitudini del pianeta.
Il risultato appare sempre più chiaramente come “un sistema globale che non è solo un sistema economico, ma una metafisica, una mitologia, una civiltà assolutizzata […] e opera come la principale fonte di infelicità organizzata, di sofferenza, di oppressione e di morte” (Roberto Mancini).
E Renato parla anche di lotta di classe. E qui aggrottano le ciglia non solo quelli che pensano in doppiopetto secondo l’etica neoliberista, la lingua comune del pianeta, ma anche quelli adusi al gergo felpato dell’ambiente ecclesiastico che hanno dimenticato la forza e la concretezza delle parole bibliche e delle beatitudini evangeliche. La lotta di classe la vediamo anche oggi perfettamente all’opera dentro e fuori la fabbrica. Non è certo la povera difesa che i lavoratori sono in grado di opporre, spesso in maniera disperata, con dinanzi sempre pronta la polizia schierata. È invece quella che una minoranza di padroni per lo più invisibili sta imponendo a tutto il mondo.
È quella che parla in maniera paternalistica ai giovani trenta-quarantenni d’oggi come a una “generazione perduta”, per dirla con le parole del presidente Monti, cattolico praticante; oppure si condanna la legge 300, che tutela i diritti dei lavoratori, perché avrebbe ostacolato la creazione di posti di lavoro, come ebbe a dichiarare recentemente lo stesso Premier. È sempre la stessa colpevolizzazione del lavoro e dei lavoratori, quella che troviamo narrata nelle vicende di Renato e compagni nella concretezza della fabbrica Wierer: è una forma di “cultura”, di ideologia che domina, espressione di una vera lotta di classe per togliere a chi lavora la dignità del proprio lavoro, fino a ridurre la reazione dei lavoratori a problema di ordine pubblico.
È quello che oggi vediamo alla Fiat, all’Alcoa, alla Carbonsulcis, all’Ilva di Taranto, dove addirittura vi è chi fa balenare l’alternativa idiota: o il lavoro con i tumori o niente lavoro con la salute. Gli errori e gli orrori compiuti da una politica ottusa e culturalmente dipendente dalla ventata neoliberista e le strategie dei detentori del capitale finanziario e produttivo, scaricano regolarmente sui lavoratori, sui cittadini e sull’ambiente i costi in funzione di un interesse lucrativo potenzialmente illimitato.
Basti un solo esempio: nell’ultimo quarto di secolo una quota molto elevata di ricchezza prodotta nei principali paesi industriali è stata trasferita in misura crescente dai salari ai profitti. “Per quanto riguarda l’Italia, si calcola che lo spostamento sia di circa 8 punti percentuali sul Pil, una cifra enorme, all’incirca 120 miliardi di euro” (Marco Revelli).
Ho notato anche che nei media cattolici da tempo la parola giustizia applicata alla realtà economica e sociale è praticamente desaparecida sostituita con linguaggi che evocano l’amore, la carità, tipo “la civiltà dell’amore” o “la carità sociale”. Sono modi di dire che concretamente oscurano il diritto intrinseco alle persone ad essere trattate “decentemente” nell’ambito lavorativo o come cittadini secondo il dettato costituzionale. Col risultato di degradare e di liquefare anche il senso altissimo e la densità biblica e teologica di cui tali termini sono portatori.
“Lotta come amore” è il titolo del periodico di cui don Sirio Politi, tra i primi pretioperai in Italia, è stato il fondatore. Un titolo inclusivo dell’istanza di giustizia. Così come la lotta sostenuta da Renato possedeva la densità di un amore che cercava ed operava la giustizia tra i compagni di lavoro, nella concretezza della fabbrica.
Comunità di vita: fraternità universale
Gran parte di questo quaderno è dedicato a raccontare gli “esperimenti“ di vita comune e condivisa nel tentativo di dare forma agli orizzonti scaturiti dal Concilio Vaticano II. Renato non è vissuto da solo. Già nel 1967, a due anni dalla fine del Concilio, iniziò con altri preti la vita comune in un contesto parrocchiale a Banchette di Ivrea (partiti in quattro, poi rimasti in tre, con don Nino e don Giovanni che assume la funzione di parroco). È il tentativo di attuare gli orientamenti conciliari inserendo una serie di elementi a partire dalla concretezza della loro esistenza sino alla pratica pastorale.
Abbiamo la fortuna di avere a disposizione, qui riportate, le riflessioni scritte di Renato che ci aiutano ad entrare con la mente e il cuore nella complessità di trasformazioni profonde, difficili da gestire, nel tentativo di dar forma a nuove coerenze evangeliche, dentro la realtà del mondo, in particolare quello operaio.
Ascoltiamo questo suo passaggio: “Ci è parso allora necessario, per fedeltà al vangelo e al ministero di preti, cambiare il contesto storico, sociale, culturale nel quale ci trovavamo, per cominciare a credere e sperare nelle condizioni normali della gente alla quale eravamo stati mandati. Non dovevamo inventare tutto noi: l’esperienza dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld e dei preti operai francesi, ma anche italiani (don Sirio Politi a Viareggio e don Borghi a Firenze) aveva già aperto e indicato la strada: il lavoro manuale e in fabbrica ci dava nello stesso tempo la possibilità di liberarci della cultura e mentalità clericale, di vivere del proprio lavoro separando il ministero dal denaro, inserendoci nella classe operaia, allora soggetto attivo della lotta per la riforma della società”.
Una comunità però non di soli preti, ma aperta a nuove figure, come testimoniano Alda e Giorgio: “Approfondendo il significato della vita comune e del coinvolgimento degli altri (non religiosi) entrano in comunità una famiglia e vengono accolti alcuni ragazzi con diversi problemi. L’impostazione iniziale della vita comune si accentua con la messa in comune degli stipendi e si cerca di rinnovare nel profondo la pastorale postconciliare”.
Quella ricerca comune dura sino al 1974 e Renato ne descrive la sua conclusione: “La nostra ingenuità era incredibile, ma ben presto ci siamo resi conto che la nostra Chiesa, neanche sotto il soffio più potente dello Spirito, era in grado di rinnovarsi in modo profondo. Ritorno alla Parola di Dio, la liturgia partecipata, la Chiesa come popolo di Dio, ritorno al vangelo, alle origini, spiritualità di Charles De Foucauld, revisione di vita, vita comunitaria, e mille altre cose tutte belle, sante e necessarie, non erano tuttavia sufficienti a farci superare l’abisso che ci separava dal “mondo” e dai “poveri”.
Soprattutto viene alla luce l’impossibilità a tenere insieme tutte le realtà nelle quali si è inseriti e le logiche che le sottendono, come ancora testimonia Renato: “ci accorgiamo dell’impossibilità di attuare il Concilio nelle sue intuizioni più importanti: questa pastorale non intacca la struttura ideologica, economica e di potere della Chiesa e del nostro inserimento in essa ed è in contraddizione con le nostre scelte operaie e politiche”.
E tuttavia in quello sperimentarsi è avvenuto qualcosa di grande e di duraturo che rimarrà impresso nell’esistenza che ciascuno porterà con sé: “Con alcuni amici abbiamo fatto un’esperienza che credo non esagerato dire eccezionale, di umanità, di fraternità, di fede laica e secolarizzata, che crediamo ci abbia portato a comprendere il Vangelo e a cercare di viverlo in un modo che può sembrare singolare, ma che credo ci accomuni a tante persone e a tanti gruppi sorti in questi anni in Italia e nel mondo”.
Dopo una ricerca sofferta, tra il 1974 e 1975, i tre preti si orientarono su strade diverse, sempre comunitarie: don Giovanni rimase a Banchette continuando il lavoro sulle linee del Vaticano II; don Nino diede vita alla comunità del Pozzo ad Ivrea assieme alla famiglia Nelli e ad alcuni giovani, seguendo l’intuizione e la pratica ispirate alla chiesa povera e dei poveri. Renato si unì alla fraternità di Lessolo, fondata da Carmelitani che dal monastero si erano trasferiti in cascine disabitate dove ospitavano emarginati e in particolare ex carcerati.
Renato ne parla così: “Abbiamo provato ad esercitare la fraternità tra noi. Poi è venuta su gente, giovani soprattutto per un po’ di preghiera, di consigli. Poi poveri, operai, emarginati, semplici, carcerati, perseguiti. Non più a chiedere preghiera e consigli ma pane, rifugio, un po’ di affetto e di amicizia. È con fatica che, vangelo alla mano, abbiamo accettato questo dono di fraternità, di condivisione, di ospitalità. Non abbiamo cercato né scelto. Alcuni si sono fermati tra noi e sono diventati a tempo pieno nostri fratelli. Volevano e vogliono fare la nostra vita”…È una comunità laica. In che senso? È fatta di credenti e di non credenti. Ci sono persone con diverse fedi. Il nostro stare insieme non è per tutti, non è “nel nome di Gesù” o “nel nome del vangelo”. E questa cosa, che può sembrare – e per certi versi certamente lo è – un ‘impoverimento’, paradossalmente credo ci renda più vicini al vangelo perché “Voi siete tutti fratelli”. E non “siete fratelli” perché cattolici, perché cristiani, perché impostate la vostra vita sul Vangelo, ma semplicemente perché siete fratelli. E ai fratelli non si chiede di avere le stesse idee, le stesse posizioni. Quello che ci tiene insieme, ormai da più di trent’anni, credo che sia davvero la passione per la vita che facciamo e per questa disponibilità ad accogliere chi viene e chi bussa”.
In questa fraternità di Lessolo Renato ha trascorso il resto della sua vita, sino al 21 dicembre del 2011, ucciso da un infarto nella sua cameretta. È morto dove desiderava morire: “tra i miei fratelli e le mie sorelle, quelli di casa, voi che siete qui e tutti quelli che quassù hanno speso e spenderanno poco o tanto della loro vita e quelli che quassù sono saliti o saliranno per un boccone di pane, di libertà, di futuro e di speranza”.
“A Lessolo ho dato tutto in questi 32 anni: la testa, il cuore, il corpo, prima forte e robusto ora un po’ malandato… Tutto per questo tentativo di fraternità universale (Charles de Faucauld)… Qui ho cercato di realizzare la mia vita di fede nel Vangelo di Gesù Cristo e la mia vita di prete. Il luogo dove la povertà ha voluto dire comunione e condivisione, la castità, un po’ più di capacità di voler bene a chi non è del proprio sangue, o della propria famiglia, l’obbedienza e la fedeltà a un progetto comune. Tutto questo con voi e con quelli che sono stati qui in questi anni. Per me «non è stata un’esperienza temporanea, ma condizione accolta e scelta come itinerario di tutta una vita» (come usavano dire di sé i pretioperai)… Vorrei morire a Lessolo vuol anche dire …che vorrei che Lessolo continuasse”.
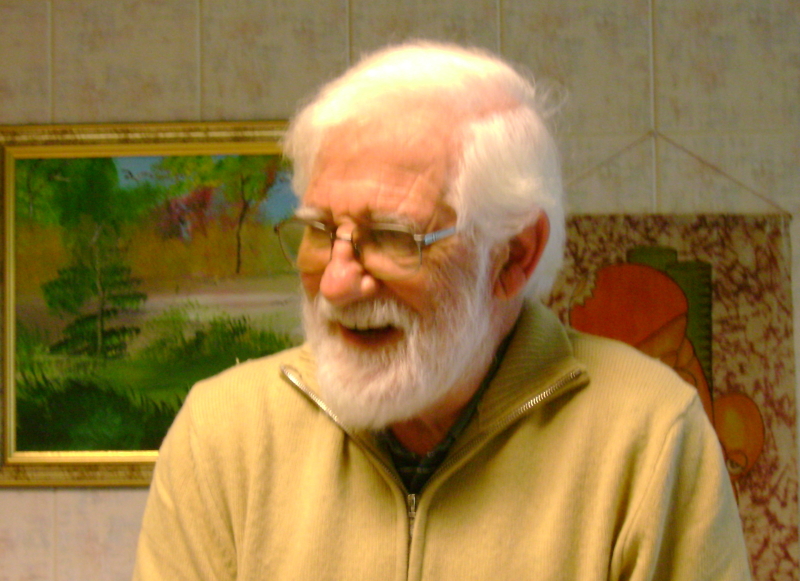
il sorriso di Renato
Nella breve scheda biografica che segue troverete i passaggi più salienti della vita di Renato, dall’immersione nella dinamica del Vaticano II negli anni della sua formazione teologica a Roma, con incontri diretti dei protagonisti, all’insegnamento della teologia morale nei seminari, all’ingresso nel lavoro di fabbrica, alla vita comune nella comunità di Banchette e nella fraternità di Lessolo…
È possibile trovare una chiave interpretativa attraverso la molteplicità o addirittura frammentarietà del percorso di Renato? Bonhoeffer ci dà un’indicazione: “Tutto dipende ormai dal fatto se sia possibile ancora scorgere, sulla base della frammentarietà della nostra vita, in che modo era progettato e pensato il tutto, e di quale materiale sia fatto”.
Forse la chiave giusta di comprensione, quello che Renato ha inseguito in tutti i passaggi è quella di dar forma, con tutte le sue forze, alla fraternità universale, quella di cui parla nel suo scritto ultimo. Una cosa del genere può avvenire solo nel frammento, cioè nella povertà e nei limiti della nostra condizione umana. Possiamo dire che la sua è stata una vita donata e spesa divenuta coscienza piena nel progetto di Lessolo, e “segno dei tempi” che manifesta l’unica via, anche per la chiesa, che possa aprire un futuro per l’umanità nell’era planetaria.
