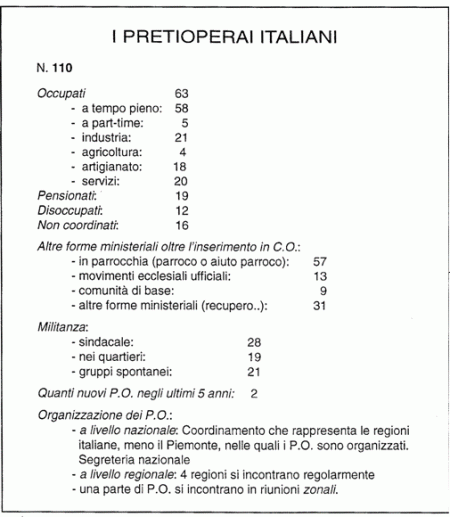
1. Provocazioni culturali, politiche, ecclesiali
che stanno alla base della scelta dei PO italiani
Per la quasi totalità dei PO Italiani il Concilio Vaticano II è stato il punto di partenza nel cammino che ci ha condotto a condividere la condizione operaia. Ci riconosciamo in una storia comune, in una comune ispirazione, ma non siamo un “movimento” od una organizzazione, almeno nel senso che si è soliti attribuire a questi termini.
Il pluralismo che ci caratterizza può essere giudicato debolezza, oppure ricchezza. Di fatto in Italia questo nostro modo di esistere rappresenta l’unica possibilità di presenza.
A. Il Vaticano II ha costituito un momento di rottura dal quale si dipartono alcune transizioni di importanza decisiva e che hanno influito alla scelta dei PO. I passaggi sono principalmente i seguenti:
• dalla Chiesa semplicemente identificata come società gerarchica al recupero della figura biblica e storica del Popolo di Dio;
• dal monolitismo teologico alla ricchezza pluralistica delle riflessioni critiche sul cristianesimo;
• dalla semplice dipendenza dei laici nei confronti del clero ad una loro presa di coscienza e responsabilità con processi di autonomia sul piano culturale, politico, teologico, etico…
• da una Chiesa di fronte al mondo e società perfetta, ad una Chiesa nel mondo, che deve stare con gli ultimi del mondo.
Quest’ultima transizione è quella che più direttamente ha coinvolto i PO. Infatti l’essere preti, anche nella funzione di cappellani del lavoro presenti nelle fabbriche, significa continuare ad essere organici alla struttura gerarchi ca della Chiesa; l’essere in condizione operaia vuol dire essere integrati in una situazione materiale e spirituale che possiamo definire mondana, caratterizzata da elevati livelli di conflittualità. Questa doppia appartenenza comporta in se stessa un’inevitabile e mai sopita tensione tra elementi fortemente disomogenei e storicamente in attrito. Ne derivano sintesi personali o progettuali tutt’altro che univoche.
B. Situazioni storiche in campo religioso e sociale che hanno rappresentato un impatto per le decisioni dei PO.
• Ci sono degli elementi che danno un volto particolare al cattolicesimo italiano. L’inevitabile associazione Chiesa – Vaticano, il potere spirituale che, nella tradizione italiana, diventa esercizio di potere temporale direttamente o indirettamente esercitato mediante il partito cattolico, la presenza capillare delle parrocchie a livello popolare, l’insegnamento della religione nelle scuole, il concordato, il mantenimento del clero con supporto dello stato italiano… accentuano la forma politica del cattolicesimo nazionale. Nel complesso la religione cattolica è diventata una “parte” politica interclassista, ma di fatto escludente coloro che non si trovano in queste dimensioni. Da questo emerge la contraddizione di una non libertà del Vangelo, di fatto legato ad una parte politica e strumentale al potere di turno.
• In Italia è presente una forte tradizione socialista con un partito Comunista (ora Partito Democratico della Sinistra) ed un Sindacato C.G.I.L. con iscritti comunisti, socialisti e nuove formazioni della sinistra. Queste componenti sociali hanno esercitato e tuttora esercitano un peso decisivo nella Classe Operaia e nel mondo del lavoro. Pur non essendo queste le uniche forze in campo nell’organizzazione dei lavoratori, è chiaro che per i PO hanno rappresentato quel mondo con il quale era ed è inevitabile entrare in rapporto con l’inserimento od il confronto.
La realtà sociopolitica italiana presenta una forte emarginazione di cittadini sia da parte del sistema capitalistico che del sistema religioso. Di fronte a questa frattura (riconosciuta anche dai vescovi e da Paolo VI a Taranto) la Chiesa Italiana non è stata capace di immaginare vie nuove di evangelizzazione che potessero mettere in discussione la propria posizione politica.
Due sono le anime principali del cattolicesimo italiano.
• La cultura presenzialista o intransigente (integrista?), la quale lamenta che la comunità cristiana ha introiettato in sé alcuni punti di vista della cultura laicista, in particolare la lettura della storia moderna proposta dalla cultura illuminista e marxista in termini di soggettivismo, storicismo ed ateismo. In conseguenza di ciò il cattolicesimo si è dicotomizzato, ponendo da una parte la vita religiosa e dall’altra la vita concreta. Quello che propone è una ricomposizione dell’identità cattolica in tutte le espressioni della vita soggettiva, culturale e pubblica usando anche dello strumento politico proposto a tutti i cattolici.
• La cultura della mediazione o dialogante che propone un taglio non integrista verso le realtà altre, non cristiane: “invece di perdersi in recriminazioni e condanne, la Chiesa italiana sente sempre più urgente il dovere di incarnare il dono divino della riconciliazione nelle molteplici condizioni umane nelle quali si trova a vivere” (Card. Ballestrero). È la continuazione della cultura della mediazione del cattolicesimo democratico.
• Ma vi è una terza posizione non espressa che è andata maturandosi tra i credenti militanti e si potrebbe definire del “paradosso”. Viene sottolineato il carattere paradossale del cristianesimo, non rappresentabile – nella situazione italiana – né in un sistema organico e integrale, né attraverso tentativi di mediazione.
2. Le motivazioni di fondo che stanno alla base della scelta dei PO
Bisogna innanzitutto osservare che ciascun PO è arrivato alla scelta operaia per tutta una serie di percorsi e motivazioni di carattere esistenziale, socio politico, spirituale, biblico, ecclesiale concatenate tra di loro, per cui non è facile distinguere e sezionare questi diversi filoni senza rischiare di perdere il significato di un’esperienza. Occorre anche tener presente che ciascuno di loro ha una storia personale legata all’ambiente dove ha vissuto, alle persone che ha frequentato, alle sensibilità che ha maturato, e quindi anche le motivazioni che hanno determinato una scelta che è comune presentano connotazioni, accentuazioni e sfumature specifiche, caratteristiche di ciascuno. Infine bisogna notare che non tutte le motivazioni erano chiare ed esplicite fin dall’inizio. Nel corso degli anni, stando in condizione operaia, molti PO hanno scoperto valori nuovi, hanno acquisito nuove sensibilità e nuove convinzioni.
• Identità
All’origine della scelta di condividere la condizione operaia per molti vi è la messa in discussione (interiore prima che esteriore) della formazione ricevuta, il rifiuto di vivere dipendente dalla struttura ecclesiastica, ed il rifiuto di un ruolo in gran parte ridotto a professione. Tutto ciò perché vissuto come alienanti e come protesi a garantire l’appartenenza ad un’organizzazione più che al formarsi dell’identità.
Per i PO la scelta di un lavoro dipendente, intesa come scelta definitiva e non solo come esperienza, è stata la via con cui porsi in una diversa situazione in maniera laica e storicamente data, dalla parte degli sfruttati, senza alcun ruolo e privilegio ricevuti da fuori, con i vincoli di spazio e tempo che questa condizione impone.
Per i PO quindi la condizione lavorativa rappresenta una condizione di partenza per la ristrutturazione della propria identità e del proprio equilibrio personale. Per questo le motivazioni esistenziali di partenza sono state per molti l’esigenza di uscire da una condizione di privilegio (quella del prete tradizionale) ed il bisogno di mantenersi con un lavoro “laico” come radice di libertà e di autonomia nei confronti dell’istituzione ecclesiastica.
• Condivisione
Naturalmente i PO hanno compiuto questo cammino anche in seguito a stimoli assorbiti all’esterno e diversamente rivissuti nella propria esperienza personale:
– una maggiore attenzione alle condizioni di vita della gente povera, operai, immigrati, tra i quali vivevano;
– il desiderio di uscire da una condizione di estraneità di fronte ai problemi e alle lotte della gente;
– la necessità di schierarsi concretamente per la giustizia e non solo a parole: stare cioè dalla parte dei trattati ingiustamente;
– l’esigenza di essere come loro, “dentro” la loro condizione, per condividere e giocare la propria vita come loro, senza privilegi e coperture.
• Lavoro manuale
Quasi tutti i PO hanno scelto la condizione operaia, cioè un lavoro manuale dipendente, e questo per delle ragioni ben precise. Anzitutto per denunciare una realtà di divisione sociale del lavoro per cui il lavoro intellettuale è privilegiato, ben remunerato, socialmente qualificato, mentre il lavoro manuale è un lavoro declassato in seconda serie, oltre che faticoso, nocivo e rischioso, meno riconosciuto socialmente e meno remunerato. Si voleva quindi affermare la dignità umana del lavoro della povera gente e denunciare l’ingiustizia di questa divisione sociale del lavoro.
• Accogliere ed annunciare un Vangelo vivo
In molti c’è stato anche il senso della “vanità” della pastorale tradizionale nei confronti dei poveri. Il Vangelo andava assunto dalla Chiesa a partire dalla condivisione con i poveri rappresentati dal ceto operaio e dalla sua ansia di giustizia a partire dalle condizioni di oppressione. La pastorale tradizionale della Chiesa cresceva buoni servitori dell’istituzione, ma non formava persone libere per l’impegno nel sindacato e nella politica, cioè per la doverosa lotta per la giustizia. Non dall’essere “per e con” loro ma dall’essere “come” loro poteva venire il punto di partenza per un Vangelo efficace.
• Dimensione politica della carità
C’è stato poi un fatto molto importante per tutti i PO: la scoperta della politica, il bisogno cioè di amare anche con la testa; la politica come dimensione della carità. La povertà che si andava a condividere nella fabbrica e nei quartieri non è un fatto casuale, piovuto dal cielo, ma ha delle cause ben precise che vanno analizzate per poterne progettare il superamento. Questo è avvenuto nel momento in cui i PO hanno cominciato a partecipare attivamente alle lotte degli operai e della gente dei quartieri.
È venuta quindi maturando in ciascuno una scelta politica di appartenenza alla classe operaia ed un’adesione ai suoi obiettivi, alle sue lotte ed alle sue organizzazioni.
“L’impatto con la realtà operaia scuote profondamente i PO che hanno deciso di farne esperienza non superficiale e non provvisoria. Nel lavoro quotidiano si fa una dura esperienza di sfruttamento, unita ad una scoperta talvolta esaltante. Si sperimenta sulla propria pelle lo sfruttamento (la catena di lavoro, l’operaio ridotto a numero, il lavoro considerato come merce) e l’alienazione (i lavoratori privati della loro dignità, attaccati al mito del benessere, della carriera, del consumo). Si percepisce personalmente il bisogno della rivolta e della lotta”. (Bollettino di Collegamento PO 4/82, pag.12).
Questa esperienza così forte e drammatica è stata vissuta da ciascun PO con la percezione (inizialmente vaga e confusa) del significato strutturale dell’essere in condizione operaia.
“Un’esigenza di moralità della nostra vita ci imponeva di cercare con tutte le nostre forze (e quindi anche con la ragione) quali fossero i bisogni di salvezza dell’uomo d’oggi e quali le possibilità storiche di rispondervi. Il giudizio di ragione che il capitalismo si oppone strutturalmente ai bisogni di salvezza dell’uomo d’oggi e che la classe operaia è oggettivamente nelle condizioni di operare dei cambiamenti strutturali è il fondamento di ragione su cui radichiamo oggi la moralità del compito storico che questa classe può svolgere.
”Per questo ogni passione per la salvezza dell’uomo che dimenticasse questo giudizio di ragione ci sembra ambigua e mistificante. Conseguentemente il prezzo che ci costa il rimanere in condizione operaia per noi può essere sostenuto soltanto dalla continua convinzione che il rimanerci dentro ci colloca in una condizione oggettivamente di classe e quindi è funzionale al permanere in noi di quel giudizio di ragione e delle scelte morali che ne conseguono”. (PO di Milano, 26 settembre ’80)
3. Percorso storico dei PO Italiani
Un accenno alla storia dei PO italiani permette di individuare i nodi, le problematiche, i contenuti positivi e le debolezze.
a. I primordi
Ancora prima dell’inizio dell’esperienza dei PO c’erano dei preti presenti in fabbrica come Cappellani del lavoro. Alcuni di loro sono stati particolarmente vicini agli operai durante la resistenza al nazifascismo e durante i primi momenti di repressione padronale. Nel 1950 Carlo Carlevaris entra anche lui come cappellano del lavoro alla FIAT di Torino; sarà poi cacciato con Toni Revelli dalla Direzione Aziendale nel 1962, perché non più omogenei alla politica padronale.
Dal 1950 Bruno Borghi a Firenze lavora prima come artigiano e poi alla Pignone, ponendo al centro della sua scelta la separazione del provento economico dal ministero. Sirio Politi dal 1956 al 1959 lavora nei Cantieri Navali di Viareggio; poi, per le resistenze della gerarchia ecclesiastica, deve ripiegare sull’artigianato.
Nel 1967 per interessamento del Card. Pellegrino arcivescovo di Torino Giovanni Carpené e Luisito Bianchi furono accolti come PO dal Vescovo di Alessandria; nel 1968 Carlo Carlevaris ottenne di andare al lavoro entrando in una azienda metalmeccanica. Proprio in Piemonte nasce il primo collettivo di PO.
L’esperienza ventennale dei Cappellani di fabbrica non è sfociata automaticamente nell’esperienza dei PO, ma ha reso alcuni di loro attenti ai vari nodi del distacco tra Chiesa e Classe operaia. Tra Cappellani e PO si verifica un salto di qualità sul piano della condivisione di un mondo e di una cultura e, soprattutto, di un modo di essere.
b. Inizio del collettivo
Nei primi anni del post-concilio partono, in modo isolato e senza alcun collegamento tra loro, i primi PO: una decina tra il ‘65 / ‘68, situati nel Centro – Nord d’Italia. Dopo il ‘68 le presenze cominciano ad aumentare. Collegata alla vicenda dei PO è anche l’esperienza dei Chierici al lavoro sorta nelle tre Regioni del Nord: la Parrocchia di Spinea nel Veneto, l’esperienza del “Paradiso” di Bergamo, ed il Seminario di Rivoli in Piemonte. Oltre a queste esperienze diocesane abbiamo parecchie iniziative dei religiosi. I chierici passano dalla conoscenza del mondo del lavoro alla condivisione. Ma non per tutti, poiché si manifestano le resistenze dell’autorità ecclesiastica: parecchi religiosi devono rientrare e l’esperienza di Spinea chiude nel ‘72 osteggiata dai Vescovi del Veneto; rimane solo il percorso di Torino sostenuto dal Card. Pellegrino. Nel ‘68 a Torino Sirio Politi, Carlevaris e Carpené danno vita ad un collegamento tra PO per confrontare le esperienze ed essere un punto di riferimento e sostegno per coloro che avessero compiuto questa scelta. Già in questi primi incontri emergono orientamenti diversi tra chi pensa ad un movimento strutturato e chi paventa una clericalizzazione dell’esperienza.
I PO Italiani iniziano i loro incontri nella forma di convegni o di seminari di studio su tematiche impellenti. Gli incontri di questo periodo risentono dello sconvolgimento che l’essere in Classe Operaia e nel mondo del Lavoro ha portato nel personale, nella spiritualità, nel ministero e nell’essere Chiesa.
Il primo convegno nazionale si tiene a Chiavari il 6/7 luglio ‘69 con il tema “Vivere il nostro sacerdozio nel lavoro”.
Nel ‘70 si tiene il secondo incontro a Bologna (25/26 aprile) portando il confronto sul senso della preghiera nel nuovo contesto di vita dove il tempo è fagocitato dal lavoro e dalla lotta di liberazione.
A Firenze (7/8 novembre ‘70 il terzo incontro che ha come tema “La nostra fede in Cristo vivente oggi”: l’incarnazione come dato definitivo diventa la categoria teologica assunta dai PO.
Nel novembre ‘73 a Reggio Emilia il quarto convegno su: “Fedeltà alla Classe Operaia a Cristo ed al Vangelo nella Comunità dei credenti”. Per la prima volta i PO italiani si presentano in pubblico affermando questa doppia fedeltà. È il momento di una forte contestazione al cristianesimo politico italiano e di una profezia che passa attraverso le scelte di vita delle persone. Con i nuovi ingressi in Classe Operaia (una media di 13 preti ogni anno fino al ‘73) si cominciano a strutturare i gruppi regionali confluenti in un coordinamento ed una segreteria.
Quinto convegno (gennaio ‘75) a Serramazzoni 1° “Rendiamo conto della nostra fede: quale fede?” Si comincia ormai a riflettere sulle conseguenze che l’impatto con la Classe Operaia porta non solo alle nostre persone ma alla Chiesa ed alla Società.
c. La Parabola dei PO
Negli anni successivi l’esperienza si radicalizza nel senso di mettere radici identificandosi con la C.O., assumendone le ragioni, il linguaggio, le problematiche e le speranze, mentre diventa critico il rapporto con la Chiesa italiana connivente con scelte politiche ed anche economiche della controparte; ne è conferma il sesto convegno dal titolo “Contro l’uso antioperaio della fede” (Serramazzoni, 3/6 gennaio’76).
Nel settimo convegno, tenuto a Salsomaggiore, i PO si presentano come “Gente di confine” non solo perché emarginati come i loro compagni, ma anche come possibile cerniera tra due mondi: la chiesa e la C.O.
Ma anche in questo ritrovarsi al confine i PO rimarcano due linee differenti: i Piemontesi sottolineano il valore ecclesiale di base nella direzione di un’esperienza di chiesa in C.O. mentre il Lombardo/Veneto in particolare pone l’accento sulla libertà di un’esperienza a fronte della durezza della Chiesa italiana con la C. O. e con i PO.
Si accentua, nella radicalità, la consapevolezza che lo Spirito ci precede sulle strade dell’evangelizzazione. La fede e l’impegno politico sono vissuti in profonda solidarietà con i compagni di lavoro nella loro condizione di dipendenza e subalternità sociale ed esclusione ecclesiale. Lo Spirito e la Parola ci spingono su strade di laicità a “Credere ed operare la giustizia” (ottavo convegno, 21/24 aprile ‘79 a Viareggio).
La società italiana è permeata da una profonda crisi economica, politica e sindacale; è crisi anche di valori di riferimento che hanno permesso il cammino democratico dopo la resistenza al fascismo; sono gli anni di piombo, del terrorismo politico. Il capitalismo ci fiacca e diventa duro resistere nel quotidiano. Occorre vivere “Tra disgregazione e speranza con la fede giocata nel quotidiano per non essere schiacciati né alienati”, tema del nono convegno di Frascati (5/8 marzo ‘81). I tempi sono così duri che, come collettivo, abbiamo dovuto difendere i PO Aldo D’Ottavio e Battistutta dall’accusa di far parte delle Brigate Rosse.
Anche il successivo convegno di Sassone (Roma) del 13/16 ottobre ‘83 ripercorre la crisi “Nella vita quotidiana e nel declino delle progettualità”, interrogandoci: “Come uscire diversi dalla crisi”; così pure a Firenze (1/4 maggio ‘86) “ Civiltà tecnologica, sfruttamento, emarginazione: la fede interroga i progetti”.
La crisi della C.O. si riversa anche sul collettivo dei PO italiani; si accentuano le linee di differenza sia nel campo della militanza sindacale / politica, sia nel concepire il ministero e l’essere Chiesa. Nella trasformazione capitalistica parecchi PO perdono il posto di lavoro; quelli del Friuli lo cedono volontariamente a chi ha carichi di famiglia. La società fa emergere nuove povertà ed emarginazioni. Alcuni PO entrano nel servizio del volontariato tra i tossicodipendenti, portatori di handicap, lavorano con gli immigrati o i barboni, sono presenti nei movimenti nonviolenti e della pace o si dislocano, per alcuni periodi, anche nel Sud del mondo.
Nell ‘87 il bollettino di collegamento dei PO diventa la rivista “Pretioperai”, un nodo pensante per un servizio di verità.
In questi dieci anni (‘77/’87) si possono stimare i PO italiani a più di trecento; presenti in tutte le regioni italiane con una maggiore presenza al Nord. Agli incontri e convegni si è andati da un massimo di 160 ad una media di 80 presenze.
d. L’ultimo periodo
Lo sforzo di questo periodo è diretto al tentativo di ascoltare le nostre storie per riuscire a trovare nel rispetto reciproco, la fedeltà alla profezia nella società e nella Chiesa…
Nel dodicesimo convegno (Salsomaggiore, 22/25 aprile ‘89) il tema è “PO qualche anno dopo” e si ha la sensazione di dover marcire in una situazione di oppressione, dovendoci assumere il male della storia, ma affermando una speranza che va oltre il nostro controllo ed il nostro futuro. Si esaurisce la spinta propulsiva del movimento, si risente della pesantezza ed anche dell’invecchiamento, ma le motivazioni si fanno più lucide.
Nel tredicesimo convegno (Salsomaggiore, 1/3 maggio ‘92) “Dai diamanti non nasce niente… nella condizione operaia: Vangelo od evangelizzazione?” ci si interroga sul proclama della Chiesa italiana sull’evangelizzazione potente, riscoprendo il paradosso della Croce. In questo convegno si verifica il defilarsi di fatto del gruppo del Piemonte in totale disaccordo sulle linee dei PO giudicate perdenti.
Arriviamo così al Seminario di studio organizzato con altre riviste italiane (Salsomaggiore, 23/25 aprile ‘94) “Paradosso cristiano nel crepuscolo del ventesimo secolo” sulle figure storiche del cristianesimo italiano e le provocazioni della Parola sulla libertà di Dio e sul libero incontro con l’uomo.
4. Cenni di esperienze significative
a) In Piemonte alla fine degli anni ‘60 per osmosi dell’esperienza francese dei PO, per la presenza del Card. Pellegrino arcivescovo di Torino e l’orientamento dei primi PO con alla testa Carlo Carlevaris, si è costituita la “Missione Operaia”.
In un “progetto comune” confluivano i PO già al lavoro, i chierici e seminaristi che avevano accettato di vivere e lavorare nei quartieri gestendo la propria vita in piccole comunità (una diecina), alcune suore diventate pure loro operaie, un gruppo di giovani operai che tentavano di diventare preti restando in condizione operaia ed, infine, anche la JOC, nata da questo movimento supportato dalla rivista “Itinerari” .
Il sogno è quello di far nascere la Chiesa in classe operaia, visto il grande distacco con le masse operaie che provenivano dal Sud, accogliendo la condizione di dipendenza, il loro linguaggio e la lotta di liberazione per i diritti civili, sociali ed economici, eliminando anche l’emarginazione ecclesiale.
L’esperienza è stata guardata con sospetto dai cristiani benpensanti, e talvolta ha creato conflittualità ecclesiale. Dopo il coraggioso Pellegrino, con Ballestrero e con Saldarini si ha un progressivo affievolimento di questa presenza ecclesiale.
b) Il Vescovo Ancel (ausiliare di Lione) è in Italia negli anni del dopo Concilio e tiene alcuni corsi di esercizi spirituali ai preti e seminaristi di varie diocesi. Nasce il movimento non strutturato del Prado italiano con referente Olivo Bolzon, rettore del Seminario per l’invio di preti diocesani in America Latina.
Nascono le prime comunità di vita ispirate al Prado (Spinea, Vicenza, Verona, Trento, Bergamo) e parecchi preti entrano in condizione operaia. Le comunità resistono per una quindicina di anni (‘72/’87) e poi si sciolgono, ma resta la presenza tra i PO.
c) A Porto Marghera vicino a Venezia era nato nel dopoguerra l’unico significativo polo industriale del Veneto con parecchie industrie parastatali. In questo ambiente si inseriscono i PO della zona sia della comunità di Spinea, sia PO isolati. Intorno a loro si coagula un gruppo di laici militanti per un cammino di ricerca che continua ancora intorno alla rivista “Esodo” .
d) Agli inizi degli anni settanta si hanno casi di chierici religiosi che fanno un’esperienza fuori dagli istituti di formazione e vivono con un formatore nei quartieri in piccole comunità entrando nel mondo del lavoro. Sono di solito religiosi maschi, e questo fenomeno è limitato nel tempo; all’ordinazione presbiterale tutti rientrano negli istituti. Uno di loro è attuale vescovo di Locri nel Sud.
Particolare risulta l’esperienza dei Gesuiti a Parma e a Napoli che hanno mantenuto una loro qualificante presenza tra i PO anche come équipe. Così pure i Francescani di Mestre, presenti nella zona industriale.
e) I pochi PO del Sud in genere non hanno spazi per entrare in fabbrica, data la poca industrializzazione delle regioni, ma sono impegnati nelle periferie degradate delle città a contatto con l’emarginazione e contro i poteri mafiosi, a rischio anche della loro incolumità.
f) Una équipe particolare, durata una decina di anni, è stata quella “contadina” composta da tre PO dislocati in tre realtà differenti: a Verona, Roma, Messina. Anche questa è andata ad esaurimento per scelte diverse dei soggetti. Uno di loro ha continuato il lavoro con i contadini del Nicaragua creando collegamenti con le cooperative autogestite di contadini italiani.
g) Particolare menzione è da rivolgere all’équipe di Viareggio sorta intorno a Sirio Politi e che sopravvive alla sua dipartita. Incentrata sul lavoro artigianale come recupero di mestieri con inserimento di ragazzi in difficoltà, è diventata un centro di incontro per la zona del porto ed un luogo di diffusione di idee ed iniziative culturali sulla pace, l’obiezione di coscienza e la nonviolenza servendosi della rivista “Lotta come Amore”.
5. Il nodo della militanza sindacale e partitica
I PO italiani militano nei vari sindacati. Parte nella CISL, la cui base per una buona percentuale proviene dal mondo cattolico. L’orientamento di questo sindacato è al moderatismo incentrato sulla promozione e difesa dei diritti dei lavoratori privilegiando il contrattualismo ed il solidarismo senza però porre pregiudiziali al sistema, ma cercando le compatibilità.
Un’altra parte di PO milita nella CGIL con una base proveniente dalle varie espressioni della sinistra privilegiando il discorso non della alternanza, quanto dell’alternativa al sistema politico ed economico a partire dalla solidarietà di classe.
Esiste poi un sindacato di estrazione socialista e repubblicana: la UIL.
Tra i vari sindacati ci sono state notevoli fratture dovute agli orientamenti di fondo, ma anche, a volte, unità di obiettivi e di azione. Ora i tre sindacati confederali non sembrano avere grandi differenze essendo diventati parte integrante delle istituzioni politiche del Paese. Ma la cosa non è pacifica e sono sorti sindacati di base ed autonomi in cui militano anche dei PO.
La tendenza generale dei PO nella militanza sindacale è stata quella di privilegiare gli incarichi che consentano un diretto e paritario rapporto con la base più che incarichi a tempo pieno nelle organizzazioni; però ci sono state alcune significative eccezioni.
Ora, a causa dei cambiamenti avvenuti (cambio di lavoro, licenziamenti, lavoro nell’artigianato…), il rapporto con il sindacato risulta allentato.
La militanza partitica praticamente non si è mai espressa nel collettivo dei PO italiani ed è rimasta a livello personale.
Ci fu un momento di grande tensione a livello di militanza sindacale quando furono aboliti da parte del governo alcuni punti di contingenza che garantivano l’adeguamento del salario all’inflazione. La CISL si mostrò filogovernativa mentre la CGIL si pose all’opposizione. Si andò al referendum popolare promosso dal PCI e la spaccatura del movimento operaio si riflesse anche tra i PO. In quel periodo (22/23 maggio’82) a Castiglione dei Pepoli (Bologna) i PO si ritrovarono in un seminario di studio dal titolo “Quale militanza?”.
6. PO: ministero e Chiesa
I PO italiani hanno iniziato la loro esperienza partendo da motivazioni e storie personali; gli humus e i contesti risultano diversissimi. È difficile collocarli con chiarezza ed univocità di fronte al ministero e ad un rapporto con la Chiesa, visto che anche la Chiesa italiana presenta situazioni differenti. Durante il nostro percorso non siamo mai arrivati ad una visione unica e condivisa. Il pluralismo di presenza e di significati è la nostra ricchezza ed il nostro limite: o accettarci o separarci.
Indichiamo alcune tipologie o profili di PO da intendersi non come schemi fissi, quasi fossero realtà meccaniche, ma come descrizione di caratteri prevalenti, talvolta in vitale combinazione tra loro:
a) PO come ministro in condizione operaia per far nascere la Chiesa in classe operaia. È forte l’attesa del riconoscimento da parte dell’autorità della Chiesa della specificità e legittimità di questo particolare esercizio del ministero sacerdotale.
b) PO nel ministero pastorale ordinario (parrocchia). Guadagnarsi da vivere con le proprie mani per rendere libero, povero e gratuito il ministero che è inserito nel quadro normale della pastorale. Una variante di questa impostazione ci pare di riscontrarla nel rapporto particolare tra PO e comunità di base.
c) PO che vive la condizione di lavoro e di militanza senza aver particolari gruppi cristiani operai a cui riferirsi, senza alcun inserimento nella pastorale normale, avendo quale punto di convergenza ecclesiale il momento misterico dell’Eucarestia e della Parola.
d) PO totalmente assorbito nella condizione e militanza operaia, testimone dell’estrema scissione esistente tra prete ed operaio e del paradosso del loro accostamento.
La posizione in cui prevalentemente i singoli PO si collocano influisce sulla lettura della realtà ecclesiale ed anche sul progetto di vita e di ministero.
7. PO e Vescovi italiani
La storia dei PO italiani è segnata da una profonda conflittualità con l’episcopato. I PO sono entrati nella classe operaia per scelta personale. Solo il gruppo del Piemonte è stato promosso e sostenuto dal Card. Pellegrino.
Da parte dei Vescovi prevalsero le preoccupazioni sulla militanza sindacale, sul dialogo non controllabile con il mondo marxista, sul cambiamento della vita e del ruolo del prete, sulla non utilità politica di questa esperienza che diventava una spaccatura dell’unità politica dei cattolici italiani. Il solco andò accentuandosi anche se alcuni hanno tentato delle mediazioni.
Nel ‘76 a Serramazzoni il Vescovo Cesare Pagani propose un “rapporto organico” con la Conferenza Episcopale, ma i PO in maggioranza (51 contrari e 31 favorevoli) opposero un rifiuto motivato dal pluralismo delle tendenze all’interno del movimento e dal timore di un’omologazione ed appiattimento alla linea della Chiesa italiana. Non si è rifiutato il dialogo, ma si è preferito richiamare ad un rapporto corretto le singole Chiese locali con i PO presenti nel loro territorio.
Il dialogo riprese nel 1981 con il Vescovo Alfredo Battisti della commissione del mondo del lavoro e problemi sociali. I quattro incontri non approdarono a nulla per mancanza di proposte unitarie sia da parte dei vescovi che si mostrarono latitanti e sia da parte dei PO. Con il Vescovo Santo Quadri, successore di Battisti, non se ne fece nulla e con Charrier si ebbe l’affossamento, anche perché era cambiata la linea della segreteria della CEI.
Gli anni ‘70 sono stati tempi di conflitto e di frattura per tutto il mondo cattolico italiano in occasione dei vari referendum sul divorzio, sull’aborto, e poi i temi del concordato rinnovato dai socialisti al governo, la religione cattolica nelle scuole, la forma del mantenimento del clero e le pressioni continue per l’unità politica dei cattolici… Alcuni PO furono sospesi a divinis per le loro scelte, altri lasciarono il ministero; furono tempi di grande sofferenza di fronte ad una Chiesa schierata politicamente e forte.
Negli anni ‘80 si ha un alleggerimento della pressione; si arriva anche all’ordinazione di due chierici per restare in condizione operaia, a Torino e a Vittorio Veneto. Il Card. Martini di Milano comincia ad incontrare i suoi PO periodicamente. La segreteria della CEI è retta dal Card. Ballestrero e prevale la linea del dialogo e della mediazione.
Ultimamente si assiste ad una pressione su alcuni PO perché rientrino in parrocchia pur conservando il lavoro: forse c’è bisogno di raschiare il barile?
La posizione dell’episcopato di questi ultimi tempi non ha avuto nei confronti dei PO prese di posizioni ostili, ma si è dimostrata spesso indifferente e silenziosa. Questo silenzio indica che la parabola dei PO per i Vescovi non è più interessante? Sono passati ad altre “cose” senza cogliere gli interrogativi posti da questa esperienza? Eppure, nonostante la fine delle ideologie appare sempre più evidente il persistere del fossato fra Chiesa e mondo operaio. Nonostante il pluralismo di questa profezia, l’invecchiamento dei PO, la mancanza di “figli” … resta la provocazione dell’incarnazione, della laicità come sfida per i credenti, della desacralizzazione, della testimonianza attenta e silenziosa nella doppia fedeltà a Cristo e all’uomo nella sua storia concreta.
RICORDI DI DON BRUNO BORGHI
IL CARDINALE E I PROBLEMI DEL LAVORO
A.
Una sera andai a chiedere al Cardinale di ricevere un gruppo di contadini, a conclusione di un convegno.
«Volentieri ma un quarto alle sei devo uscire per un altro impegno».
Si fissò che si sarebbe stati lì alle 5,30 precise, tanto per permettere a quella rappresentanza di contadini di esporre brevemente al Cardinale le conclusioni a cui erano giunti e le richieste che avrebbero fatte alle autorità competenti.
Si fu puntuali e il Cardinale ci fece accomodare vicinissimi a lui, intorno ad una tavola, come se si fosse in famiglia, e invece di ascoltare cominciò Lui a parlare e mi ricordo che disse queste precise parole:
«Quando venni a Firenze, da Padova, credevo che la mezzadria fosse il contratto di lavoro ideale. In questi anni mi sono convinto che la mezzadria è un contratto “ingiusto” e che deve essere abolito».
Rivedo ancora un contadino di Luco di Mugello esplodere a queste parole per lui inaspettate e che forse avrebbe voluto dire lui al Cardinale, e battere la mano sul marmo della tavola e ripetere parole di meraviglia e di entusiasmo; e il Cardinale ascoltare mentre sorrideva con la bocca e con gli occhi e fare cenni di approvazione con le mani.
Mi ricordo che quando il Cardinale si alzò per rientrare nel suo studio erano le 6,45. Fu un incontro bellissimo. Non ho mai saputo però come abbia fatto con l’impegno che aveva in precedenza.
B.
Ultima occupazione del Pignone. Durante tutta la vertenza cercavo di informare il Cardinale circa le posizioni dei lavoratori e l’andamento della vertenza. Quando fu decisa l’occupazione della fabbrica andai a chiedergli il permesso di celebrare la Messa dentro l’officina per gli occupanti.
Era un sabato sera. «Tu pensi che sia bene?». Quasi sempre da chi gli domandava qualcosa, voleva sapere il parere su quella stessa cosa.
«Io sì, Eminenza!».
«Vai pure».
Così potei celebrare la Messa nel piazzale del Pignone.
Sono grato al Cardinale di avermi ordinato, ma anche di avermi dato la possibilità di celebrare la più bella Messa.
Ma gli sono infinitamente più grato di aver Lui, per mezzo di un suo prete, aver reso presente alla classe operaia, in un momento così decisivo, e così carico, Cristo e la Chiesa.
C.
Nel 1951 il Cardinale non mi aveva più permesso di andare a lavorare in fonderia al Pignone. Però dopo diversi anni, cioè dopo la vertenza del Pignone che culminò con l’occupazione di fabbrica e la nuova gestione da parte dell’ENI, accennai al Cardinale alla possibilità di ritornare a lavorare in fonderia. Tutte le volte infatti in cui si era parlato di questo problema e perfino al momento in cui mi proibì di andare in fonderia non solo non l’avevo trovato contrario a questa esperienza ma avevo la netta impressione che fosse favorevole. Posso anche sbagliarmi su questo.
Quando gli proposi un piano preciso che prevedeva un ritorno in officina restando agganciato ad una comunità parrocchiale dove c’erano altri sacerdoti lo trovai ben disposto. E una sera nel suo studio mi disse queste parole: «Senz’altro bisogna tentare. È l’unica esperienza valida».
Conservo il libretto di lavoro che andai a fare il giorno dopo in piazza Beccaria, come una prova della grande apertura e del grande coraggio di questo mio Vescovo.
Bruno Borghi
8. Quale futuro per i PO italiani?
Come ogni parabola, anche quella dei PO italiani è carica di ambiguità; occorre scavare nel campo e cercare la perla per riconoscere il tesoro nascosto. Il pluralismo di esperienze non aiuta certamente a porci con forza propositiva davanti alla nostra Chiesa anche se comuni sono le provocazioni dell’incarnazione, della laicità, della fedeltà al Vangelo e alla C.O.
Ma la stessa Chiesa italiana si presenta in un pluralismo di esperienze religiose: il cristianesimo popolare del Nord è diversissimo da quello del Sud; i vari movimenti ecclesiali hanno direzioni differenti nella teologia, nella spiritualità e nella presenza politica; le stesse espressioni strutturali centralizzate (es. Charitas, Pax Christi…) esprimono originalità e differenze notevoli. Sul tutto, però, sembra gravare il conformismo gerarchico, vischioso come un’area di palude.
La profezia del collettivo PO potrebbe allora esprimersi come spazio dove le varie anime vengono a confronto senza l’egemonia politica di nessuno. Ognuno ha il compito di conservare la propria legittimità e dignità di ricerca ponendo interrogativi veri alle altre esperienze e nello stesso tempo cogliendo le provocazioni altrui. È un esercizio di ascolto attento e vero, di capacità di interrogarsi ed interrogare abbandonando ogni logica di supremazia e di potere. Attraverso l’esercizio della nonviolenza e della stima dovremo lasciar spazio alla Grazia, credendo che solo lo Spirito di Cristo costruisce relazioni nuove e convergenze profetiche.
L’esperienza piemontese incentrata sulla Missione Operaia nel “progetto comune” pone la questione di una Chiesa radicata in una storia ed in una cultura e la questione del suo servizio attraverso i ministeri.
La tradizione lombarda coglie il centro della dislocazione e della militanza e pone il problema di come ridefinire le categorie della fede ed il rapporto con la C.O.
Il cammino veneto, che si situa in una chiesa molto presente nella società, tanto da diventare onnicomprensiva (la parrocchia diventa il mondo), pone il problema dello svuotamento dal potere riaffermando la trascendenza, la libertà di Dio e del credente sulla linea del paradosso cristiano.
Ogni posizione è parziale, ma dialogante, quindi aperta alla novità. Il collettivo è lo “spazio” in cui si riconosce che l’unico signore non è il peso politico, ma il Cristo e la Grazia che ci è stata donata con il suo strano dinamismo.
Questo costituisce una provocazione per la nostra storia, ma è anche un sogno di una Chiesa che si configuri come “spazio” dialogante tra le varie esperienze, senza il verme dell’autoritarismo e della violenza, per un’evangelizzazione dolce, un accompagnamento degli uomini e donne del nostro tempo, ponendo di continuo al centro la scelta evangelica degli ultimi.
Il paradosso non è legato solo al cristianesimo a fronte delle realtà terrene, ma è assunto anche nelle nostre storie dal fatto di voler vivere le due dimensioni di prete e di operaio che la Chiesa nel ‘59 ha dichiarato incompatibili. Esprimono, invece, la tensione a non nominare il nome di Dio invano da parte della Chiesa e a non costruirsi idoli nello spazio della realtà secolare.
