— ricordiamo
Martino Morganti
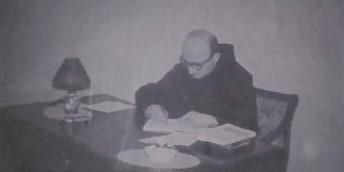
Nel luglio dell’anno scorso a Martino è stato diagnosticato un tumore al polmone sinistro. Ha accettato subito e senza apparenti eccessivi tremori l’idea che il suo cammino era terminato. L’unico suo cruccio era di essere di peso agli amici. È stato lucido fino agli ultimi 6/7 giorni ed è morto all’alba dell’undici di settembre.
Scrivo, avendo terminato di adempiere le ultime “pratiche” per Martino. Sono a casa mia e non ho a disposizione la documentazione necessaria per fare un profilo completo e corretto. Devo fidarmi della memoria e del risvolto di copertina di un libro. Continuiamo a riunirci a casa di Martino, ma ci vorrà un po’ di tempo prima di trovare la forza per raccogliere la storia viva che abbiamo vissuto con lui.
Martino è nato a Pistoia il 20 settembre 1927. È entrato nel seminario minore dei Francescani a Giaccherino (Pistoia) nel 1938. Nel 1951 e stato ordinato sacerdote. Si è laureato in diritto canonico presso il Pontificio Ateneo Antoniano (voleva fare una tesi sulla pena di morte che non è stata accettata – era contro – da nessuno dei professori della materia, perché – parole di uno dei professori che Martino amava ripetere quando parlava di quel tema – “vuole fare una tesi o un suicidio?”).
Parecchi anni dopo si è diplomato in liturgia presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma.
Ha insegnato diritto canonico e liturgia per circa quindici anni nello Studio Teologico Francescano di Fiesole e nel Seminario Maggiore di Firenze. Ha tenuto lezioni e corsi di liturgia in molti istituti e diocesi. Ha partecipato attivamente a molte “settimane liturgiche” nazionali, collaborato a molte riviste (Rivista liturgica, Rivista di pastorale liturgica, Rivista del Clero, Settimana del Clero, ecc.). Ha diretto per circa dieci anni (dal 1969 al 1977/78) l’antica rivista francescana “Studi Francescani”, trasformandola completamente, al punto che la direzione gli fu tolta perché non in linea con la “proprietà” (la Provincia Toscana dell’Ordine).
Fu nell’ottobre del 1969 che dette vita, insieme ad altri confratelli, al primo caso di “piccola fraternità” di frati operai, lavorando prima come addetto alle pompe di benzina, poi in una fabbrica di tonno in scatola e infine in una delle poche grandi industrie di Livorno (la SPICA), ricoprendo, a volte, anche incarichi sindacali.
È andato in pensione di vecchiaia nel settembre del 1987.
Dal 1972/73 è stato tra i promotori della comunità di base detta prima “di via Mentana” e poi di “piazza del luogo Pio” (chiaramente dal nome dei luoghi dei nostri incontri) e ne è stato di fatto l’animatore fino alla fine (l’ultimo anno della sua vita le riunioni settimanali della comunità si sono sempre svolte nel luogo in cui Martino risiedeva, o a casa sua o a casa di amici). Ha partecipato attivamente ai diversi incontri delle Comunità di Base: ha raccolto nel volume “Eucarestia raccontata” (ed. Borla, 1988) una “summa” ragionata di quasi tutto quello che era stato prodotto sul tema dalle CdB fino a quell’anno. Ci ha lasciato un ultimo volumetto, “L’erba e le pietre” (ed. Università Popolare 1997).
Uno o due anni fa (non riesco a ricordare esattamente) è stato espulso dall’ordine francescano con la motivazione che rifiutava di rientrare in convento. Non siamo mai riusciti a capire le motivazioni vere.
Nel ricordo che abbiamo fatto di lui il giorno del funerale, è stato chiesto al provinciale toscano dei francescani che era presente se ora poteva svelarci il motivo di quella espulsione: ci ha risposto che gli dispiaceva molto, ma ci ha chiesto di non chiedergli di dire di più.
Abbiamo creduto di interpretare un suo desiderio facendo un funerale laico. Saremo stati almeno duecento nella sala della Circoscrizione 4, provenienti da molte parti d’Italia, in una atmosfera calda e partecipata.
Leo Piacentini
FUNERALANDO
L’ultimo scritto di Martino, ancora non pubblicato
Carissimi, tranquilli: niente di direttamente personale. Due lettere (le ultime due) esplicitamente (e sfacciatamente!) autobiografiche, bastano ed avanzano! Sono disposto a dar credito a chi riconosce all’autobiografia valori terapeutici (Duccio Demetrio – Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Ed., Milano 1996). Credo però che l’autobiografia faccia anche male. Alla salute altrui, asfissiata dalle invadenze e prepotenze di chi impone solo ascolto. Insomma: autobiografici sì ma con moderazione.
Del resto vorrei parlare proprio di qualcosa che è assolutamente negato all’autobiografia; che è per sua stessa natura sottratto alla gestione, al racconto e alla registrazione del protagonista: il funerale. Il mio funerale è quanto di meno possa appartenermi; è ciò che è totalmente oltre, dopo di me. Il funerale è l’espressione pubblica della nostra passività massima: funerale, almeno in Toscana, ha un suo sinonimo in trasporto (domani alle 17 si fa il trasporto di… Carlo) nel quale il cadavere è chiaramente identificato nel trasportato, in colui/colei che è totalmente rimesso ad altri, consegnato alle mani altrui. Inerte come cadavere! Sul mio funerale potrei, al massimo, influire con previe volontà e disposizioni e contare, per la loro esecuzione, su regole e buon cuore dei sopravvissuti. Ma nel mio caso sono ben contento che tutto resti rimesso alla responsabilità e ai… disagi altrui. Rimango fermo — e mi piace ribadirlo — a due soli dettati attinenti soltanto al come trattare il mio cadavere. Primo: renderlo disponibile alla donazione di ogni suo brandello donabile e ad ogni sperimentazione con esso sperimentabile. Secondo: consegnarlo alla cremazione.
Vorrei semplicemente parlare a voi e con voi del funerale. Un argomento come un altro e, come altri, bisognoso di attenzione, ripensamenti e sperimentazioni. Mi si è riproposto su sollecitazione di non lontani ritagli di giornali (aprile 1999): raccoglievano indiscrezioni secondo le quali il funerale costituirebbe un problema anche per la chiesa cattolica italiana, che sarebbe già al lavoro per riscriverne i riti, le formule e l’intero complesso liturgico. Problema di contenuti e di forme. Nessun problema — ed ecco il punto — riguardante il dove, il luogo della celebrazione. Intendo per la chiesa cattolica (ma nemmeno per altre chiese o religioni!) ben fornita di luoghi. E non è poca cosa. È quasi tutto: disponibilità di luogo è presupposto e garanzia di libera espressione di ciò che i soggetti dell’azione (il funerale) intendono fare. Le mura stesse sono già adattate e rese docili all’azione (il tempio: pietre teologizzate o teologia pietrificata) e, comunque, già riservate al proprio specifico ed esclusivo.
Un privilegio riservato a chi possiede il tempio? E per i senza tempio? Confidare in qualche soluzione pubblica o ritornare al tempio pagando il dovuto pedaggio di adeguarsi alle regole del tempio? Magari anche confidando in un qualche molto problematico vantaggio a proprio conto: gli amici di P. Balducci che ottengono di fare le sue esequie nel tempio (duomo di Firenze) corrodono la centralità del cristianesimo traendolo verso il post-cristianesimo a cui si dichiara approdato il frate, o ri-ingrassano il prestigio e l’egemonia del tempio?
Comunque: scarsità o assenza di luoghi liberi per liberi funerali. Questo è il problema. Da non sottovalutare. Da preoccuparsene e occuparsene.
Lo avvertono i… non religiosi. Clara Sereni (Il Manifesto, 2 sett. 1998) esprime la rabbia di constatare, ancora una volta, l’incapacità che abbiamo da laici ad “inventare cerimonie degli addii” che aiutino ad elaborare un lutto rispetto al quale i credenti sono tanto più attrezzati di noi… “Per i signori X (le persone qualsiasi) e per chi vuole salutarli non c’è un cerimoniale, non ci sono riti, e soprattutto non c’è un luogo: c’è solo il deposito delle bare al cimitero, con il rumore di fondo delle ruspe a enfatizzare ogni sconforto”. “Basterebbe poco” — aggiunge la Sereni —: “una sala adatta, esattamente come quella per i matrimoni civili. Basterebbe poco, se le amministrazioni comunali lo decidessero; e forse ci riuscirebbe finalmente di essere laici fino in fondo, ma meno isolati, disperati, soli”.
Con i non religiosi (ma credo occorra rivedere anche sbrigative identificazioni tra religiosità — ogni tipo di religiosità — e laicità) hanno diritto al luogo libero per funerali liberi anche chiese e religioni non schedate ed allineate: è credibile una chiesa altra senza un funerale altro?
Un gruppo di cittadini (in realtà con il volto di gente della comunità dell’Isolotto) si è rivolto all’inizio del 1998, al presidente della circoscrizione 4 di Firenze proprio per richiedere uno spazio per il commiato dei defunti. Constatano: sul territorio esistono soltanto due Cappelle di commiato. in tutti e due i casi si tratta di “luogo terribilmente desolante, destinato solo alle celebrazioni funebri dove il tempo della morte rimane diviso dal tempo della vita”. Auspicano sia reso disponibile un locale “presso la sede del Quartiere, casa comune di tutti, non separato dalla realtà quotidiana” senza attivare “quasi automaticamente il legame con l’istituzione religiosa”. Ciò “costituirebbe un significativo passo avanti per quel processo di laicità che sembra più difficile quando tocca gli aspetti profondi della nostra esistenza”.
È questo l’essenziale della mia lettera; impegnarvi, secondo competenze personali o d’insieme, nella riappropriazione, che è giusta riappropriazione, del libero funerale che esige libero luogo per il funerale. Vedo alcuni indispensabili o utili passaggi.
• Intanto un’accurata ricognizione delle disponibilità pubbliche: templi, incluse le cappelle mortuarie; sale cimiteriali; sedi di partito ed associazioni; cos’altro ancora?
• Valutazione del recensito: è propizio a coerenti incontri tra la vita e la morte del defunto/a oppure a staccare e modificare quanto il defunto/a ha scelto e vissuto con concezioni teologiche e comportamenti imposti da rituali precostituiti? È piuttosto frequente registrare amici di altre chiese/religioni, o non religiosi, restare sul piazzale del tempio (a fumare?) in attesa che il defunto/a finisca la sua sosta nel luogo separato ed esclusivo appunto il tempio.
• Richiesta a chi di competenza di dotazioni adeguate alla sana pluralità dei cittadini religiosi o non religiosi, di qualsiasi religiosità e non religiosità e tutti nel contemporaneo rispetto.
• Quali criteri e sperimentazioni privilegiare? Preferibili strutture a destinazione unica ed esclusiva (stanze mortuarie o opportunità varie tratte magari da collegamenti tra quella morte con quella vita (la scuola, la fabbrica, un istituto culturale, la palestra, un teatro, il parco, la piazza…)?
• Tenendo presente che attraversiamo un tempo di adattamento sarà bene addolcire rigidità e inflessibilità puriste. Lo stesso rifiuto del tempio sarà pagato a troppo caro prezzo se costringerà a separare il defunto/a dagli amici ancora vincolati al tempio? Sarà comunque indispensabile mantenere alta la riflessione sul funerale per non mollare sulla ricerca e richiesta del libero spazio per il funerale. E soltanto sperimentando funerale a misura propria in un luogo proprio, si potrà approdare ad un funerale diverso e non soltanto per diversa etichettatura.
Personalmente riterrei utile tener presenti soprattutto due cose. La prima: al funerale immediato alla morte non si potrà chiedere molto. Perché dominerà un gran bisogno di stare insieme, in silenzio e senza vergognarsi dell’emozionale anche se diventasse addirittura dominante. Per cui il luogo funziona meglio se meglio accoglie i presenti e se meglio mette gli uni accanto agli altri. La seconda: il vero funerale (o i veri funerali?) rimandarlo a tempi meno affrettati e più disposti anche al ragionamento e alla memoria più tranquilla e serena. Funerale come un “fare memoria di lui/lei”; e un “fare memoria di lui/lei” che, umilmente imitativo di un altro memoriale sommo ed unico, quello di Gesù di Nazareth, tenti di tenere con noi colui/colei che ci lascia: chieda efficacemente che la vita di lui/lei rimanga vita nel nostro vivere (cosa avrebbe fatto o non fatto, detto o non detto qui ed ora e in me?).
Carissimi nipoti, occupiamoci, occupatevi del luogo del funerale. Non è un compito frivolo o da perditempo. È un buon impegno, un lavoro di grande utilità.
Mi viene da dire: funeraliamo. Inventando un verbo che costituisce un sicuro attentato alla bellezza della lingua italiana. Un verbo che però ha in sé qualcosa di clownesco, di goliardico o di carnevalesco, comunque di divertito e che, senza compromettere la serietà del fatto, gli eviti di sprofondare nel tutto cupo, nel tetro senza scampo; che aiuta ad abbassare la percentuale delle “facce da funerale” anche il giorno del funerale. Comunque un verbo perché rimanga sveglia l’avvertenza che il funerale è un’attività, un evento, un incontro vivo e da vivere nella vitalità della vita, e non appuntamento con la vita conclusa e finita di lui/lei, celebrata da altri per altro nella passività di riti prefissati e pilotati da altri.
Livorno, 22 agosto 1999
Gli amici ricordano…
Martino Morganti: Mai dire fine
Letture "E’ necessario avvicinarsi alle parole, quelle scritte e quelle dette,...
Ricordando Martino Morganti
Pistoia, 20 settembre 1927 - Livorno, 11 settembre 1999 Nel luglio dell'anno scorso a Martino è...
