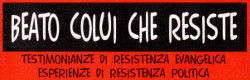
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1995
Terza relazione
Due precisazioni
– Mi è stato chiesto di descrivere, a titolo di esempio, la mia ricerca di una pratica politica “resistenziale”. Con l’unico intento di stimolare ciascuno a raccontare la sua, rendendone visibili i “criteri” che le danno dignità di azione “politica”. Il fatto di raccontarla all’inizio di questo convegno, non significa che essa sia in qualche modo “sponsorizzata”. Né l’atteggiamento con cui io ve la pongo vuole essere di tipo propagandistico. Anche se naturalmente non posso non parlare con passione delle cose che sto facendo e di cui sono convinto.
– “Le brevi note sull’azione politica” che allego al mio intervento contengono, per accenni, alcune premesse teoriche che qui do per scontate. Sono collocate a parte per alleggerire la comunicazione, ma anch’esse presumono di essere lette e di essere messe in discussione. In sintesi lì si riconferma, piaccia o no, che ogni azione che pretenda di essere buona non può eludere la dimensione politica.
Il contesto culturale di fondo in cui nasce l’autorganizzazione
Il fallimento epocale delle risposte storiche costruite sull’analisi di classe sembra mettere in discussione “tout court” la validità stessa di quelle analisi.
Fa senso vedere gli sconfitti prenderne precipitosamente le distanze proprio nel momento in cui i vincitori ne stanno dispiegando a livello planetario le conseguenze. La dialettica tra teoria e prassi chiederebbe invece di sottoporre ad analisi “critica” non solo gli aspetti teorici di quelle analisi ma anche le forme organizzative in cui si sono tradotte e che potrebbero essere state alla base della sconfitta.
Diversamente si commetterebbe lo stesso errore di chi pretende di buttar via il Vangelo perchè su di esso è nato il Vaticano. La mancanza di questa razionale chiarezza espone, soprattutto chi è arrivato all’analisi di classe per “contagio” o “col cuore”, a pesanti delusioni affettive.
Di esse si nutrono tutte quelle neoteorizzazioni ( – destino di “perdizione” della storia, – inesorabile corruzione insita nel “potere”, la “croce” come stare passivamente dalla parte dei perdenti, – svilimento dell’individualità come esito di ogni impegno politico organizzato….) che portano al disimpegno pratico dalla politica e al rifugio in una sorta di aristocratica resistenza solo interiore, ricercata attraverso il tentativo, velleitario, di sottrarsi individualmente alle regole imperanti
Il problema su cui punta il dito
Appare come dato inoppugnabile e sufficientemente universale che i movimenti di liberazione o di emancipazione sociale mentre da una parte necessitano di organizzazioni per raggiungere i loro obiettivi dall’altra incontrano nella loro burocratizzazione l’appuntamento con il loro decadimento e con la perdita della loro spinta propulsiva iniziale.
“Bombardate il quartier generale” era lo slogan con cui Mao traduceva alle guardie rosse il compito di riappropriarsi della “direzione” rivoluzionaria occupata dai nuovi mandarini.
Anche il “movimento operaio” è stato investito dalla “sconfitta” e anche in questo caso tra le tante cause che l’hanno determinata sembra esserci anche quella della degenerazione dell’organizzazione sindacale. L’esperienza storica ci obbliga quindi a “criticare” il modello organizzativo che il movimento si è dato.
Lungi dall’essere un secondario problema di “strumenti”, abbiamo toccato con mano a nostre spese che il modello organizzativo è talmente legato agli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere da non poterne essere disgiunto o rimandato a un secondo tempo.
Analisi dell’organizzazione sindacale fatta dall’autorganizzazione
– Il sindacalismo “professionale” a pieno tempo e la sua configurazione in “carriera” colloca l’apparato “sindacale” (anche se di provenienza operaia) in una condizione materiale di “privilegio” o comunque di “lontananza” rispetto a chi sta in produzione: sappiamo tutti bene quanto la diversa condizione materiale incida sul diverso approccio ai problemi reali;
– un apparato di questo tipo tende a costituirsi in vero e proprio “ceto sociale” a se stante, con corposi interessi di “casta”;
– il suo rapporto con la base diventa “invasivo”: i rappresentanti eletti vengono trasformati in “comunicatori” delle decisioni che la struttura prende e smettono di essere i canali attraverso i quali il volere e il pensare dei lavoratori irrompe nella struttura;
– a questo punto la struttura diventa particolarmente sensibile a recepire le offerte di riconoscimento istituzionale, con la relativa tutela legislativa dei privilegi economici (es. patronati, caaf, patti in deroga ecc, ecc…) o rappresentativi (articolo 19, maggior rappresentatività, quote garantite nelle Rsu…) che il potere le offre in cambio di una funzione calmierante e regolatrice del conflitto;
– ogni dissenso interno viene criminalizzato o nascosto e si utilizzano tutti gli strumenti a disposizione per soffocarlo e impedirgli di attecchire. La richiesta di maggior democrazia viene bollata come cavallo di Troia delle destre;
– quando i lavoratori esprimono una volontà divergente rispetto a quella elaborata dalla struttura (cfr. caso di Termoli e tutti quelli a seguire), un attacco concentrico di tutti i poteri li costringe a pentirsi. Con assolutismo teocratico si insegna che fuori dalla linea elaborata dalla struttura c’è solo anarchia, individualismo, egoismo, mancanza di solidarietà.
Le premesse ideologiche
L’autorganizzazione non nasconde le proprie premesse ideologiche, come invece fanno tutti coloro che si riempiono la bocca della morte delle ideologie e sotto sotto contrabbandano l’affermazione clandestina della loro.
L’autorganizzazione ritiene che il rapporto capitale-lavoro sia ancora connotato dal binomio sfruttamento-alienazione: anche se occultato (ma neanche poi molto) sotto forme nuove. Di conseguenza, la classe operaia continua ad avere un ruolo generale (cioè non solo per sé) da svolgere.
I lavoratori continuano a rappresentare il nocciolo duro del sistema di produzione e di accumulazione del capitale. Questo è il motivo per cui non è tollerabile per il sistema permettere loro, in quanto lavoratori, di darsi un’organizzazione rappresentativa che non sia subalterna ai valori che sono socialmente imposti. E per far questo non si ha vergogna a negare ai lavoratori anche quei minimali diritti di democrazia che sono il vanto delle nostre “civiltà occidentali”. Costituzione e democrazia si fermano fuori dalle mura delle fabbriche.
Il progetto dell’autorganizzazione
L’autorganizzazione si propone la ricerca e la rivendicazione di un nuovo modello organizzativo che permetta ai lavoratori di esprimere nella loro rappresentanza, nel caso lo volessero, i loro interessi di classe.
Questo nuovo modello, facendo tesoro degli errori del passato, ci sembra esigere:
1. un livello di partecipazione di massa più cosciente
2. un livello di democrazia reale più elevato.
1. Per poter perseguire il proprio compito storico, in una fase in cui le catene da cui liberarsi non sono più quelle primitive della fame e della miseria ma quelle di sudditanze sempre più raffinate imposte alla propria dignità, alla propria libertà e all’uguaglianza di tutti, il movimento esige un livello più alto di coinvolgimento coscienziale e partecipativo, senza del quale esso diventa impossibile e le burocrazie hanno la possibilità di sovrapporsi al movimento di classe non “esprimendolo” ma “regolandolo”.
2. L’autorganizzazione si rifiuta di accettare che i lavoratori vengano considerati “soggetti a rischio” per cui ad essi possa essere concessa solo una “democrazia controllata”. Secondo l’analisi dell’autorganizzazione, Cgil-Cisl-Uil si sono ormai adattate alla necessità di subire le regole del mercato, e quindi sono diventati, volenti o no, strumento attraverso cui passa il progetto di totale mercificazione di ogni aspetto della vita umana. Per reprimere però le spinte antisistemiche che salgono dal ventre della “classe” Cgil-Cisl-Uil sono costrette a ridicolizzare qualsiasi reale passione per una partecipazione cosciente di massa e ad opporsi a qualsiasi passo in avanti verso una democrazia vera.
L’autorganizzazione lavora sull’ipotesi che
la classe operaia,
– se sottratta al dominio culturale del “pensiero unico” provocato anche dall’assenza di quel “maestro” alternativo che dovrebbe essere la sua organizzazione
– se posta in condizioni di darsi democraticamente una struttura rappresentativa che ne esprime i veri bisogni e la organizza efficacemente
è in grado di attingere dalle proprie condizioni materiali
– la coscienza di sé come classe
– la consapevolezza della propria unità e della propria forza
per riprendere a svolgere il proprio ruolo antagonista al sistema capitalistico.
Questa è in ogni caso una sfida epocale che la storia pone davanti a tutti.
A questa sfida l’autorganizzazione tenta di rispondere.
Una pista concreta di “autorganizzazione”
Diverse sono le pratiche che, rifacendosi agli assunti teorici dell’autorganizzazione tentano di attualizzarla. Non sempre coerentemente e talvolta abusando del concetto stesso.
I “comitati di base” (cobas) nati nelle grandi industrie metalmeccaniche rappresentano lo specifico cammino in cui io mi sono situato.
Il “comitato di base” nasce là dove un gruppo di lavoratori, esaurita ogni possibilità di riportare l’organizzazione sindacale sotto controllo diretto dei lavoratori attraverso una lotta al suo interno, decide di venirne fuori e di rendere visibile la propria scelta di non delegare più a nessuno la tutela dei propri diritti.
Normalmente la semplice apparizione di qualcuno che autonomamente pretende di “pensare” e di “dire quello che pensa” provoca reazioni scomposte negli apparati sindacali: prova eloquente che si è toccato un nervo scoperto.
Tra i lavoratori invece, la nascita di un soggetto collettivo così inusuale, che rompe la passività generale e chiede a tutti di schierarsi, ha l’effetto di un sasso gettato in uno stagno, e comunque rappresenta un fatto indubbio di “rianimazione”.
Il “comitato di base” inizia col proposito di rianimare la vita sindacale di fabbrica potendosi permettere di dire tutto senza dover chiedere il permesso a nessuno.
Riscopre una dimenticata vigilanza dal basso su tutti i problemi di reparto (salute, rapporti autoritari coi capi, professionalità, salario, controllo degli orari…) e un violento sguardo “di fabbrica” sulle manovre che i vertici sindacali abitualmente gestiscono coi Governi di turno.
In poco tempo emerge il conflitto con le “compatibilità” di sistema (nome nuovo dato agli interessi complessivi dei padroni) accettate dai sindacati. Il Cobas si offre come la voce e la sponda organizzativa di quei lavoratori che non intendono subirle. Arrivando diritto di filato al problema di chi ha il diritto di rappresentare tutti i lavoratori e quindi di trattare a nome loro, dal livello di fabbrica a quello nazionale.
Da questa pratica è scaturita la nostra attenzione a come si costruiscono le rappresentanze democratiche dei lavoratori e la conseguente campagna per l’abrogazione totale dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (all’ordine del giorno in queste settimane).
In questa battaglia abbiamo scoperto che pretendere che ai lavoratori sia concessa almeno la “democrazia parlamentare borghese” è un fatto rivoluzionario.
A chi ci sta preparando la gabbia di un “sindacato unico di regime” noi opponiamo la ricostruzione dal basso dell’unità vera tra tutti i lavoratori. Rivendicando il diritto all’esistenza a tutti i sindacati di questo mondo ma rimettendo il potere reale di rapprentare i lavoratori tutto e unicamente al “parlamento” da loro liberamente eletto (dalla fabbrica al nazionale) senza quota garantita a nessuno, neppure in base al numero dei propri iscritti. Esattamente come non si regala un solo parlamentare a nessun partito in base ai propri tesserati.
La linea rivendicativa espressa da ogni sindacato conterà in questa struttura rappresentativa e contrattuale solamente in base ai consensi effettivamente ottenuti dai lavoratori nel momento elettivo generale.
Per tutelarci dalle reazioni congiunte di padroni e sindacati e per raggiungere più efficacemente il nostro obiettivo, ci siamo coordinati a livello nazionale costituendo l’associazione sindacale nazionale denominata “Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale (Slai)”.
Lo Slai Cobas non è un altro dei tanti sindacati o sindacatini, come ci si accusa.
Lo Slai Cobas è un anticipo esemplare della forma organizzativa di cui noi pensiamo la classe abbia bisogno: tant’è vero che provocatoriamente lo abbiamo chiamato l’anti-sindacato, il sindacato senza sindacalisti.
Lo Slai Cobas non mira a riprodurre una nuova generazione di “colonnelli” più puri e forti di quelli che ci hanno preceduti, ma 1avora per rinviare ai lavoratori la responsabilità collettiva di farci tutti sindacato.
Per questo lo Slai Cobas non ha un “suo” futuro per cui lavorare. Non si prefigge di organizzare alla bell’e meglio poche o tante avanguardie.
Fuori da una ripresa di protagonismo di massa dei lavoratori lo Slai Cobas non ha futuro, proprio perchè i suoi destini si fondono sulla possibilità della riapparizione di un forte movimento operaio su posizioni classiste e anticapitaliste.
Esso rappresenta un concreto progetto politico perchè ciò avvenga. Partendo dall’autorganizzazione dei lavoratori.
Se l’istanza dell’autorganizzazione dovesse essere inglobata da una opposizione sociale più vasta, essa potrebbe diventare un punto di sbocco più generale di quello limitato che noi esprimiamo.
L’autorganizazione non sarà più quindi solo una “nuova forma” dello strumento della lotta sindacale, ma una forma più alta, più libera e completa del vivere sociale.
Allegato:
BREVI NOTE SULL’AZIONE POLITICA
a cura di SANDRO ARTIOLI e dei PO lombardi
La retta intenzione
Ogni azione è definita innanzitutto dal fine che si propone.
Nessuna azione può essere buona se il fine che si prefigge di raggiungere è malvagio.
Avere una “retta intenzione” è quindi necessario. Ma non sufficiente.
Il raggiungimento dell’obiettivo
Un’azione per essere buona pretende anche di esserlo “in sé”, cioè nelle caratteristiche che la compongono. Un’azione non diventa buona solamente per il fatto che ad essa si sovrappone un’intenzione retta. Tra le caratteristiche che rendono un’azione buona “in sé”, c’è quella che essa sia potenzialmente efficace, contenga cioè tutti i requisiti ragionevolmente necessari per raggiungere il fine retto che si propone.
L’efficacia nell’azione politica
L’oggetto che un’azione buona cerca efficacemente di perseguire può essere o l’affermazione di un positivo (un bene) o la negazione di un negativo (un male). Una corretta ricerca di efficacia non può però non prendere in considerazione l’eventualità che il bene che si vuole costruire (o il male da cui ci si vuole liberare), non possa essere raggiunto senza un’azione anche sulle cause strutturali (sociali, politiche, economiche) che quel bene negano o quel male generano.
Se così fosse e non si ricercasse l’efficacia anche nella rimozione-affermazione di queste cause, l’azione non avrebbe tutte le caratteristiche necessarie per poter essere detta “buona”.
Questa è la permanente dimensione politica della “carità”.
Ogni buona azione presuppone quindi una “opzione politica buona” dentro cui essa si innesta e senza della quale essa è vana. E un’opzione politica deve proporsi come efficace.
A questo punto i problemi che si pongono sono:
* un’azione può essere giudicata già in partenza come carica di efficacia potenziale? e in base a quali criteri?
* dopo quanto tempo un’azione perseguita come efficace deve essere sottoposta a verifica e valutata se lo è stata veramente?
* l’efficacia è importante nell’azione a tal punto che ogni mezzo è buono purché la raggiunga?
* solo chi vince ha ragione?
L’efficacia di partenza
In partenza all’azione è richiesto solo di partire da elementi di analisi seriamente valutati e di progettare la messa in moto di meccanismi che potrebbero avere la ragionevole possibilità di raggiungere il fine che ci si propone. Non sono tali le azioni pressapochiste, avventuriste, individualiste. Su altro piano si colloca naturalmente la testimonianza individuale, anche eroica, che può essere l’ultima chance lasciata per poter rispettare l'”extrema ratio” della propria coscienza.
La verifica dell’efficacia dell’azione
La verifica dell’efficacia di una azione non può essere rimandata continuamente ad un “dopo” escatologico, perché ciò equivale a una non verifica. Tenendo pure presente che, soprattutto le azioni politiche che si prefiggono di intervenire nel “macro”, l’efficacia di un’azione può anche pretendere di essere misurata in un arco di tempo che va al di là di quello di una vita individuale, occorre saper cogliere i momenti storici in cui un’azione, perseguìta a lungo nel tempo, esige di essere verificata.
Le azioni più spicciole richiedono invece di essere accompagnate da una verifica continua della loro efficacia. Di fronte all’inefficacia dell’azione posta in atto non ci si può rassegnare ad addebitarne la causa alle forze che si sono ad essa opposte, ma occorre individuarne gli eventuali errori commessi in fase di progettazione e in fase di realizzazione. Questo lavoro di “critica” permette di ricavare quegli elementi che consentono di correggere l’azione, progettandone un’altra che faccia tesoro degli errori commessi nella precedente.
Con ogni mezzo, pur di essere efficaci, allora?
Questo può valere, forse, per il raggiungimento di un fine malvagio.
Ma l’affermazione che anche per raggiungere un fine giusto sarebbero leciti mezzi ingiusti purché efficaci, è stata giustiziata non dalla morale ma dallo stesso principio di efficacia. La pratica storica ha dimostrato infatti che se i mezzi sono “in contraddizione” con il fine che si vuole raggiungere, anche se nell’immediato sembrano accorciare la strada, alla lunga i germi di cui sono portatori continuano inesorabilmente la loro strada finendo col “corrompere” lo stesso fine. Essi sono quindi alla lunga inefficaci. Il fine che si vuole raggiungere non “giustifica” quindi, ma ”qualifica” i mezzi da adottare.
(A questo riguardo come è improprio giustificare la ribellione armata di un popolo sottomesso dicendo che il fine giustifica i mezzi, è altrettanto improprio dedurre che la lotta armata, essendo un mezzo violento, sia in ogni caso inadeguata a raggiungere un fine buono. Essa va giudicata nella sua presunzione di essere, in una specifica situazione, l’ultimo mezzo a disposizione per impedire una violenza enorme e non altrimenti vincibile. La negazione cioè di un negativo.)
Le verifiche epocali
Possono però arrivare dei momenti in cui il fallimento di un progetto storico è registrato non tanto in questa o in quella azione particolare ma su un fronte”planetario”: diversi cammini, eroicamente tentati, e a lungo, e in tanti posti diversi, e da moltitudini di uomini, depositano uno sull’altro il peso del loro fallimento e della loro inefficacia di fronte ad altri progetti dimostratisi più spregiudicati e più forti.
Questo può generare un clima generale per cui è ragionevolmente difficile, almeno in quel momento, assegnare una qualche ragionevole probabilità di “efficacia politica” a qualsiasi progetto alternativo. Si pone quindi la domanda se si può continuare a chiamare un’azione politica “buona” quella di cui si pronostica già come altamente probabile l’insuccesso e l’inefficacia. O se essa non si configuri come lo strascico velleitario di chi non si rassegna ad essere stato sconfitto. E’ con quest’ultima ipotesi che molti giustificano il loro “passare ad altro” abbandonando il campo.
L’efficacia non si identifica solo con la vittoria
Rileggendo la storia di tanti movimenti di “liberazione” e del loro esito, viene a tutti da pensare alle tante vite spese nel progettare e nel costruire un progetto, che, non essendosi realizzato, appare fallito agli occhi di tutti. Siccome la “vittoria” alla lunga è andata ad altri, si potrebbe quindi concludere che tutto ciò che è stato fatto, essendosi rivelato inefficace, è stato inutile.
Ma è possibile leggere in un altro modo la storia complessiva di tutti questi multiformi tentativi di generare azioni politiche buone, e scoprire che una loro efficacia l’hanno comunque raggiunta. Soprattutto provando a pensare che cosa sarebbe stata la storia se essi non ci fossero stati.
Il flusso freddo che percorre la storia dell’umanità è contrastato dalla presenza continuamente risorgente di queste correnti calde che, or qui or là, irrompono sul palcoscenico del mondo. Esse si richiamano tra di loro, si passano il testimone da una nazione all’altra, da un secolo all’altro; e, pur non avendo vinto in nessun posto, la loro efficacia sta nel non essere mai state sconfitte del tutto e per sempre.
In questo quadro è possibile allora continuare a ricercare azioni che si propongano di essere intelligentemente efficaci, sapendo che in ogni caso esse rappresentano il nostro contributo, non inutile, al permanere di quella corrente calda che viene da lontano e che impedisce alle forze dell’oscurità di dominare incontrastate su tutto e su tutti, rendendo infinita la storia e impossibile il permanere di ogni progetto di salvezza per il mondo.
Inserire la propria vita in questa “corrente calda” vuol dire lavorare per offrire agli umani di tutti i tempi una possibilità dignitosa di senso non alienato per la loro vita. Che altrimenti non sarebbe dato.
Che è poi la loro dimensione trascendentale.
Sandro Artioli
