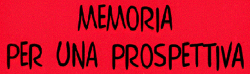
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1996
seconda relazione
Memoria di una compagnia paritaria
con uomini e donne nella quotidianità del lavoro
|
|
|
Non cercare
|
Noi non andiamo Segno non è |
|
|
|
Il Regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto |
|
I testi sopra citati ci faranno compagnia in questo tentativo di memoria del Collettivo dei PO Italiani.
Non siamo nati PO, ma lo siamo diventati nel dinamismo di una storia personale e collettiva in cui ci siamo scoperti “discepoli” attirati dallo sguardo di Cristo, dal fascino del Vangelo, dalla speranza del Regno. Abbiamo imparato cosa voglia dire “obbedienza” di persone mature e libere “nell’incontro con l’esso dove si maschera Dio e da questo esso (destino o storia) nasce di continuo effettivamente la ‘guida’!” (Bonhoeffer).
Il passare del tempo porta con sé un vaglio fino nel profondo del nostro essere, una scrematura, una verità sulle illusioni e sulle tensioni ideali.
Rimane invece la compagnia paritaria (espressa nella condizione operaia) con gli uomini e le donne del nostro tempo nella partecipazione al destino comune, senza sconti e a pieno titolo. Si è stagliata da questa obbedienza una nuova identità, identità polemica, proprio dalla convivenza in noi di due poli disomogenei: il prete e l’operaio, tanto da apparire come realtà in qualche modo paradossale, “dove le due dimensioni assolutamente distinte, simbolicamente si relazionano” (Cacciari). Da questa relazione mai equilibrata e statica è informata la storia dei pretioperai italiani.
Per tentare una memoria, prenderò quindi dai sensori costituiti dai Convegni o Seminari nazionali in cui il Collettivo si è espresso, ma anche dagli scritti individuali prima riportati dal Bollettino di collegamento e poi dalla rivista Pretioperai. La relazione sarà necessariamente impostata a sprazzi e farò riferimento (senza peraltro citarne continuamente la fonte) ai nostri interventi collettivi od individuali.
Fare memoria: gli ambiti potrebbero essere numerosi e diversi; ma a noi interessa l’ambito del nostro convenire: fare memoria per una prospettiva. Mi limiterò quindi a dei richiami generali per mettere a fuoco i passaggi, i nodi e le parole comuni che sono diventate punto di riferimento del collettivo nel mutare delle condizioni; sono come il tesoro scoperto e ricoperto della parabola.
Ripercorrendo il cammino, nell’insieme della nostra storia emerge una sorprendente logica dei vari passaggi: dalla crisi del ruolo, ai temi ecclesiali, alla dimensione politico-sociale, alla ricerca di sensi nuovi. In ogni periodo, pur nell’accavallarsi delle problematiche sopra citate, risulta egemone un particolare ambito che riduce ad unità la nostra esperienza e su questi ambiti la nostra riflessione è durata anni.
1° ciclo
L’incontro con la concezione di lavoro e con la Classe Operaia mette in crisi il proprio mondo ed apre strade ed interpretazioni nuove.
• Chiavari ’69 – convegno: Vivere il nostro sacerdozio nel lavoro.
• Bologna ’70 – seminario: Che significato dare alla preghiera?
• Firenze ’70 – convegno: La nostra fede in Cristo vivente oggi.
Le tematiche sopra richiamate risentono della sponda ecclesiastica di partenza; il cordone ombelicale è resistente, ma l’attrazione dell’altra sponda è più forte; ci si butta in mare aperto rifiutando il salvagente di coperture istituzionali: si rischia in proprio.
Perché lavori? “Per essere onesto con me stesso e gli altri, per essere autonomo, per purificare la Chiesa…”. Si incrociano ricerca di autonomia e profezia per la Chiesa e la Classe Operaia. La ricerca di autenticità interroga e rende vulnerabile la professione ed il ruolo del prete.
“E cosa rimane della preghiera quando si è spogliati della veste talare ed immersi nel lavoro e nella militanza?”. I ritmi ed i significati precedenti si frantumano nella visione laica e nella lotta politica per la liberazione degli sfruttati. L’esperienza di spogliazione spinge alla ricerca di altri significati.
Peggiore risulta il disagio dal fatto che i compagni di lavoro non domandano conto della nostra fede; esprimono al massimo una dicotomia tra realtà di oppressione e domanda religiosa. “Il centro è la lotta per la giustizia oltre il senso di cui ci riteniamo depositari”. Anzi, la Chiesa è vista come segno di valori inconsistenti, o peggio, connivente con la controparte.
Il risultato di questo impatto suscita l’esigenza di doverci attrezzare per reinterpretare la fede e vivere l’esperienza di una comunità credente a partire dalla nuova scelta di vita: l’essere in Classe Operaia.
Le parole comuni di questo periodo sono prevalentemente di ambito religioso: incarnazione, spogliazione sulla falsariga di Fil. 2,5, vissute nella dinamica personale.
2° ciclo
Dalle opzioni personali alla presa di coscienza di essere in qualche modo un Collettivo situato nella contraddizione tra Chiesa e C.O.
• Reggio Emilia ’73 – convegno: Fedeltà alla Classe Operaia, fedeltà a Cristo ed al Vangelo nella Comunità dei credenti.
• Serramazzoni/1-’75 – convegno: Rendiamo conto della nostra fede: quale fede?
• Serramazzoni/2-’76 – convegno: Contro l’uso antioperaio della fede.
• Salsomaggiore/1-’77 – convegno: Gente di confine.
I PO italiani, distaccatisi dalla sponda clericale, approdano e si àncorano saldamente alla sponda della Classe Operaia; ma il mare è unico, separa e nello stesso tempo unisce le due sponde.
“È nostra ferma intenzione rimanere per sempre in C.O. accettando lealmente il Movimento Operaio, militando nelle sue organizzazioni storiche e di classe”. Non è una delle tante esperienze che la vita presenta; siamo di fronte alla scelta fondamentale da cui guardare, interpretare, dare forma a tutta la realtà. Non è semplice per noi svestirci del ruolo di maestri, deporre strumenti teologici o di interpretazione evangelica per assumere strumenti laici come: analisi, progettualità politica, organizzazione, lotta… La laicità è un terreno dove le regole e le giustificazioni sono immanenti.
Il salto di qualità ci porta a prendere atto della centralità del Movimento Operaio come coscienza storica della perversità dei meccanismi capitalistici di produzione determinanti non solo la distribuzione, ma anche la cultura, i valori, i consumi, l’organizzazione autoritaria del vivere sociale e politico. La C.O. si pone nella dimensione progettuale alternativa: il socialismo, e si presenta come forza storica di liberazione degli sfruttati ed emarginati della storia…
La fede, se da una parte inabita la profondità della persona, dall’altra germoglia nella terra che abbiamo scelto come tensione verso cieli nuovi e terra nuova della promessa. Ma come PO siamo sul crinale tra fede ed incredulità poiché sorge la domanda “se sia possibile la fede quando il cristianesimo storico si è reso strumento delle guerre di religione, della tratta dei negri, del colonialismo e del capitalismo. Lui sta non dove l’hanno messo, ma nel cuore e nella nostalgia della gente”. Problematico rimane anche il rapporto tra scelta di classe e scelta evangelica dei poveri.
Dalla posizione di C.O. con sofferenza e rabbia denunciamo l’uso strumentale della fede contro la C.O. Un bene pubblico usato per scopi privati, ridotto a ideologia, ad ombrello per difendere privilegi, poteri, e spazi sociali da occupare. I PO invocano la profezia dirompente dei profeti della Bibbia e di Gesù di Nazaret e l’essere in C.O. diventa per noi una necessità e l’unica possibilità di annunciare il Vangelo ai poveri.
Siamo in una posizione scomoda tra Chiesa e C.O.: “la Chiesa non solo non ci riconosce, ma ci sospende a divinis per le scelte politiche, il divorzio e poi l’aborto… ed anche i compagni ci guardano con sospetto”. L’attraversamento delle due culture, storie e valori avviene nello schierarsi con gli sfruttati e da questa scelta si può reinterpretare il mondo di provenienza. Il confine è il nostro Esodo, la nostra Pasqua.
Nel ‘76 viene respinta la proposta di un rapporto organico con la CEI presentata dal vescovo Cesare Pagani; questo fatto porta ad accentuare le differenze all’interno del collettivo PO. Principalmente i PO Piemontesi, ma anche altri, con l’esperienza del card. Pellegrino vedono possibile il sorgere di uno spezzone di Chiesa in C.O. attraverso l’attuazione di un “progetto comune” di varie componenti della Chiesa di Torino. Come conseguenza si accentuano le tematiche del mandato e del ministero legate al senso di essere Chiesa. Gli altri PO che fanno esperienza dell’esclusione come la C.O., vedono la negatività o l’impossibilità di esprimersi in categorie ecclesiastiche incapaci di rappresentare la nuova situazione.
Le parole comuni di questo periodo sono equilibrate tra il religioso ed il profano: fede storicizzata, schierarsi / compromettersi; laicità, progetti di liberazione, socialismo.
3° ciclo
Presenti in C.O. nella quotidianità affrontiamo la durezza del tempo.
Ora il pendolo si sposta dalle tematiche prevalenti della fede e della Chiesa al terreno del vivere la storia dolorosa del tempo: la profonda crisi economica, sindacale e democratica. Sono gli anni di piombo, delle divisioni… anni di crogiolo e di purificazione.
I convegni e gli apporti di questo periodo riguardano il cambiamento strutturale e delle condizioni di lavoro intrecciati con i richiami ad essere credenti in situazione.
• Viareggio ’79 – convegno: Credere ed operare la giustizia. Nasce il Bollettino di collegamento dei PO
• Frascati ’81 – convegno: Tra disgregazione e speranza, con la fede nel quotidiano per non essere schiacciati, né alienati dalla crisi.
• Castiglione dei Pepoli ’82 – seminario: Quale militanza.
• Sassone ’83 – convegno: Vita quotidiana e declino della progettualità; come uscire dalla crisi diversi?
• Verona ’85 – seminario: Ricerca sui ministeri.
• Firenze ’86 – convegno: Civiltà tecnologica: sfruttamento, emarginazione; la fede interroga i progetti.
• Firenze ’87 – nasce la rivista Pretioperai.
• Verona ’88 – seminario: Vivere ed annunciare le beatitudini oggi.
Equilibri o rendite garantite non sono la nostra caratteristica. Accettiamo il camminare e crediamo alla storia dei compagni di strada. Pesante risulta l’ingiustizia fatta sistema dal capitalismo: “il lavoro ridotto a merce, gli operai sono ostaggi, la divisione tra garantiti ed assistiti, il divario tra bisogni reali ed indotti, l’informazione guidata contro la C.O., la normalizzazione…”.
La crisi energetica presenta la politica dei due tempi; e dalle ristrutturazioni delle fabbriche sono cacciati migliaia di lavoratori. I 40.000 della Fiat scesi in piazza con lo slogan: “lasciateci lavorare”, sono il segno della spaccatura tra lavoratori.
Ma è anche il momento dell’apertura al territorio e alle fasce emergenti: Donne e Giovani.
Le differenti militanze portano tensione anche tra noi; nasce il bisogno di ricapire la militanza e “riaffermiamo ancora l’essere in C.O. con la pazienza storica e nel ministero della lotta, superando facili messianismi per un impegno nel quotidiano”. La fedeltà nel quotidiano diventa il nostro cruccio perché non rinunciamo ad essere “soggetti di storia”.
Sull’altro versante, la nostra fede non va alla ricerca di spazi dove stare al sicuro, ma si gioca nella tensione alla giustizia come compito umano: “abitare la terra, vivere di fede e ricercare la giustizia”.
Il tentativo di dialogo con i Vescovi trova un nuovo interlocutore nel Vescovo Battisti della Commissione sociale / lavoro; ma le mosse di altri vescovi sono la sospensione di Franco Brescia, di Louis Picler e poi di Roberto Berton per le posizioni politiche ed ecclesiali.
Come collettivo chiediamo ai vescovi di non uccidere la speranza, ma “di aprire un dialogo con il mondo moderno su una serie di problemi che vanno dai ministeri, alla sessualità, alla scomunica dei comunisti…”. I Vescovi, di ricambio, pongono le questioni sul ministero da salvare in condizione operaia, e sul mandato.
Questi dieci anni sono caratterizzati anche da profonde tensioni nel nostro collettivo. I seminari sulla militanza, i ministeri e le beatitudini esprimono le nostre differenti visioni.
Le parole diventano prevalentemente laiche: crisi, ristrutturazione, militanza, ma anche fedeltà alla C.O. e al Vangelo; ma tra noi emerge il divario dei significati.
4° ciclo
Un’identità, ma quale identità per il Collettivo PO?
Con il convegno dell’89 si apre un nuovo percorso. Il pendolo sembra riallinearsi prevalentemente su tematiche di fede superando la centralità ecclesiastica per un’esperienza del Mistero dentro le situazioni di sofferenza ed oppressione di interi popoli, nella dimensione sapienziale.
• Salsomaggiore/2-’89 – convegno: PO: qualche anno dopo.
• Salsomaggiore/3-’92 – convegno: Dai diamanti non nasce niente… nella condizione operaia, Vangelo od evangelizzazione
• Salsomaggiore/4-’94 – seminario: Paradosso cristiano del XX secolo.
• Salsomaggiore/5-’95 – convegno: Beato colui che resiste.
• Salsomaggiore/6-’96 – convegno: Memoria per una prospettiva.
“Dopo una lunga stagione che ci ha visti impegnati come PO, tenendo anche conto dei cambiamenti, delle differenze, delle difficoltà di dialogo, ci si domanda quali siano le idee forza e le intuizioni alle quali ci ispiriamo”. La nostra strada è inconsueta per un prete. Le due figure eterogenee: il prete e l’operaio, cariche di stimoli, appartenenze, culture, quotidianità tanto diverse hanno portato nelle nostre persone un incontro-scontro ed è avvenuto un processo di destrutturazione in una faticosa ricerca di nuove identità. “L’incarnazione od il farsi uomini, la compromissione nelle situazioni concrete, parziali, costrittive fa sì che le nostre vite siano caratterizzate dalla incompiutezza e dalla frammentarietà, eppure da questo disequilibrio si può percepire la pienezza di un progetto”.
Il tempo trascorso ha lasciato il segno come per i nostri compagni di lavoro. Il cambiamento degli eventi esterni e gli orientamenti personali hanno cambiato la stessa composizione del collettivo PO. Tra noi ci sono pensionati, prepensionati, disoccupati, alcuni resistono ancora nelle fabbriche, o nell’artigianato, altri si sono inseriti nel campo sociale, nelle cooperative, nel volontariato nel campo della droga o dell’handicap, con i terzomondiali in Italia o all’estero, nei cammini di pace e di nonviolenza… C’è chi è inserito in parrocchia ma con un atteggiamento critico ed antistrutturale contrastando la dimensione ateistico bigotta di certa gestione ecclesiastica.
E non ci siamo nemmeno strutturati per andare oltre la nostra generazione. Insomma non siamo per niente efficienti; eppure la nuova struttura “va ricercata nell’essere figura vivente, parabola, volto che interroga dalle pieghe della condizione operaia”. In linea con il discepolo anonimo di Gv.21 che va oltre la preoccupazione di Pietro di prevedere, organizzare, controllare. La legittimazione è solamente interna alla vita che abbiamo scelto: nella dislocazione dal basso.
“Siamo nella Chiesa come ‘memoria sovversiva’ del Vangelo e nella condizione operaia dando forze finché possiamo”. E proprio perché non è un’esperienza ma una scelta di vita, non sappiamo nemmeno come andrà a
finire.
Di fronte al “non senso” che esprime la vera povertà del nostro tempo che mette a rischio il futuro e la speranza, l’unica posizione possibile è quella di non farci omologare: nella capacità di dare volto e spazio all’altro, alla diversità, alla debolezza, come elementi di rottura e di continuità della storia e della speranza. Ma questa condizione passa attraverso l’abisso, il vuoto, il nulla di esistenze private di significato e sottoposte alla miseria, alla costrizione, all’ingiustizia da parte del progetto vincente.
“Nel Venerdì santo, il seme caduto in terra muore e basta; non c’è nulla da raccogliere, ma solo lo iato tra croce e resurrezione”. La sofferenza dell’innocente proclama al mondo la giustizia come grido, urlo di fronte al vuoto e alla morte. Il grido è misteriosamente abitato da Dio non più onnipotente nel dogma, nella morale, nella simbologia o nell’organizzazione. Il Dio debole nella debolezza dei poveri apre la storia: “spero in Te finché non sia passata l’iniquità della notte” (S. Agostino).
Non esiste un Vangelo allo stato puro; ogni generazione lo riceve dalle comunità precedenti nella veste dell’evangelizzazione necessariamente legata al proprio tempo. Ogni volta occorre spogliare il Vangelo per rileggerlo nella propria storia. Questa fedeltà alla condizione storica umana manda in crisi ogni evangelizzazione ritenuta esaustiva. Arduo è poi rimanere nella complessità delle situazioni “ascoltando Dio senza ridurlo ad oggetto, possesso, merce, riconoscendo la sua signoria (coram Deo) anche attraverso le nostre infedeltà.
Dislocati in deserto
andiamo oltre la foresta delle fedi
liberi e nudi verso il nudo essere,
e là dove la parola muore,
abbia fine il nostro cammino. (Davide M. Turoldo)
“Su noi grava la gloria di Dio che non è un’immagine della potenza di Dio o del trascendente, ma qualcosa di simile ad una mano che incombe, ad un peso che sta sopra il popolo notte e giorno. E nessuno può toglierlo e chi tenta di toglierlo tradisce il mistero” (A. Potente).
Dall’altro campo: la condizione operaia; sembra che le nostre riflessioni siano più deboli, meno precise con un pericolo di fughe nella ricerca “spirituale”. Le parole dominanti sono fuori di noi e confuse nella complessità del sistema. Resta l’apporto lucido, ma anche problematico di coloro che sono ancora in condizione operaia.
“In questa fine del 2° millennio sembra che la storia stessa sia arrivata ad una sorta di fine. Si sono esauriti i tentativi di dare alla storia una sua direzione e si assiste al dispiegamento planetario di quel modo di costruire l’umanità e di concepire il mondo che si è rivelato vincente, il meno peggiore dei possibili. Mercato, tecnologia e capitale vivono per motore proprio e sono fini a se stessi attraversando il Nord ed il Sud del pianeta”.
“L’indifferenza è il principio in grado di salvaguardare lo standard di vita del Nord e gli interessi dell’economia. Sembra che il microprocessore del principio di indifferenza ce lo stiano inconsciamente installando nei computer dei nostri cervelli… Di fronte a questo processo è giusto provare a chiedersi sinceramente: il Dio cristiano, tirato dentro con l’incarnazione di un cristianesimo politico dimostratosi fallimentare, ha ancora qualcosa da dire di credibilmente serio a coloro che, sconfitti dall’esito di questa storia, non si rassegnano a vivere come mostri, ma conservano la speranza di una storia altra?”.
Il senso della parabola dei PO è stato quella di tentare di guardare la storia dall’altra parte e dal basso. “Non è una scelta facoltativa, ma l’unica possibile, poiché le uniche parole etiche, politiche, religiose davvero nuove usciranno solo da quella porzione di umanità che ha ancora bisogno di avere delle speranze”. Pur nella vittoria del pensiero unico rimane sempre un ‘resto’ che non ha rinunciato a pensare; anzi su alcuni nodi la coscienza è diventata più lucida (ambiente, pace, consumo…) anche se necessitiamo di più coscienza e di meno delega. “Tra alcuni PO c’è un’accentuazione della dimensione etica e coscienziale (necessaria), accompagnata però da un disgusto verso la politica per il suo fallimento, privilegiando il buttarsi sulle nuove piaghe sociali vissute però secondo la tradizione ecclesiastica della carità, esonerandosi dal dover fare i conti con le forme economiche e sociali in cui si strutturano i progetti pro o contro l’uomo”.
Resta problematica anche la posizione del Sindacato Confederale di fronte al progressivo riconoscimento istituzionale da parte del padrone e dello stato a fronte della sua normalizzazione nelle regole del sistema, riconducendo lo spazio della progettualità alla compatibilità, divenendo così una forza di conservazione.
Nella Chiesa, con il superamento del regime di cristianità, non sembra si siano aperte strade nuove. Per noi resta impossibile una proposta di dottrina sociale della Chiesa come strada di mediazione. “Oggi ci sono molti messaggi ma mancano i significati, ossia i sensi per cui si decide; come è possibile allora operare mediazioni? Oggi occorre resuscitare i sensi più che fare mediazioni… Dio nella logica biblica non gestisce, ma sta accanto all’uomo per partecipare al suo dolore regnando dal legno della croce” (G. Mancini).
Il paradosso è anche tra cristianesimo e storia; mentre l’agire etico si svolge tra obbligo e gratuità secondo le situazioni assunte e “noi, servi inutili, siamo arrivati là dove dovevamo arrivare e non di più” (A. Rizzi). Tra il farsi volto dell’atto etico e della testimonianza e il dire il Nome si dibatte la tensione della vita dei PO
La beatitudine del resistere di fronte ai poteri senza più contrasto, che creano esuberi ed apartheid su scala mondiale, appartiene a tanti uomini e donne del nostro tempo. Resistere al pensiero unico che pretende basarsi su presupposti naturali (per cui sei dichiarato antistorico) come: primato dell’economia sulla politica, del bene privato sul bene comune con le sue leggi di produttività, concorrenza, diventa resistere all’idolatria della bestia dell’Apocalisse.
I PO in questo contesto, sono diventati “qualsiasi”, gente comune, senza privilegi, ma nella ricerca di una dimensione sapienziale non occupando spazi particolari ma problemi vissuti secondo la parabola del sale e del lievito. “L’efficacia non sta tanto nel cambiare il mondo una volta per tutte, quanto nell’impedire, come flusso di corrente calda, che il flusso freddo raggeli la storia”.
Chiudo con una citazione di Sirio che, dopo dieci anni, serba ancora tutta la forza della profezia:
“La storia è un’enorme forza di liberazione per la capacità che il tempo possiede di decantazione, di superamento, di dimenticanza, di cancellazione. Può essere però ugualmente seppellimento di morti e seppellimento di viventi… E la speranza non è necessariamente legata e dipendente da particolari momenti favorevoli o disastrosi della storia. È una permanenza, una vitalità sempre presente…
Chi è sceso sulla strada, ha scelto e deciso semplicemente di uscire dal cerchio del privato (qualsiasi privato, compreso quello della propria salvezza) e di confondersi e perdersi nella folla, qualificata od anonima che sia. Non è pensabile che la permanenza possa essere dipendente da una soggettività o, peggio ancora, dalla giustificazione di un gradimento o dalla constatazione della sconfitta, dall’avvertenza dell’inutilità o semplicemente dal mutare delle stagioni.
Il voltarsi indietro non ha assolutamente senso. E tanto meno un arrampicamento per ritrovare condizioni di sicurezza od almeno di una possibile ragionevolezza.
Quando si è posto mano alla pazzia, la razionalità più consigliabile è cercare di esser pazzi del tutto.
Può essere che solo allora possano sopravvivere e maturare le condizioni ottimali per la testimonianza. Perché può avvenire che l’amore… sia tutto nel restare!” (Sirio Politi).
QUATTRO GRANDI CONTENITORI
La memoria risulta importante per riscoprire le radici, per un riconoscimento reciproco, per il senso di un’identità nel tempo, per far emergere energie da spendere… ma la memoria può diventare la pietra tombale, il sigillo di una esperienza conclusa se non coglie il presente e si apre alla tensione del futuro.
La “nostra” memoria ci ha fatto cogliere il limite (limes) sia della nostra esperienza, come dei grandi sistemi un tempo creduti assoluti; ma ci ha fatto cogliere anche il limitare, la soglia (limen) e quindi l’entrare e l’abitare situazioni e problematiche che non sono esclusivamente dei PO ma appartengono alla condizione umana e sono vissute da tanti compagni e compagne di viaggio, credenti o meno.
La memoria è un percorso singolare, ma ora ci troviamo in un mare dove altri rivi sono confluiti con loro percorsi specifici. Il mare ci assorbe, ci rimesta, rende leggere le nostre identità per accomunarci nel destino comune. In definitiva era proprio questo ciò che volevamo fin dall’inizio.
1) la condizione operaia
Il salto del muro si è compiuto con la scelta di stare nella condizione operaia (la maggioranza come lavoratori dipendenti, alcuni nell’artigianato, altri nelle cooperative di autogestione). Questa scelta ha comportato uno stile di vita che da una parte ha rotto con la “casta clericale”, rimettendo in circolazione le nostre persone nell’armonia economica, culturale, affettiva, sociale… e dall’altra ha rotto con il “cristianesimo politico” italiano espresso dalla D.C. Abbiamo così assunto un diverso punto prospettico da cui guardare la realtà: lo “sguardo dal basso” di lavoratori inseriti nel processo di produzione determinante la vita personale, sociale e politica della gente. In questa situazione abbiamo colto i valori della C.O. e gli strumenti di una progettualità politica nella dimensione del “socialismo”.
Il quadro di riferimento della condizione operaia è cambiato per i fatti ben noti accaduti. Ci troviamo di fronte alla frantumazione, alla precarizzazione, alla riduzione al silenzio del soggetto operaio; i valori della C.O. sono dichiarati antistorici e perdenti, il progetto politico non supportabile da esperienze credibili, secondo il pensiero unico. In questo contesto le analisi risultano deboli e a volte confuse, l’organizzazione e la lotta domandano un supplemento di senso, tanto che alcuni prefigurano la fine della storia a fronte del venir meno di un serio antagonismo.
Però mai come oggi si è avuto un dibattito sugli appuntamenti di fine secolo, sul senso della politica, sulla posizione della sinistra, sul pensiero critico, sullo spazio del privato e del pubblico, sul senso di progetti vincenti o perdenti nella storia…
La dimensione politica resta il primo territorio da abitare con la gente.
2) la giustizia
L’incontrare il volto dell’altro, anzi, il grido dell’altro nelle situazioni di oppressione, ci ha interpellato sul dovere di dare una risposta a partire dall’intimo della nostra costituzione umana: la giustizia come rapporto giusto non solo tra umani, ma anche con l’ambiente e con le generazioni future.
La dimensione etica della vita ci ha fatto superare una prassi di carità storicamente vissuta dal mondo ecclesiastico come concessione dall’alto, o tappabuchi nei confronti delle falle di un’organizzazione sociale ed economica che crea apartheid e marginalità sociale.
Di fronte all’abbattimento dello stato sociale (non solo in Italia) ritornano parole come nuovo patto sociale, solidarietà, carità…, sia nell’ambito ecclesiastico che laico, con il forte rischio di riportare sul piano etico/spirituale ciò che è politico/dialettico.
L’intreccio tra giustizia, solidarietà, carità è sempre aperto, come del resto il rapporto tra autorealizzazione e giustizia, tra gratuità e obbligo dell’agire etico. La mondializzazione del sistema di produzione e di scambio supportato dalla tecnologia ci pone le complessità della questione giustizia oggi.
3) profezia/evangelizzazione; chiesa/mondo
Nella storia del cristianesimo si è vissuto e teorizzato il dualismo tra sacro e profano, tra spirituale e materiale, tra anima e corpo, tra clero e laici… Con l’egemonia del sacro nella storia (teoria delle due spade, del regime di cristianità, dell’unità politica dei cattolici, della dottrina sociale della chiesa).
I PO nella loro vita hanno rotto il dualismo e la separazione pagando degli alti prezzi. Si è avuto lo spostamento dalla centralità della chiesa e del sacro al senso del regno presente nella storia come misteriosa presenza / assenza.
In particolare è saltato per noi il ruolo del prete definito sociologicamente, poiché ci siamo posti in una dislocazione kenotica.
Il cristianesimo politico italiano a cui ci siamo fermamente opposti si è mostrato fallimentare con il crollo dalla D.C. Ora il mondo cattolico italiano si sente orfano di fronte al rapporto con la storia e la politica ed è in atto un tentativo di ricompattazione (grande centro, unità sui valori, assemblea di Palermo come luogo di confronto – ma per andare dove? – settimane sociali…).
Gli spazi liberati per la profezia e l’evangelizzazione mettono paura e molta incertezza. Sugli stessi ministeri è aperto il dibattito (Drewermann, Haring, Prezzi sul Regno; documento europeo di “Noi siamo chiesa”…).
Il Vangelo attraverso la testimonianza dei credenti diventa sale e lievito di una storia che viene salvata, ma resta il problema di come possa avvenire questo nel concreto delle situazioni (Romero, Bonhoeffer, M.L. King, E. Cardenal…).
I credenti e le chiese sono attraversati dalla doppia appartenenza e non esistono modelli unici di chiesa, di ministero, di rapporto con la storia, poiché nel “penultimo” non c’è nulla di imitabile: “passa la scena di questo mondo”; resta però il problema di come prendere sul serio questo mondo senza fughe.
4) fede non clericale
Abbiamo faticato non poco a liberare la fede da un contenitore clericale, legato alla violenza del sacro ed alla concezione strutturale di una “religione naturale”. Siamo stati segnati per anni da una tensione con la Chiesa. La parabola di frate Francesco che attraversa nella fede anche l’istituzione, scegliendo l’ultimo posto come frate minore, può aprire nuovi percorsi nel senso di perfetta letizia.
Anche il nostro parlare di Dio è cambiato; alcuni accentuano la “dislocazione dal basso”, in cui anche Dio si pone fuori dal tempio, mentre altri accentuano il percorso nella dimensione del filone “mistico” come superamento delle gabbie e mediazioni religiose.
Viviamo ora in un contesto di rivincita del religioso o del sacro non necessariamente nelle forme religiose ufficiali. Le religioni diventano contenitori troppo stretti per molte persone e scatta il senso “parziale” di appartenenza. Nel contesto però la ricerca di singoli e gruppi va nel segno della libertà di Gv.4,23 degli adoratori di Dio in spirito e verità; ma resta il nodo del rapporto tra autonomia ed eteronomia, il problema delle interpretazioni, del senso della religiosità popolare e dei rapporti o mediazioni con le forme istituzionali in cui si trovano anche parecchi di noi.
Questi sono quattro grandi contenitori (od aree di rifornimento?) a cui siamo giunti; il dibattito e la ricerca sono più grandi del nostro percorso, ma questo convegno può costituire un momento di confronto del collettivo dei PO per superare la memoria, sia pure preziosa, ed aprirci a nuovi cammini.
Luigi Forigo
