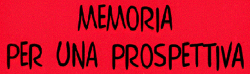
Convegno nazionale / Salsomaggiore 1996
terza relazione
Un tentativo di vocabolario per dire ciò che sta succedendo nel mondo:
– SFRUTTAMENTO
– ECONOMIA COME SOTTOSISTEMA
– DECLINO DELLA FORZA LAVORO GLOBALE
– TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
– TERZO SETTORE-POST MERCATO-ECONOMIA SOCIALE
INTRODUZIONE
Sembra un’impresa impossibile dire in poche parole ciò che sta succedendo nel mondo. Abbiamo tutti la sensazione che sia in corso un inarrestabile cambiamento che ci fa pensare che la vita, così come la conosciamo, venga modificata in molti suoi aspetti.
Sembra che una nuova dittatura, anonima e sottile, derivata da pensatori liberali fortemente ispirati dal culto della libertà, si stia imponendo: dittatura fra le più feroci, le più impietose, responsabile di milioni di persone stritolate sotto le ruote del “libero mercato”, elevato a divinità imparziale, oggettiva, implacabile.
Dovremo imparare a “Non aver pietà per nessuno “?
Dovremo assistere al trionfo del “Principio di indifferenza” ?
Dovremo, per chi ha vita, rimuovere sistematicamente e in massa, dal nostro cervello, le stragi e le loro cause? Oppure commuoverci e metterci il cuore in pace?
Si possono dire molte altre cose. Ma non si può dire che la situazione mondiale non stia cambiando. Nel mondo e in Italia. (cfr. Le due destre di Revelli).
Come poter dire alcune parole che non siano commoventi, ma siano moventi ed ordinanti il cervello?
Ho scelto SETTE PAROLE, fra le molte, sotto cui è possibile mettere dati, interpretazioni, correzioni, eccetera.
Non è – come si suol dire – una analisi della situazione.
Sono un tentativo di vocabolario, una cassettiera, per aiutarci in un linguaggio comune. Non ci sono collegamenti fra le parole. Chissà se sono le parole giuste per dire ciò che sta “succedendo” nel mondo…
Manca ciò che siamo soliti chiamare Opposizione.
Gli allegati ed il materiale a disposizione possono servire per completare. Il tutto può servire per collocare alcune discussioni.
1. GLOBALIZZAZIONE.
È sinonimo di mondializzazione. È mondializzazione o intern6azionalizzazione della produzione, distribuzione e consumo.
L’apparato produttivo del G7 è giunto a tutto il mondo mediante le imprese già ben conosciute in ambito mondiale, chiamate transnazionali. Di conseguenza, imprese e settori produttivi locali vengono fatti uscire dal mercato o assorbiti dalle transnazionali.
Al treno della globalizzazione si sono uniti i nuovi paesi industrializzati del sud est asiatico, perfino il paese più antimperialista ed anticapitalista: il VietNam. Le cause remote e prossime, le condizioni, gli obbiettivi di questo fenomeno, sono nominate, numerate, discusse, espresse in vari modi, in articoli, libri, convegni.
Per evitare le solite storie su Nord e Sud forse è utile leggere l’allegato che abbiamo preparato per tutti su Globalizzazione e Mediterraneo.
2. OLIGOPOLIZZAZIONE.
È terminato così il Libero Mercato. O perlomeno la cosiddetta economia di mercato si dà in realtà solo in settori o attività produttive di bassa rendita, di tecnologia blanda o arretrata e di produzione ridotta, considerando il mercato mondiale.
Il mercato oggi è oligopolico, cioè un mercato caratterizzato dall’esistenza, di fronte a un numero imprecisato di compratori, di un numero limitato di venditori di una merce, (cfr. Samir Amin sui cinque monopoli).
Le forme più complete di oligopolio sono precisamente le imprese transnazionali. Questo processo è possibile solo con il costante sviluppo della tecnologia, che si costituisce come il motore della espansione capitalistica oligopolica.
In cima a questa struttura incontriamo la Cupola Finanziaria, che con i suoi flussi di liquidità o non liquidità governa il mondo.
L’economia finisce di essere Oikos-Nomos e passa ad essere crematistica (io mi occupo degli affari finanziari), massimizzando il valore del cambio monetario nel breve periodo per il proprietario finanziario (cfr.finanziarizzazione = D – D + (Denaro-Denaro + ), non più: D – Merce – D + . Le contraddizioni che sorgono vengono esposte, discusse, in vari modi eccetera.
3. LO SFRUTTAMENTO.
La globalizzazione e la oligopolizzazione si reggono sul lavoro umano, produttore di valore. Il “valore” è l’essenza dell’attività economica, il cuore dell’“economia”. Capitale-lavoro è una dicotomia che sussiste e – nonostante tutto – aumenta come problema dialettico all’interno del sistema.
La proletarizzazione di grandi parti della popolazione mondiale (che prima erano settori indipendenti del ceto medio, artigiani indipendenti, contadini con terra), è stata la conseguenza diretta della globalizzazione e della oligopolizzazione della economia mondiale.
Nelle nazioni del G7 i salariati sono la maggioranza della popolazione economicamente attiva. Qui comandano i sindacati, perché possono paralizzare il sistema. Nel resto del pianeta la lotta tra capitale e lavoro può arrivare a situazioni esplosive. La povertà molto estesa in queste parti del mondo si basa in gran parte sullo sfruttamento così come lo descrissero gli economisti marxisti classici.
4. ECONOMIA COME SOTTOSISTEMA.
Per quello che concerne il presente ed il futuro la problematica principale non è la dialettica fra capitale e lavoro (problemi interni). No. Adesso si è scoperto che questo tipo di economia non ha futuro perché è un sottosistema antagonista al sistema che lo sostiene: il sistema naturale. I sistemi generali, che sono la realtà dell’esistenza, tanto in questo pianeta Terra come nell’Universo, non erano percepiti dal genere umano fino a poco tempo fa. Negli ultimi 25 anni di questo secolo si è scoperto che facciamo parte di un immenso sistema, che va dai batteri fino alle galassie: siamo parte di una totalità. L’economia è appena un sottosistema in una intricata rete di relazioni nel contesto dell’ordine naturale.
Questo già si conosceva scientificamente, ma se ne ignorava la sua grande importanza. Con questa “scoperta” si va prendendo coscienza che questo sottosistema economico è antagonista con il sistema naturale.
I dati qui abbondano.
5. DECLINO DELLA FORZA LAVORO GLOBALE.
“Ciò che un tempo era dominio dell’attività del lavoratore, diviene dominio della macchina” scriveva K. Marx nel primo volume del capitale (1867). Solamente che lui quasi poneva alla pari i due obbiettivi della sostituzione dei lavoratori con le macchine: “ridurre il costo del lavoro e guadagnare un maggior controllo sui mezzi di produzione”. La storia ci dice che fu il secondo obbiettivo quello che scatenò la terza rivoluzione industriale, la rivoluzione delle “macchine pensanti”. Tra il ‘45 ed il ‘55 negli USA si verificarono più di 43.000 scioperi… Interessante è questa descrizione:
I manager iniziavano a preoccuparsi per quella che consideravano una vera e propria invasione dei sindacati in un territorio che era sempre stato un loro dominio esclusivo. Le questioni di assunzione e licenziamento, delle promozioni, delle azioni disciplinari, dei benefici previdenziali e sanitari e della sicurezza vennero introdotte nel processo di contrattazione collettiva in tutti i settori. «Business Week» avvertiva che “è giunta l’ora di assumere una ferma posizione contro ulteriori intrusioni nel dominio del management”.
Minacciati dalla crescente intensità delle istanze dei lavoratori e ben determinati a mantenere il proprio controllo sui mezzi di produzione, i giganti dell’industria americana si rivolsero alle nuove tecnologie dell’automazione per liberarsi dei lavoratori ribelli e per accrescere la produttività e i profitti. La nuova strategia imprenditoriale ebbe successo. Nel 1961, una sottocommissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti pubblicò un’analisi statistica sull’impatto dell’automazione sul lavoro nel quinquennio precedente. La Steel Workers Union dichiarava una perdita di 95.000 iscritti, a fronte di un incremento di produttività del 21%; la United Auto Workers (UAW) affermava di aver perso 160.000 iscritti, messi fuori gioco dall’automazione; la International Union of Electricians (IUE) lamentava la perdita di 80.000 posti di lavoro nel settore elettrico, a fronte di un incremento di produttività del 20%. Tra il 1956 e il 1962, più di un milione e mezzo di americani impiegati nel settore manifatturiero persero il posto di lavoro.
La fabbrica senza operai, tanto sognata dai manager, si avvicinò ancora di un passo nei primi anni Sessanta, grazie all’introduzione del computer negli stabilimenti. Le macchine pensanti erano in grado di gestire una quantità di mansioni assai più grande di quella che avrebbe anche solo potuto essere immaginata da Del Harder, quando, dopo la guerra, concepì l’idea della prima divisione automazione alla Ford Motor Company. Il nuovo approccio all’automazione informatizzata veniva chiamato “controllo numerico” (N/C). Grazie al controllo numerico, le istruzioni su come un foglio di lamiera deve essere laminato, stampato, saldato, rivettato o verniciato sono immagazzinate nel programma del computer, che istruisce la macchina utensile su come realizzare un pezzo e i robot della linea sulla configurazione di montaggio. Il controllo numerico è stato definito “probabilmente lo sviluppo tecnologico più significativo da quando Henry Ford introdusse il concetto di catena di montaggio”. Dal punto di vista dei manager, il controllo numerico significava poter aumentare efficienza e produttività riducendo, allo stesso tempo, il bisogno di manodopera nelle fabbriche.
Tutte le competenze, le conoscenze e le esperienze che,fino a quel momento, costituivano il patrimonio intellettuale della classe lavoratrice vennero effettivamente trasferite su un nastro, consentendo il controllo a distanza del processo di produzione e diminuendo di molto il bisogno di supervisione e di controllo direttamente sul luogo di produzione. Con il controllo numerico, molte delle decisioni relative alla gestione delle fabbriche e ai processi produttivi passarono dalle mani dei lavoratori a quelle dei programmatori e del management, che sfruttò al massimo l’opportunità. Da quel momento in avanti si poteva esercitare un controllo più stretto su tutti gli aspetti della produzione, incluso il ritmo stesso. Gli uomini d’impresa, soprattutto nel settore manifatturiero, fremevano di entusiasmo per la nuova rivoluzione dell’automazione. Cox and Cox, una società di consulenza di direzione con sede a Chicago, pubblicò un rapporto sulle macchine utensili a controllo numerico nel quale affermava: “È giunta la rivoluzione del management dalla gestione degli uomini alla gestione delle macchine”. Alan A. Smith, della Arthur D. Little Inc. sintetizzò i sentimenti di tutti i suoi colleghi: poco dopo aver assistito alla prima dimostrazione del controllo numerico al MIT, scrisse a James McDonough – uno dei coordinatori del progetto – per esprimergli il suo entusiasmo, proclamando che la nuova generazione di utensili a controllo numerico assistiti da computer segnava “la nostra emancipazione dal lavoratore”.
Mentre l’automazione si diffondeva a macchia d’olio in tutto il Paese, i suoi effetti cominciavano a farsi sentire sui lavoratori e sulla società.
I dati sono differenziati, contrastanti tra loro. Ciascuno raccoglie i dati a modo suo. A livello mondiale non si sa se in verità l’occupazione globale sia diminuita. Penso a ciò che sta avvenendo in India o in Cina.
Poi ciascuno tira le conclusioni che sono favorevoli all’ipotesi che vuol dimostrare, verificare (cfr. Rivas).
Si tratta poi, anche in base all’esperienza personale, di dire i cambiamenti nella condizione di lavoro. Ed anche qui c’è una serie infinita di scritti…
6. LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.
La prima rivoluzione è segnata dalla combinazione del carbone con la macchina a vapore, con l’integrale condizionamento della vita economica da parte delle macchine… La seconda, che ebbe luogo tra il 1860 e la prima guerra mondiale: petrolio, elettricità, invenzione di nuove macchine… La terza iniziò a prendere forma dopo la seconda guerra mondiale, ma solo ora sta iniziando ad avere un impatto significativo sul modo con cui vengono organizzate le attività economiche dominanti. Macchine automatiche a controllo numerico, computer avanzati e programmi sofisticati stanno invadendo anche quella che è rimasta l’ultima sfera di esclusiva competenza umana: il dominio della mente.
Alcuni considerano questo evento in termini mitologici, come terzo grande evento nella storia dell’universo: “Il primo evento è la creazione dell’universo. Il secondo la comparsa della vita. Il terzo è la comparsa dell’intelligenza artificiale”.
Leggere l’elenco di queste macchine applicate all’industria, ai servizi di ogni tipo, e soprattutto all’agricoltura (dai Romper dei kibbutz all’agricoltura molecolare, sino alla fine dell’agricoltura all’aperto) fa perlomeno meravigliare.
Alcuni prevedono la fine del lavoro umano…
Norman Weiber, padre della cibernetica, scrive: “Se questi cambiamenti nella domanda di lavoro ci si presenteranno in maniera casuale e disorganizzata, potremmo precipitare nella più tragica epoca di disoccupazione che ci sia mai stato dato di vedere” (1984). Già nel 1949 prevedeva che “nelle mani dell’attuale organizzazione industriale, la disoccupazione prodotta da tali impianti produttivi può essere disastrosa”.
Altri invece prevedono l’effetto “a cascata” con nuova Terra da paradiso… Altri dicono che il surplus aumentato debba essere devoluto a quello che chiamano terzo settore.
7. TERZO SETTORE – POST MERCATO – ECONOMIA SOCIALE.
È difficile sintetizzare il modo con cui pongono questo problema. Riproduco qui un brano che mi sembra sintetizzare un modo di presentare questo fenomeno, ora che la “vendita della forza lavoro” e il ruolo dei governi centrali come garante dei mercati stanno perdendo certezza ed importanza.
Nei prossimi decenni, il ridimensionato ruolo del mercato e del settore pubblico finirà per condizionare la vita dei lavoratori in due modi. Chi conserverà un posto di lavoro vedrà probabilmente abbreviata la settimana lavorativa e disporrà di maggiore tempo libero; molti di loro saranno probabilmente spinti dalle forze del mercato a dedicare il proprio tempo libero al consumo e al divertimento. Il crescente numero di disoccupati e sottoccupati, al contrario, si ritroverà sempre più affondato nel sotto proletariato; molti di loro, ridotti alla disperazione, per sopravvivere si volgeranno all’economia non strutturata, barattando lavoro occasionale in cambio di cibo e alloggio, altri si dedicheranno al furto e alla piccola criminalità; droga e prostituzione continueranno a crescere dal momento che milioni di esseri umani – abili di corpo e di mente ma rifiutati da una società che non ha più bisogno del loro lavoro – dovranno trovare un modo per sbarcare il lunario; le loro richieste di aiuto saranno in larghissima parte ignorate da uno Stato che stringerà sempre più i cordoni della borsa e che sposterà le priorità di spesa dal benessere collettivo e dalla creazione di occupazione al rafforzamento delle forze di polizia e alla costruzione di nuove prigioni.
Ma il baratro verso il quale si stanno dirigendo molte nazioni industrializzate non è in alcun modo inevitabile. È disponibile un’alternativa: una scelta che può aiutare ad ammortizzare i colpi sempre più aspri inferti alla società dai Moloch tecnologici. Con gli occupati che dispongono di più tempo libero e i disoccupati che hanno tutto il tempo, esiste la possibilità di sfruttare il lavoro inutilizzato di milioni di persone, indirizzandolo verso funzioni produttive al di fuori dei settori privato e pubblico. Talenti ed energie di occupati e disoccupati – di chi ha tempo libero e di chi ha tutto il tempo – possono essere efficacemente diretti verso la ricostruzione di migliaia di comunità locali e la creazione di una terza forza.
Nel terzo settore, altrimenti noto come indipendente o volontario, l’accordo fiduciario cede il passo ai legami comunitari, e la cessione volontaria del proprio tempo prende il posto delle relazioni di mercato imposte artificialmente e fondate sulla vendita di se stessi e dei propri servizi agli altri.
La possibilità di far risorgere e trasformare il terzo settore in un veicolo per la creazione di un’era post-mercato densa di fermenti deve essere seriamente presa in considerazione.
Il terzo settore già occupa un’ampia porzione della vita sociale. Le attività di volontariato spaziano dai servizi sociali all’assistenza sanitaria, dall’istruzione alla ricerca, alle arti, alla religione, alla difesa legale. Le organizzazioni di servizi di volontariato assistono i vecchi e gli handicappati, i malati di mente, la gioventù disadattata, i senzatetto e gli indigenti. Volontari ristrutturano case diroccate e contribuiscono alla nuova costruzione di abitazioni popolari; decine di migliaia di americani prestano servizio volontario in strutture ospedaliere pubbliche e private, prendendosi cura dei pazienti, tra i quali i malati di Aids; migliaia di altri fungono da genitori surrogati, da fratelli e da sorelle per gli orfani, assistono i ragazzi fuggiti di casa e quelli che hanno problemi; altri ancora vengono impiegati come insegnanti nelle campagne per eliminare l’analfabetismo, nei programmi di sostegno scolastico, nei centri di assistenza sociale; un numero sempre più alto di cittadini dedica volontariamente il proprio tempo ai centri di assistenza, aiutando le vittime di stupri e di violenze in ambito familiare; migliaia sono i volontari che operano nei centri di raccolta e nella distribuzione di cibo e generi di prima necessità ai bisognosi.
Molti americani sono coinvolti in programmi di riabilitazione degli alcolisti e dei tossicodipendenti; i professionisti donano i propri servizi – legali, contabili, medici, organizzativi – ad associazioni di volontariato; a milioni si offrono per iniziative ambientaliste, campagne antinquinamento, o per la protezione degli animali; moltissime sono le associazioni per la difesa del cittadino e dei suoi diritti, che si impegnano – grazie al lavoro volontario – per modificare situazioni giuridiche o culturali inique.
PER INTRODURCI ALLA DISCUSSIONE
aggiungo tre punti finali:
1. Queste sette parole sono solo una cassettiera vuota. Sono sembrate utili per raccogliere in modo ordinato i dati che ciascuno conosce o che vuole ricercare.
2. Sono sette parole che tentano di dire qualcosa del “sistema”. Mancano i dati sull’opposizione. Dicendo questo, forse appare anche un giudizio sulla settima parola. Ci sono dati di resistenza, opposizione, mobilitazione che evidenziano la necessaria mobilitazione attiva contro… Ma questo sarà il terzo tema del convegno.
3. È stato scelto un modo freddo, anche se non neutrale, di presentare la situazione attuale del pianeta. A ciascuno il risvegliare le sue coscienze, il dire i soggetti e non solo gli oggetti delle varie parole. Il pericolo è spostare l’attenzione dalla ricerca delle cause alla constatazione degli effetti, segnando così in maniera netta il passaggio dalla politica alla morale, dalla responsabilità alla colpevolizzazione. Non esistono più fautori o profittatori di un sistema che consente, incrementa, secerne l’esclusione, ma soltanto spettatori, testimoni, che dall’esclusione sono «interpellati» (termine di connotazione intensamente cristiana), ai quali si chiede soltanto di uscire dalla loro indifferenza.
Nel suo significato originario, attivo, l’esclusione potrebbe avere altri nomi: segregazione, servitù, sfruttamento. Ma ormai, trasformata in participio passato passivo, è protetta da qualsiasi investigazione a monte, sulla realtà dei rapporti di potere e di produzione. A questo punto, l’«esclusione» sociale non è più argomento di riflessione politica, ma il tema di seminari cattolici o psicoanalitici.
Dobbiamo avere il coraggio di diffidare della compassione, colpevole alibi della nostra indifferenza politica. Che la pseudo-compassione morale ceda di nuovo il passo all’analisi e alla lotta politica, e che di nuovo l’uno si divida in due! La compassione non porta all’azione, ma al contrario le ostruisce la strada. Perché l’azione non chiede lacrime ma risoluzione, non vuole che si soffra davanti all’ingiustizia ma che si sia decisi a sopprimerla.
Cesare Sommariva
