ex-
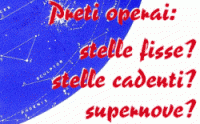
a cura dei PO del Veneto
CI SONO QUELLI CHE LEGGONO
LA BIBBIA PER TROVARE L’INDIRIZZO
DI UN BUON ALBERGO IN PALESTINA
(L. Longanesi)
NUOVA EVANGELIZZAZIONE:
DAL DIN-DON AL BIP-BIP
«Il bambino arriva fra i caldei e si accorge che ha dimenticato le tavole della legge. Allora comincia a cliccare e ritorna nel tempio di Gerusalemme, per recuperarle». Detto così sembra un’avventura di Indiana Jones, invece è il cd rom sulla dottrina cristiana che il teologo Franco Calzona sta progettando per spiegare ai bambini la storia sacra. Non un semplice ipertesto, ma un vero videogioco, che trasforma in una sfida didattica anche il peccato originale e i Vangeli di Gesù.
Non è l’unica sorpresa telematica che la Chiesa riserva alla convention mondiale della Apple, quattrocento partecipanti da 32 paesi: se è vero che in una parrocchia spopolata del Galles il sacerdote è stato sostituito da un computer in grado di distribuire sermoni e penitenze ai pochi fedeli, esiste anche il progetto di un «Istituto di teologia a distanza» che non dispiace all’Opus Dei. Si tratta di corsi in filosofia, diritto canonico e teologia organizzati «in rete» dal Pontificio ateneo romano della Santa Croce, università cattolica in grado di formare centinaia di professori di religione in tutto il mondo, dall’Italia all’India, dal Canada ai Paesi musulmani. Ognuno di loro potrà insegnare religione nelle scuole ma soprattutto (e sono la maggior parte, assicurano i responsabili dell’iniziativa) persone qualsiasi come ingegneri, medici e avvocati «potranno soddisfare il desiderio di dare motivazioni razionali alla propria fede».
Il computer sugli altari, dunque, non solo negli uffici o sul pullman ipertecnologico dei Chicago Bulls, che studiano scrupolosamente ogni traiettoria dei rimbalzi avversari. Mentre la Cei organizza una rete telematica di tutte le parrocchie, spiega don Calzona, e la Mondadori sta per presentare a Francoforte un cd rom sul Santo Padre, a Roma si sta per avviare la prima università di giornalismo ecclesiastico: presto avremo un ufficio stampa in ogni Diocesi, non solo in quelle più grandi come quella del cardinal Martini a Milano. Tutte collegate tra loro in tempo reale».
(dai giornali del 3 ottobre 1996)
NON BASTAVA LA PREGHIERA?
Mancanza di fede, nell’ortodossia totalitaria della Chiesa. Chiunque chiede del pane a Dio non riceverà delle pietre. Se a colui che desidera la verità appare un errore, questo è per lui una tappa verso la verità, e se continua lo vedrà come un errore. Colui che non desidera la verità s’inganna, ma s’inganna anche recitando il credo. La condanna degli errori era cosa buona; ma non «anathema sit».
In quale modo si può stabilire che un certo, errore non sia necessario per un certo spirito in quanto tappa? Sarebbe stato sufficiente dire: Chiunque dice che… non è giunto alla verità. Proteggere i piccoli? Non bastava la preghiera?
Dio e il soprannaturale sono nascosti e senza forma nell’universo. È bene che siano nascosti e senza nome nell’anima. Altrimenti si rischia di assumere sotto questo nome qualcosa d’immaginario. (Quelli che hanno nutrito, vestito, ecc., il Cristo non sapevano che era il Cristo).
Senso dei misteri antichi, il cristianesimo (cattolici e protestanti in egual misura) parla troppo di cose sante.
(Simone Weil, Quaderni, vol. II)
”MERCANTÌE, MERCANTÌE…”
È di ieri la notizia che dal 20 marzo saranno in vendita i compact disc e le musicassette, editi dalla Emi, con il Santo Rosario recitato dal papa. L’album, che ha già vinto il disco di platino in Spagna per avere venduto più di 150.000 copie, contiene appunto i quindici misTeri del Rosario (cinque di gaudio, cinque di dolore e cinque di gloria, per chi non ricordasse il catechismo) e la recita finale in latino del Salve Regina.
(dai giornali del 18 febbraio ’95)
«Et vui altri preti et frati, anchora vui volete saper più de Dio, et sette come il demonio, et volete farvi dei in terra, et saper come Iddio a guisa del demonio: et chi più pensa di saper, manco sa». E abbandonando ogni ritegno, ogni prudenza, Menocchio dichiarò di rifiutare tutti i sacramenti, compreso il battesimo, come invenzioni degli uomini, «mercantìe», strumenti di sfruttamento e di oppressione da parte del clero: «credo che la legge et commandamenti della Chiesa siano tutte mercantìe, et si viva sopra di questo».
Del battesimo disse: «credo che subito nati siamo batteggiati, perché Iddio ci bateza che ha benedetto ogni cosa; et quel battezar è un’inventione, et li preti comenzano a magnar le anime avanti che si nasca, et le magnano continuamente sino doppo morte». Della cresima: «credo sia una mercantìa, invention delli homini, quali tutti hanno il Spirito santo, et cercan di saper et non sano niente».
Del matrimonio: «non l’ha fatto Iddio, ma l’hanno fatto li homini; prima l’homo et la donna si davan la fede, et questo bastava; et doppo son venute queste invention dalli homini». Dell’ordine: «credo che il spirito de Dio sia in tutti, …et credo che ognuno che havesse studiato potesse esser sacerdote, senza esser sacrato, perché sono tutte mercantìe». Dell’estrema unzione: «credo che sia niente et non vaglia niente, perché si onge il corpo et il spirito non si può ongere».
Della confessione era solito dire: «andare a confessar da preti et frati tanto è che andar da un arboro».
Dagli interrogatori al processo per eresia del mugnaio Menocchio,
bruciato in Friuli verso l’anno 1600
(C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi, ed. Einaudi)
Mediazione cristiana ed esperienza dei PO
Premessa / L’ateismo dei sacrestani
Il titolo di questa sezione non è enigmatico. Il libro dell’Esodo parla insieme di un tempio che si deve fare (cap. 25), di un vitello d’oro che non si deve fare (cap. 32) e di una Divinità che appare fuggendo (cap. 33, fine). Cosa c’entra questo con i PO?
I PO veneti nell’autunno del ‘95 proponevano per loro e per altri gruppi tre schemi di riflessione su tre temi che erano e sono centrali non solo per questa limitata esperienza, ma anche per una più vasta condizione cristiana e umana. Non erano e non sono né “religiosi”, né “politici”. I problemi così separati, non esistono se non in vedute illusorie. Sono temi-incrocio, come incrocio è la vita e come ricerca di incroci umani è l’esperienza dei PO. Dei tre temi (pubblicati nei materiali per il convegno di Salsomaggiore ‘95) il primo era relativo agli interessi privati che le varie classi dirigenti (anche nella Chiesa) curano a spese del bene pubblico, il secondo era relativo al problema ‘Dio’ visto come cosa da esibire in tv, nei giubilei ecc. o nel suo ritirarsi nel silenzio della sofferenza e nella ingiustizia.
Il terzo (quello scelto poi dal gruppo veneto e di cui qui c’è la relazione degli incontri avvenuti su di esso) riguarda il problema ‘istituzione’ nella Chiesa. Molta parte della storia dei PO si svolge attorno a queste domande. Anche le divisioni tra noi sono qui, tra chi vede nel ‘lavoro’ un aggiornamento del ruolo, chi la sua necessaria distruzione, chi l’immissione nel ruolo di forze di novità.
Una visione più fredda di queste vicende indicherebbe che tutte le letture erano legittime. Il compito indicato dall’Esodo (fare templi, non vitelli d’oro, adorare un Dio che è presente-assente) era superiore a forze umane, chissà. I PO, tutti, hanno dato un qualche contributo. Certo rimane intatto il compito oggi. Uscire dal falso dilemma che pone non la Chiesa, ma questa classe dirigente nella chiesa.
Secondo una sconcia ovvietà il credente dovrebbe scegliere tra l’immediatezza del Divino e la mediazione. Questo porta al cristiano tipico italiano, ateo e bigotto insieme, a seconda dell’opportunismo. Dall’Esodo invece e da Matteo al cap. 4, ci viene l’opzione per la vera scelta: scegliere tra mediazione e idolatria.
Attenzione però. Fenomeni profondi e potenti sembrano rendere vuote anche queste antiche categorie, togliendo ai PO anche il loro posticino da ‘profeti’. Tutte infatti le prospettive cristiane, dall’alto al basso, sembrano travolte da una miscela nella quale trionfalismo e presenzialismo della religione nei media e nell’economia (giubileo ecc.) si combinano con una altrettanto vincente disobbedienza e indifferenza di tutti. Onnipresenza e insignificanza del cristianesimo coincidono.
Quello che è stato chiamato da Gargani ‘l’ateismo dei sacrestani’ mostra una forza molto maggiore e sofisticata del buon vecchio e conosciuto ‘ateismo dei bestemmiatori’…
Channa, che era stato schiavo nella casa di Suddhodana, il padre del futuro Buddha, si unì come novizio all’Ordine, ma non riuscì a procedere nella Via proprio a cagione del suo orgoglio per il Maestro, già suo padroncino, per cui sempre discorreva del «nostro Buddha», della «nostra Legge».
Dopo la morte del Buddha, cacciato dall’Ordine come postuma punizione inflittagli dal Maestro stesso, spinto dall’angoscia, riuscì ad estirpare la sua egoistica affezione; quindi con un ulteriore sforzo conseguì la condizione di Arhat, di cui espresse la beatitudine con la strofa:
«Avendo udito il Dharma dalla virtù possente di quel Grande,
Insegnato da Colui che tutto conobbe,
Giunsi alla Via onde immortalità si consegue:
Ben dotto egli è, per guidare alla salvezza da ogni legame!».
(dal Theragatha, in Canone buddista, ed. Utet)
INTRODUZIONE ALL’INCONTRO
Le due realtà di PO e parroco, sembrano esprimere la tipica inconciliabilità della loro stessa origine: l’una in alternativa all’altra. Proporle insieme oggi può comportare una elaborazione inutile o perlomeno artificiosa, in quanto che si può pensare che l’una delle due debba scomparire a favore dell’altra.
In effetti non è facile la convivenza di queste due “anime”, almeno in chi, come me, sente fortemente il richiamo di ambedue. E non è facile fare in modo che non ci sia pura e semplice giustapposizione fra di esse, come fossero ambiti separati che occupano momenti diversi della vita.
Io parto dalla convinzione che ci sia un elemento di base che le sostiene ambedue e che riesce ad accomunarle, è l’elemento più ovvio: cioè la mia specifica identità di battezzato e insieme di prete.
Se quindi nella storia è prevalsa la figura di parroco a qualificare il servizio proprio dell’identità sacerdotale, le aperture emerse dal Concilio, hanno dato la possibilità di considerare altre strade nell’espressione di tale servizio.
Tornando all’idea delle due anime, non posso non dire che è sempre presente in me l’esigenza di una mediazione. Si tratta cioè di “dare ragione” del proprio vissuto, facendo chiarezza progressivamente della fede, e si tratta anche di cercare assieme agli altri credenti le radici profonde di questa fede.
La mediazione: una parola che ho imparato a comprendere nella sua accezione anche positiva. Non intesa perciò solo come compromesso, bensì come incarnazione, e necessaria modalità di comunicazione.
In fondo il Cristo stesso è passato attraverso delle mediazioni “necessarie”:
la sua umanità, il tempo, la cultura, ecc. Egli visse tra la Legge e la Profezia, tra il Tempio e la strada, crescendo e facendo crescere in sapienza e grazia davanti agli uomini e a Dio. Ma visse anche la tentazione di mediazioni diaboliche, capaci di impedirgli il passaggio, la Pasqua. In Matteo 4 troviamo descritta la lotta di Gesù contro il tentatore che gli diceva: “Ti servono la mediazione del potere, del denaro, della religione”.
Ora, nel vivere queste realtà di prete operaio e di parroco, nel rapportarmi con le persone, sento in qualche modo necessarie alcune mediazioni.
1. Tra l’agire politico e quello religioso
Sento che c’è ancora una forte pressione, da parte di molti, perché io come parroco mi esprima a favore di un determinato versante politico che, se anche non più segnato da un simbolo di partito, esprime però la stessa cultura di prima: una cultura dentro la quale si mantiene e si alimenta una presenza forte della Chiesa.
In questo contesto ritengo giusto affermare che non ci deve essere un ruolo specifico del prete, ma solo un modo di essere, proprio di ogni battezzato che si mette in gioco come persona, per quello che crede e che sa fare. E così, a partire da questa convinzione c’è un lavoro lungo e lento di mediazione, di cambiamento di mentalità, in modo da far emergere l’idea che non ci deve essere un agire nel politico a partire dal “religioso” (“in quanto parroco, dico che…”) ma solo un agire umano e cristiano che si possono illuminare e intersecare a vicenda. È importante allora essere compagni di strada con chiunque voglia trovare modelli nuovi di vita sociale e voglia prendere sul serio quel “partire dai poveri”, che è stato l’àmbito privilegiato di Gesù.
2. Altra mediazione: tra Dottrina e Catechesi
L’essere PO toglie la fisionomia dell’essere portavoce ufficiale della chiesa, cioè uno che conosce e parla per princìpi e per categorie; uno che, se anche dimostra comprensione umana, non può poi transigere dalla sua autorità. Nell’ambito del lavoro esprimo solo la mia testimonianza e le mie convinzioni; nell’ambito della parrocchia esprimo il bisogno, che poi è di molti, di una ricerca comune, di un rendere comprensibile ciò che è già stato definito; di una riscoperta della Parola, possibilmente liberandola da formule, da dogmi e da moralismi.
Allora diventa necessario il passaggio, cioè la mediazione. Per tanti ancora, la Dottrina sicura è una garanzia di fede, ma per tanti è anche un peso e un motivo di angoscia. Per i più, soprattutto nella fascia giovanile è solo oggetto d’altri tempi, superato e inaccettabile. Ecco perché la figura di PO può rendere accostabile, nell’ambito della parrocchia, il nuovo della Parola, e poi il nuovo della Celebrazione del Sacramento, e di conseguenza anche il nuovo di una presenza propositiva nella vita.
3. Un’ultima mediazione: fra la Magìa e il Sacramento
È fatica quotidiana quella che bisogna affrontare per capire bene la distinzione fra riti e formule magiche e celebrazioni sacramentali. Ci si trova spesso, nell’ambito della Parrocchia, a dover accettare la confusione e la commistione tra questi due elementi, così radicati nella cultura della gente. La Chiesa stessa, se in certi momenti si mostra severa ed esigente (vedi la morale sessuale), in altri lascia vivere forme religiose del tutto equivoche (vedi Patroni, pellegrinaggi, santuari, ecc.). Ritengo che il PO, libero da quell’immagine sacrale che lo farebbe rientrare nell’equivoco, possa essere un’occasione per andare a comprendere il Sacramento.
È chiaro che, se la gente chiede benedizioni portafortuna, se chiede momenti e luoghi e figure sacre, se accetta la religione solo perché ne coglie i vantaggi nel contesto sociale, se dice che un Dio ci vuole (considerandolo come un tappabuchi delle loro impotenze), tutto questo non è colpa della gente.
Allora credo che sia giusto partire da lì, da quelle radici istintivamente e inconsapevolmente magiche, per poi fare un percorso di purificazione e di evangelizzazione, un percorso graduale alla scoperta dei significati, nella speranza che i linguaggi dello Spirito ritornino ad essere comprensibili.
Lidio Foffano
PO e parroco
RIFLESSIONI DI GRUPPO
Mediazione pretestuosa?
Gérard, osservatore attento dell’esperienza dei PO veneti, intervenendo ad un nostro incontro paragonava la tensione dei PO al matrimonio dove due differenze cercano di incontrarsi senza annullarsi, accettando le contraddizioni. Per noi le differenze sono costituite dalla laicità della vita e della storia da coniugare con la fede espressa anche nell’esser prete di una Chiesa particolare. Si è preso questa finestra per tentare una ricerca sulle mediazioni religiose storiche e, per noi, possibili, che coinvolgono la nostra esperienza.
Il termine mediazione, riferita all’Evento, suscita subito una reazione negativa; sembra il segno di qualcosa di poco pulito, di torbido, confusionale, molto ricattabile, debole e quindi strumentalizzabile. L’ideale sembra essere la purezza della divinità, la trascendenza indicibile e misteriosa non toccata dalla vanità della creazione.
Appena però si cerca di dire qualcosa del Mistero, ecco sorgere la necessità di parole, segni, riti resi necessari per un’auto-comprensione e per la comunicazione. La storia ci dice che subito qualcuno se ne impossessa per costruire ortodossie ed ortoprassi, caricandosi di autorità e stabilendo parametri di identificazione e di relazione sociale.
Si entra in relazione con l’Evento solo attraverso la nostra umanità poiché “Dio non l’ha mai visto nessuno” (1 Gv. 4,12). Possiamo anche dire che noi lo facciamo a nostra immagine e somiglianza (A. Levi: Le due fedi) e d’altra parte, per il credente, Lui è passato per la nostra umanità limitata dal tempo, dalla cultura, dall’economia, dalla politica… L’incarnazione del Verbo nell’uomo Gesù esprime la costrizione e la necessità per poter esprimere qualcosa del Volto e, nello stesso tempo, il volto diventa ambiguo: “Ha bestemmiato, perché da uomo, si è fatto Figlio di Dio”. La mediazione, l’ibrido è debole ed il Crocefisso esprime questa situazione.
La debolezza della croce rimane scandalo anche per la Chiesa, l’accompagna lungo la sua storia. Storicamente è continuamente in atto il tentativo di stravolgere l’incarnazione per affermare la presenza di Dio come potere sacro dominante gli altri poteri politici (cristianesimo occidentale) o come benedizione del potere laico, figura della presenza di Dio nella storia (cristianesimo orientale).
La mediazione espressa dal Cattolicesimo si esprime nella presenza e nel progetto politico di cristianità, lasciando in ombra e guardando con sospetto il filone mistico (inquisizione e Santo Ufficio…) dove i segni diventano solo strumenti di comunicazione e vuoti di potere. La linea non sembra cambiata anche oggi: il Papa va all’ONU, incontra capi di Stato, i Nunzi controllano le chiese, i Vescovi richiamano a linee politiche, i preti sono diventati operatori sociali con grande confusione di ambiti.
Il popolo risponde centrifugando il tutto e scegliendo le singole parti che aggradano a ciascuno in un bricolage su misura, lasciando però da parte la necessaria dimensione della politica e la tensione mistica personale. La mediazione è ridotta a supermercato del sacro dove ognuno compera e consuma quello che gli serve. Il 56,5% degli Italiani possono riconoscersi in questa situazione o come praticanti saltuari (38%) o come cristiani critici e distaccati (18,5%) (Garelli: Forza della religione e debolezza della fede)
Da una cultura vincente a una cultura rivelante
Il tempo, gli anni di PO mostrano differenze nette nella vita. Prima il sacerdozio era lo scopo assoluto: preghiera, studio, incontri, economia, riposo, celibato ecc., tutto era per quello, il sacerdozio. Era come una massa che assorbiva tutto, sia il prendere che il dare, cioè il prete come ‘padre’. Questo era anche il senso comune.
Più tardi nascono i perché. Questo finalizzare tutto a questo, questo creder solo in questo, lo fa un dio al quale tutto sacrificare. È un oggetto, come Dio è un oggetto. Il ‘prete’ si delinea come un assoluto e questa assolutezza riguarda i vari gradini, fino al Papa. Questa assolutezza di un ambito come il sacerdozio, rivela insieme che è uno dei tanti ambiti che si pensano assoluti.
Anche la coscienza con la quale agisce il prete, si rivela come la necessaria utile scienza che devono avere tutte le professioni. Ma qual’è allora la coscienza e la fede proprie del prete? E la sua cultura quale dovrebbe essere? Il sacerdozio come cultura è stato e ancora vorrebbe essere la cultura vincente. Lui vorrebbe essere la cultura che fa l’unità dei vari ambiti sia all’interno del prete che nei vari ambiti della vita. Ma come potrebbe farlo se esso stesso è uno dei tanti ambiti? Dovrebbe acquisire una cultura rivelante, che andasse oltre l’utile del suo ambito. Come fare? Molte categorie vanno trasformate. Quando il sacerdozio era potere su e per gli altri, peccato era un distrarre soldi e affetti da esso. Ma ora lo stesso sacerdozio è interrogato da una coscienza diversa. La stessa conversione una volta veniva da una causa, il prete, la Chiesa. Ora la conversione avviene nella confusione di molti eventi complessi, poco controllabili.
Cattolicità: uso privato di bene pubblico!
Dalla presenza di un cristianesimo politico derivano ambiguità, confusioni e sovrapposizioni. Gli spazi pubblici sono diventati privati. La chiesa con la sua struttura (soprattutto le parrocchie) crea un mondo sociale alternativo a quello della polis. Scuole, telecomunicazioni, volontariato, anspi, consultori… tutti insigniti dell’aggettivo cattolico, diventano un mondo separato, se non in competizione allo spazio di tutti i cittadini che dovrebbe esser garantito dalla politica. Il sale si sostituisce al cibo ed il lievito alla pasta. La scelta religiosa della chiesa è ancora un terreno da scoprire.
Ma una parrocchia può esser diversa? E cosa diventerebbe se fosse solo uno spazio per un cammino spirituale? In fondo, il 65,5% dei cattolici italiani, di cui sopra, hanno come punto di riferimento un cristianesimo sociale, cioè utile.
La conoscenza salvifica della fede si tramuta in coscienza utilitaristica; tutto diventa funzionale al vivere sociale. I PO parroci sentono questo invischiamento, ma come uscirne? L’Evento non diventa solo un pretesto nella mediazione della chiesa?
Il passaggio dal pubblico al privato è favorito anche dalla situazione generale di crisi. Un tempo tra il singolo o la famiglia e lo spazio collettivo c’erano delle organizzazioni intermedie: sindacati, cellule di fabbrica, organizzazioni di quartiere, della scuola… ora, il cambiamento della struttura economica e la massiccia presenza della telematica sembrano aver ridotto gli spazi; ognuno si sente desautorato (non conta più nulla). La chiesa italiana, in questo contesto, avendo ancora una radice popolare, diventa spazio alternativo di dimensione privata. Confortata, poi, dal seguito dei mass/media diventa spettacolare: è il Woitilismo non necessariamente del solo Papa, e pur proclamando messaggi sensati, quanto risulta funzionale al pensiero unico che sta coinvolgendo cristiani, laici ed ex marxisti?
I contemplativi, di fronte a questa riduzione della fede, hanno qualcosa da dire? Il convegno della chiesa italiana fatto a Palermo aveva come unica tematica lo spessore sociale della fede per una nuova socialità!
Gli stessi PO che hanno tentato di impegnarsi attraverso organismi di volontariato in spazi laici, si sentono ora fagocitati dal peso sociale della chiesa attraverso le sue organizzazioni (Charitas…).
Di fronte alla crisi dello stato sociale che crea nuove fasce di bisogni è possibile recuperare lo spazio pubblico con la partecipazione delle organizzazioni popolari che non vogliano occupare spazi privati e superare lo stato sociale di impostazione statalista come si è avuto finora?
Volontariato: salvezza od affossamento della politica?
Il volontariato è certamente un polmone per la società italiana; sembra una forza controcorrente di fronte alle tendenze in atto prodotte dalla trasformazione capitalistica, ponendo al centro il solidarismo. Si impone all’attenzione dei mass/media, dei politici e della chiesa stessa, habitat privilegiato di molti gruppi di volontari. Il fenomeno è rilevante e risponde ad attese sociali ambivalenti ed a volte contraddittorie. Si calcola che il 14% degli italiani siano in qualche modo impegnati nelle varie forme di servizio gratuito, di cui l’8% a servizio dei bisogni sociali e coinvolge circa quattro milioni di persone in diecimila organismi.
Sembra un atto riparatorio di fronte al venir meno delle alternative sociali e politiche. Restano però gli interrogativi di come relazionarsi da una parte di fronte alle (nuove) domande dei cittadini ed alle strutture che uno stato moderno è in grado di porre; e, dall’altra, della partecipazione dei cittadini organizzati in associazioni, al benessere dei singoli e della collettività.
Certamente il volontariato, essendo più snello, coglie le domande immediate nelle pieghe della società, i limiti delle risposte istituzionali; è flessibile ed immediato, può sperimentare soluzioni, contiene una forte carica umana di rapporto, simpatia e coinvolgimento.
Altro vantaggio del volontariato risulta dall’omogeneità degli operatori che si sono scelti ed agiscono in una dimensione condivisa.
Non è da dimenticare la forza culturale di proposizione e sensibilizzazione sociale di fronte al bisogno ed in vista di uno stile di vita e di rapporti.
E da ultimo, è da ricordare il costo relativamente basso dei servizi resi proprio per l’impegno gratuito di gran parte degli aderenti alle rispettive organizzazioni.
Il volontariato è un segno di speranza o è la constatazione di una sconfitta della società italiana? Il nostro paese non è all’altezza di uno stato moderno non per le domande emergenti, quanto per le risposte che non è in grado di offrire.
Siamo un popolo che ha leggi molto qualificate, ma con una scarsa coscienza civica ed una bassa partecipazione popolare alla vita pubblica e quindi, come conseguenza, con delle istituzioni non in grado di funzionare.
La contraddizione tra un forte volontariato ed un debole senso civico, è una caratteristica del “genio” italico o è anche una conseguenza (tra altre cause) di un certo tipo di presenza politica che la chiesa ha nella storia italiana? Pensiamo al risorgimento, al “non expedit”, alla contrapposizione tra stato e chiesa, al protettorato sulla politica posto attraverso il partito cattolico…, e nello stesso tempo la forte presenza sociale dei cattolici. In questo contesto il volontariato risulta ambiguo, perché da una parte si pone come supplenza alla debolezza istituzionale, ma dall’altra non è in grado di cambiare i rapporti data la sua matrice storico-culturale. Risulta che il 66% dei volontari intervistati (Inchiesta dell’Università Cattolica) si dichiara praticante al di là dell’appartenenza ad associazioni laiche o religiose.
Quanto allora il volontariato risulta risorsa o fuga dalle responsabilità nella ricerca di soluzioni necessariamente politiche? quanto il volontariato contribuisce al mantenimento dello status quo? e quante energie, alla fine, vengono stornate dalla rappresentanza politico-istituzionale?
La fame della madre non fa crescere i figli
Progressivamente nella chiesa si é ritornati al dualismo e alla divisione tra sacro e profano, tra teologia e vita, tra chierici e laici, tra chiesa e storia… generalmente in concorrenza tra loro. Questo, se da una parte ha fatto crescere la laicità attraverso i conflitti che ha generato nella storia (rinascimento, caso Galileo, rivoluzione francese e russa…), dall’altro ha impoverito la chiesa, che ha giocato in difesa. Tuttora i diritti civili non toccano l’impostazione ecclesiastica saldamente in mano al clero, mentre i laici e le donne, in particolare, sono ridotti a “minori”, sotto tutela. Basta osservare la reazione ecclesiastica al documento internazionale “Noi siamo chiesa” dove si chiede solamente di aprire il dialogo su tutta una serie di questioni ipotecate dal clero. Gli stessi organi di partecipazione ecclesiale: consigli vari, convegni, commissioni… risultano organi solo consultivi. La parola “comunione” si è sostituita alla vecchia “obbedienza alla gerarchia” ma la sostanza rimane inalterata.
La chiesa necessita di persone adulte e responsabili sia al suo interno che negli spazi del sociale e della politica. Il prete, in questo contesto, porta su di sé la contraddizione di un ruolo che storicamente ha assorbito ogni responsabilità dentro la chiesa lasciando la gente solo ad usufruire di servizi sacri; e come contropartita ha dovuto annullare i diritti umani riguardanti la propria persona ed, in parte, anche quelli civili. In compenso risulta coperto dal mito ideologico del servizio e da un’organizzazione onnicomprensiva che lo esonera dalle tensioni personali / vitali.
Tutto è pubblico, compresa la stessa liturgia, colta però nello spessore storico e contingente delle cose, senza caricarla di una sacralità che la stacca dalla storia volendola rendere eterna: la vera liturgia, secondo il filone profetico, resta sempre la vita del popolo aperta all’Alleanza.
Il “qui ed ora” ci costringe a misurarci con le nostre tensioni e responsabilità laiche e religiose e, insieme, con la nostra fede, superando la schizofrenia personale e il dualismo ecclesiastico nella direzione dell’esperienza di Bonhoeffer a fronte della costrizione nazista.
“Se preghiamo perché il Regno venga, possiamo farlo solo come uomini che poggiano con ambedue i piedi sulla terra. Chiedere che il Regno venga non lo può chi cerca di sottrarsi alla miseria propria ed altrui; chi, nella solitudine e nel distacco delle ore di devozione, vive per essere solo “beato”; possono esserci delle ore, per la chiesa, in cui essa può sopportare anche questo; noi non lo possiamo. L’ora in cui la chiesa prega perché il Regno venga, la costringe a partecipare pienamente alla società dei figli della terra e del mondo, nella prosperità e nella miseria, si impegna a restare fedele alla terra, alla sua miseria, alla fame, alla morte. Si rende completamente solidale con il male ed il peccato del fratello. L’ora in cui preghiamo perché il Regno venga è l’ora della più completa solidarietà con questo mondo, un’ora a denti stretti e con pugni tremanti”. (Dietrich Bonhoeffer, Venga il tuo Regno, 1932).
Ed in carcere, il giorno dopo del fallito attentato ad Hitler “Più tardi ho appreso, e continuo ad apprenderlo anche ora, che si impara a credere solo nel pieno essere aldiqua della vita. Quando si è completamente rinunciato a fare qualcosa di noi stessi: un santo, un peccatore pentito, od un uomo di chiesa (una cosiddetta figura sacerdotale), un giusto od un ingiusto, un malato o un sano, e questo io chiamo essere aldiqua, cioè vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi e degli insuccessi, delle esperienze, delle perplessità; allora ci si getta completamente nelle braccia di Dio, allora non si prendono più sul serio le proprie sofferenze, ma le sofferenze di Dio nel mondo, allora si veglia con Cristo nel Getzemani, e, io credo, questa è fede, questa è “metànoia” e così si diventa uomini, si diventa cristiani.” (Resistenza e resa, p. 446).
LA STORIA E LE STORIE
Trovo confuso il concetto di mediazione. Si parla di mediazione tra Chiesa e mondo, una specie di autorevolezza della prima sul secondo. Per parte mia ho sempre parlato a nome mio, non avendo autorità su niente. In quanto alla parrocchia essa fa delle cose per le quali è lì. Cosa medierebbe? Anche il richiamo alla Storia mi pare confuso. Le grandi storie non danno più luce. Ciascuno è chiamato a cercare una luce dentro alle singole storie
Ex–ubera o vomito?
Oggi si parla molto di esuberi soprattutto in riferimento a persone escluse dai luoghi di lavoro; i PO non fanno eccezione; alcuni sono in CIG, in mobilità, in prepensionamento, o licenziati. La sorte di tanta gente è quella di essere fuori dalle “ubera” cioè fuori dal circuito economico e sociale, ricacciati nella solitudine e nella “fame” non solo figurata.
I PO sono diventati un esubero anche per la chiesa; alcune cose, però, le abbiamo scelte noi e ci siamo posti ai margini e la solitudine conseguente per noi non diventa un peso, ma la condizione necessaria per aprire all’esperienza mistica. Il nostro impoverimento è la nostra ricchezza. Non abbiamo da rincorrere né il progresso, né lottiamo per avere preti migliori, quanto per una struttura leggera che non catturi la gente ma l’aiuti ad andare verso l’Oltre.
È pur vero che la parrocchia non è solo un dato esterno che può interessare solo i PO parroci: è una realtà posta dentro di noi, poiché senza mediazioni ed istituzioni non possiamo comunicare. E non possiamo rimanere a stomaco vuoto dopo che abbiamo vomitato quello che ci hanno fatto inghiottire. Si tratta di ricapire il senso vero delle parole e dei gesti che ci sono pervenuti dalla tradizione (resurrezione, fede, preghiera, grazia, liturgia…). Ci accompagna in questo la figura di Francesco d’Assisi nell’attraversamento della struttura e trovare così nuovo nutrimento da persone diventate adulte, distaccate dalla madre e pur in relazione con lei. Accogliere maturità e possibilità di relazione adulta.
Il nostro attraversamento non è un semplice passare oltre magari senza sporcarci, è anche un incrocio, un incontro/scontro per maturare comunicazione e compagnia, anche se ognuno dovrà mediare per sé. Ma anche su questo filone sorgono dei problemi. Come esprimere l’esperienza religiosa attraverso la comunicazione e la compagnia in una struttura ecclesiastica che ha usato della comunità sul terreno politico/privato? La cultura moderna è impregnata dal “fai da te”. Come è possibile mettere in relazione le esperienze della gratuità del divino in un contesto di incomunicabilità umana? Ancora di più:
come far sì che la comunicazione e la compagnia diventino la molla per una responsabilità che vada contro l’esclusione e la solitudine intesa come emarginazione?
Resta, tuttavia, il nodo tra comunione e solitudine del credente. In politica tutto deve essere posto alla luce perché ogni cittadino possa vedere, valutare e scegliere; ma nel campo della mistica cosa succede? La politica è un campo in cui si dimostra, mentre nell’esperienza mistica si mostra; ed allora quale comunicazione è possibile in un campo riservato alla solitudine della persona?
“Se incontri il Budda: uccidilo!”
mediazione necessaria / inutile
Ogni persona matura si caratterizza non tanto dall’aver superato le contraddizioni, quanto nel vivere con equilibrio ed anche con positività in mezzo alle tensioni provocate da elementi che sembrano inconciliabili eppure necessari. Non si sopprime nulla, ma si affronta il conflitto evitando deleghe e fughe.
Una struttura di mediazione come la chiesa, quando si carica di deleghe diventa struttura di potere ed anche di oppressione, proprio il contrario del suo compito, che sarebbe quello di favorire l’incontro con l’Evento ritirandosi e morendo come mediazione. In caso contrario la mediazione, da strumento di percorso, diventa fine a se stessa catturando e legando le persone al sacro, impedendo loro di “attraversarlo” per andare “oltre”.
La mediazione, sia pur necessaria per la condizione creaturale in cui siamo posti, non è fruibile come bene in sé; il bene vero è sempre oltre. Essa diviene un “indicatore”, ti può portare fino alla soglia; il Mistero, però, non è colto nella mediazione, ma nel “rapporto” che si instaura tra la persona ed il suo Dio, e questo avviene in solitudine e nel profondo dell’anima (Eckart).
Sono necessari segni, parole, comunità.., ma sono come gli eunuchi che si fermano davanti alla stanza nuziale, pur avendo preparato l’incontro. Alla mediazione viene tolta, per questo, ogni sacralità rimanendo nell’ambito dello strumentale – creaturale.
Anzi, ogni gesto, ogni parola, ogni esperienza è strada per un possibile incontro con il Mistero al di là dell’etichetta laica o religiosa. Il sassolino che colpisce il bambù e produce un suono, è stato strumento di illuminazione per il monaco disperato dopo anni di ricerca religiosa inutile, poiché l’Evento si manifesta in concomitanza di questo o quello (esperienza Zen).
Prendiamo atto di quanto la mediazione (o il sacro) pesi ancora sulla nostra gente, è parte di un potere di oppressione più generale, concorrendo a mantenere le persone nella sottomissione. D’altronde, non possiamo eliminare il sacro: toglieremmo anche una risorsa e lasceremmo il vuoto; si tratta di assumerlo nelle sue contraddizioni e gestirlo, fiduciosi che “la chiave che ha chiuso la libertà, la può anche aprire” (Cesare S.).
I PO che si trovano in parrocchia sono particolarmente sensibili a queste tematiche e sentono che il loro ruolo non si identifica nella gestione del sacro, ma nello stare con la gente in una lettura “sapienziale” della vita, dei segni e delle parole sacre o laiche che portano a maturare nella libertà e responsabilità. I PO in questo compito si scoprono avvantaggiati, poiché hanno superato la fame del testimone, in quanto la loro fame si sazia in altri terreni: il lavoro, l’autonomia, le relazioni sociali… Il ruolo sacro uccide quella “comunità interiore” che è presupposto per un cammino comunitario di eguali: non possiamo tentare una libera comunione con Dio e sentirci oppressi dalla domanda di ruolo sacro.
Il Cristo stesso è via, non meta; verità come rivelazione del Padre; vita come unico canale di grazia; ed è costituito, per i credenti, come unico mediatore secondo la lettera agli Ebrei. Dovremmo riservare solo a Lui il termine “mediazione”; per il resto dovremmo parlare di “segni, indicatori…” da rileggere attraverso uno stile “sapienziale, figurato, di accostamento…” per ritrovare illuminazione, gusto, saggezza, fede.
In epoca cosiddetta postmoderna si è posto al centro la soggettività, il cammino delle singole persone, a questo tutto dovrebbe esser riferito, come dice Paolo: “Tutto è vostro (avvenimenti, chiesa, parola, sacramenti….) ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1Cor.3,21ss.), passando dalle singolarità all’Uno.
Prete, padre pericoloso…
Nella mediazione. si giocano vari ambiti. Parlare di prete-pedagogo mi pare pericoloso. In una famiglia ci può essere il tempo che matura i figli, ma in una comunità c’è il rischio che il prete-pedagogo abbia già fatto tutte le mediazioni e le scarichi sulla comunità. Così ha una paternità ma non genera figli adulti.
Anche il prete come organizzatore di servizi pone problemi. Non essendoci una comunità con una linea, ogni prete si inventa, successivamente, la ‘sua’ linea che la comunità subisce.
Oltre la soglia: il Nulla!
Il gruppo regionale dei PO del Veneto durante l’anno 1996 ha ruotato intorno alla domanda: “Quale la soglia minimale per accettare un’istituzione sacra che non sia di impedimento all’esperienza mistica del popolo?” .
L’intento non è stato quello di essere contro le istituzioni (anche il singolo è strutturato soprattutto nei rapporti), ma cogliere i segni di idolatria che ci impediscono di essere credenti secondo i primi due comandamenti: non avrai altro Dio fuori di me e non nominarLo invano.
La storia religiosa e civile italiana è fortemente impiantata sulle sacre istituzioni, ne fa fede la produzione artistica incentrata su madonne, santi, scene bibliche. Ma durante questa storia, si sono aperti spazi per una esperienza religiosa profonda a livello popolare?
Come PO, all’interno dell’ingranaggio ecclesiastico abbiamo contestato il sacro come storicamente si è strutturato. L’esperienza religiosa ripete la catena di montaggio della produzione e distribuzione di beni materiali e ha come prodotto l’uomo / donna sotto tutela e la divinità codificata e fruibile come una merce.
Di fronte a questo processo abbiamo tentato di ripensare i vari elementi della mediazione a disposizione della chiesa, a partire dalla nostra finestra di osservazione e dall’esperienza dei PO parroci od in contatto con le strutture del sacro. L’atteggiamento è oscillato tra la compassione biblica per la gente e la dimensione profetica.
La Parola e le Parole
Fa piacere constatare come la Parola stia guadagnando centralità nella vita dei credenti, anche se è di frequente intrappolata nel moralismo, nel fondamentalismo od anche integrismo e devozionismo, a cui non sono sfuggite le stesse prime comunità primitive.
Per noi resta importante “accostare” la parola alle parole e agli avvenimenti senza ingabbiare nessun elemento; rievocare “figure ed immagini” nella ricerca “sapienziale e profetica”.
Il rito e la magia
La ritualità sacra è carica di forti simbolismi legati alle radici di un popolo e, nello stesso tempo, alla molla che ne muova la storia. Di fatto, i riti religiosi sono diventati parte integrante della vita civile e della parabola personale. Il significato originario è stato marginalizzato.
Recuperare le radici costringe ad andare alla “memoria” di un Evento accaduto nella storia, andare alla celebrazione della quotidianità laica cogliendo la speranza aperta dalla misteriosa presenza / assenza. Il rito non sostituisce la vita e non la sublima, ma ne svela la chiamata all’alleanza.
Magistero e disobbedienza
Non è solo contraddizione, ma un assurdo avere un forte magistero onnicomprensivo ed una disubbidienza sistematica dei fedeli: qualcosa non va! Siamo in situazione di pesante fariseismo, dove all’autorità interessa salvare il castello dei principi costruito magari sulla sabbia delle filosofie ed ideologie e poi perdonare il popolo che usa il “fai da te”.
Ma come uscirne? Qualcuno in situazione più ampia dell’esperienza dei PO sta tentando delle strade sia sulla teoria e sia sulla prassi.
Sul problema della paternità / maternità responsabile: “se un grandissimo numero di sposi cristiani, dopo una seria informazione, un attento esame di coscienza e dopo aver ponderato le circostanze, fa uso del preservativo, ciò dovrebbe esser un segno del “sensus fidelium” secondo la più sacra tradizione, e non un tradimento od un adattamento al lassismo del tempo” (Fries, Le chiese diventano inutili?).
Così pure per i divorziati risposati, esclusi dalla comunione sacramentale, anche se non scomunicati, come tener presente il principio / valore della indissolubilità ed insieme la giustizia e misericordia? Ratzinger definisce la posizione di alcuni vescovi tedeschi più aperti di fronte a questo problema come “un attentato anticattolico”.
E poi: i laici chiedono la parola: fine del clericalismo; le donne chiedono la parola: fine del patriarcato; le parrocchie chiedono la parola: fine del centralismo.
La disponibilità al dialogo non è solo questione di stile: è fatto costitutivo e vitale per la chiesa e per la società. E con la parola ci sono anche i “ministeri” nella comunità. In questo contesto appare assurda la dichiarazione sulla definitiva impossibilità che le donne partecipino ai ministeri ordinati come il presbiterato. Preferiamo questo termine alla parola sacerdozio, che rispecchia un recupero del sacro delle religioni cosiddette naturali. Roma locuta est… ma la causa resta aperta!
E da ultimo, il magistero lavora per l’autoconservazione. Come l’autorità religiosa al tempo di Gesù non ha colto la novità dell’Evento nella profanità del Cristo, così oggi si continua a mettere vino vecchio in otri vecchi: è il caso del “nuovo catechismo della chiesa universale” che ribadisce dogmi ed ordinamenti tradizionali (prodotto di un centralismo romano) usurpando alle chiese locali il poter ripensare la mediazione nelle situazioni culturali proprie (vedi condanna della teologia della liberazione).
Ma qui siamo alla pretesa che il particolare diventi universale ed è la fine della cattolicità ed anche del proclamato ecumenismo dove sia possibile esprimere la ricchezza della pluralità nell’unica fede.
Ministeri: l’eunuco spione
Nella chiesa si è tentato con l’ex opere operato e non operantis di staccare la mediazione dalla bontà o meno del ministro, ma nello stesso tempo, si è rafforzato il meccanismo del rito ed il ruolo dell’officiante oggettivizzando e codificando il tutto. Il legame poi con le cosiddette offerte “libere” (ma quanto sono libere se esistono tariffari?) date in occasione del rito, mostra che siamo in un negozio dove non importa la bontà del pizzicagnolo, ma la garanzia della merce ed il prezzo equo. Oggi, poi, si sono aggiunte le “forche caudine” della preparazione per la concessione del rito: tre incontri per un matrimonio od il corso fidanzati con tanto di cartellino…; un incontro per un battesimo …o mangi ‘sta minestra…
Il ruolo di mediazione sociale e religiosa porta il prete a sostenere tutta una serie di tensioni nel tentativo di far incontrare le differenti esigenze di una società pluralista, dibattendosi tra esigenza del messaggio e la cultura moderna, tra le direttive del magistero e le esigenze della gente, tra chi chiede il minimo e chi il massimo.
Il ruolo si trasforma in “condizione di vita” segnata dalla separazione propria del sacro. La vita è segnata non dalla professione, ma dalla vocazione, non dalle tensioni economiche ma da una garanzia (sia pur modesta) per la funzione, non dagli impulsi vitali (sessualità, affettività…) ma dalla sublimazione per essere l’uomo di tutti, non dall’autonomia ma dall’obbedienza. Nemmeno il carisma personale ha spazio dovendo, per prima cosa, “rappresentare” il vescovo in una comunità: ridotto a ripetitore nell’ingranaggio della teologia del mandato.
Il tutto è presentato come il costo sacrificale alla missione. Le altre figure propositive della società (psicologi, assistenti sociali, educatori…) con cui il prete ormai per gran parte si confonde, hanno un ruolo ben limitato che non ingloba tutta la propria esistenza; resta loro lo spazio per la fame e la sete da saziare altrove. Solo le persone libere sono liberanti!
Non è possibile anche per il prete esser ridotto “allo stato laicale” (in fondo, è quello che hanno fatto i PO) e passare da mediatore del sacro, da gestore di riti, da detentore dell’ultima parola a testimone, sentinella, pedagogo che non crea nulla. Il prete sarebbe rappresentato dalla figura del dito che indica la luna, ma dovrebbe esser attento a ritirarlo in fretta perché la gente non si fermi al dito.
E possibile diventare solo “indicatore” come i segni posti sui sentieri di montagna.
La Chiesa e le nuove realtà
Le nuove realtà di costume stanno mettendo in crisi la forma ‘mediazione’ in cui si è pensata e realizzata la Chiesa. Catechismi e forme di vita collettiva cristiana di un tempo, trovano altri valori e altre forme. Su questo fatto, poca è la riflessione.
Dal padre ai fratelli
La presenza della parrocchia è innegabile. Non si può far finta che non esista. È possibile inserire in questo fatto, che è storico, nuovi elementi di storia che ci permettano di andare avanti? Questa pare l’unica strada possibile. L’elemento nuovo è quello di mettere sempre più tra parentesi la struttura padre – figli, mettendo come base quella di ‘insieme tra amici, tra fratelli’. Se insieme degli adulti cercano di vedere come accettare la chiamata di Dio, Dio stesso porterà le attuali comunità da qualche altra parte.
Altre soluzioni negative sono o il negare un fatto che esiste, o voler distruggere qualcosa che in una sua qualche forma è indistruttibile; oppure l’attuale situazione, nella quale la Chiesa ‘impone’ un suo tipo di comunità e la gente si fa la comunità che vuole.
Troppa identità e comunione nuoce alla salute!
Dal cambiamento dei nodi della mediazione si prefigura una chiesa diversa, dove rimangono i ruoli istituzionali, ma come punto di riferimento più che di gestione autoritaria dell’apparato. Al centro è collocato il mistero della persona e dell’Evento in un loro possibile rapporto. Altrettanto centrale resta la comunicazione, che non si prefigge di dimostrare od imporre, quanto di mostrare “Mirabilia Dei” e cogliere i segni del Regno posti nella storia attraverso gli atteggiamenti del discernimento collettivo, ma anche dell’accoglienza, della misericordia e dell’attenzione verso i più deboli.
Nella compagnia ognuno può passare dall’essere figlio a diventare a sua volta padre a seconda dello scambio e non del ruolo.
Una chiesa “semper reformanda” secondo la tradizione, sia perché tenta di cogliere la memoria del Mistero nel contesto culturale del tempo e sia perché tenta di rispondere alla profezia che la interpella. Potrebbe servire la figura dei Probiviri presenti in alcune istituzioni laiche. Sono persone senza potere giuridico, ma punti di riferimento morale della memoria collettiva di un movimento od associazione.
Le difficoltà e contraddizioni continueranno ad esser presenti in ogni tentativo; si tratta di attraversarle salvando la dignità dei credenti, la libertà necessaria per vere relazioni, senza troppa identità personale che porta all’autosufficenza e senza troppa comunione istituzionale che appiattisce; un mixer difficile da combinare.
Il Talmud afferma: “Dio ha messo tanta luce nel mondo di modo che chi crede veda, e tanta oscurità di modo che chi non ha fede sia nelle tenebre”.
Figli che diventano adulti
Padri e madri non possono sottrarsi al loro ruolo, ma i figli devono diventare adulti. Lo scopo quindi di una parrocchia è che questo ‘popolo’, questa comunità sia una comunità di adulti.
La grande confusione
La parrocchia italiana vive in un insieme equivoco di ambiti diversi che sono confusi. Una cosa è il messaggio di fede, i suoi gesti, i fattori che qui interagiscono ecc., altra sono le attività di educazione civile e la varia rete di servizi inerenti. Se nel primo ambito il prete è un testimone necessario ma secondario, nell’altro è un professionista di percorsi e di attività che necessariamente esigono figure chiare, verifiche, controlli. Oggi, il secondo ambito ha oscurato completamente il primo, così che la necessaria mediazione del testimone ha l’esclusiva versione del professionista che fornisce servizi.
Dal rullo dei tamburi ai silenzi
C’è sempre più una frattura e una distanza tra evento cristiano e organizzazione. Questa, posto il deposito, è un insieme di azioni diffusive, dai catechismi alle feste. Il consenso come scopo esige apparati, organizzazione, ritmi di tamburi che fissano i movimenti delle masse, grandi o piccole:
Ma poi ci si chiede. I singoli cosa veramente si aspettano? Cosa passa nel cuore delle singole vite? Che illusioni ci sono in chi batte il tamburo e che illusioni si trasmettono, quando appunto l’essenziale sono domande e reazioni mute delle singole vite? Non dovrebbe essere centrale questo? Quali atteggiamenti assumere, se fosse così?
Discernere la storia
Vedo sempre più importante la storia. Una cosa è la trasmissione di idee, altro il racconto della storia. Non è necessario che le persone si scambino idee per capire. Piuttosto si impara qualcosa quando personalmente o in gruppo si discernono i vari fili delle mille storie nelle quali siamo, a cominciare dalla storia biblica.
La mediazione? Da singolo a singolo
La mediazione è un dato necessario. Ci deve essere e c’è di fatto perché gli occhi che guardano la storia sono sempre gli occhi di uno. Quindi la mediazione è lo stato dell’uomo.
Come però fare perché qualcuno non diventi il mediatore? I credenti devono essere lasciati a scoprire la loro strada e diventare essi stessi mediatori.
La mediazione quindi è di un singolo ad un altro singolo. Nel variare delle situazioni, ciascuno deve essere orientato su una strada, ma poi (come il padre e la madre) il mediatore ha come scopo di creare altri mediatori. Questo oggi è un problema dentro la Chiesa.
A cura di Gigi Forigo e Roberto Berton
CORTIGIANI, VIL RAZZA DANNATA
(dal Rigoletto)
Belluno. Diavolo d’un uomo: supera anche la «prova gradini», ventuno in tutto e ripidissimi, da scalare per arrivare al terrazzino del palazzo della Magnifica Comunità Cadorina, e di là tener discorsi e recitare l’Angelus. Sale normalmente, senza appoggiarsi alla balaustra, fermandosi un paio di volte a guardare la folla, mentre un gruppo di chierichetti tifa «per il Papa alè-alè». Si gira attorno, alza le braccia: pare un olimpionico al traguardo.
Scoppiavano discussioni, fino a pochi minuti prima, fra i giornalisti ed il medico – portavoce del papa Joaquin Navarro. È andata davvero alla perfezione l’operazione al femore? Si dice di no… Fatica a camminare… Non riuscirà a salire senza aiuto quella scalinata… E Navarro: «La fa, la fa, in salita e in discesa; io penso che non avrà problemi». Ma no… A Roma si ferma di fronte ad ogni gradino… E ancora Navarro: «Il Papa è una persona abituata alle lunghe camminate, ma che in Vaticano non ha la possibilità di camminare, tutto qua. Qui, semplicemente, ha fatto l’esercizio che a Roma non può fare, ha camminato a lungo: solo ieri per 6 chilometri e non l’ho mai visto in difficoltà».
(dai giornali del 27 luglio 1996)
L’imperatore si spogliò e i due imbroglioni fingevano di porgergli, pezzo per pezzo, gli abiti nuovi, che, secondo loro, andavano terminando di cucire; lo presero per la vita come per legargli qualcosa stretto stretto, era lo strascico; e l’imperatore si girava e si rigirava davanti allo specchio.
— Dio, come sta bene! Come donano al suo personale questi vestiti! — dicevano tutti. — Che disegno! che coloril È un costume prezioso!
—Qui fuori sono arrivati quelli col baldacchino che sarà tenuto aperto sulla testa di Sua Maestà durante il corteo! — disse il Gran Maestro del Cerimoniale.
— Sì, eccomi pronto! — rispose l’imperatore. — Non è vero che sto proprio bene? — e si rigirò un’altra volta davanti allo specchio fingendo di contemplare la sua tenuta di gala.
(‘I vestiti dell’imperatore’ – da H. C. Andersen, Fiabe)
LIBERTÀ CORPORATIVE
«In realtà la Chiesa non vuole compromettersi nella vita pratica e non si impegna a fondo, nè per attuare i principi sociali che afferma e che non sono attuati, né per difendere, mantenere o restaurare quelle situazioni in cui una parte di quei principi era già attuata e che sono state distrutte. Per comprendere bene la posizione della Chiesa nella società moderna, occorre comprendere che essa è disposta a lottare solo per difendere le sue particolari libertà corporative (di Chiesa come Chiesa, organizzazione ecclesiastica), cioè i privilegi che proclama legati alla propria essenza divina: per questa difesa la Chiesa non esclude nessun mezzo, né l’insurrezione armata, né l’attentato individuale, né l’appello all’invasione straniera… Per “dispotismo” la Chiesa intende l’intervento dell’autorità statale laica nel limitare o sopprimere i suoi privilegi, non molto di più: essa riconosce qualsiasi potestà di fatto, e purché non tocchi i suoi privilegi, la legittima; se poi accresce i privilegi, la esalta e la proclama provvidenziale”.
in Quaderni dal carcere, Editori Riuniti)
FIGLI CHE RIDONO DELLA NUDITÀ DEL PADRE
È pomeriggio, ormai. Giovanni Paolo II sta di nuovo esplorando i boschi attorno a Lorenzago, una passeggiata semplice. Attorno, a vigilare sulla sua tranquillìtà, c’è di tutto: carabinieri travestiti da turisti e forestali a cavallo, poliziotti – motocrossisti e distinti agenti del Vaticano. I sentieri che imbocca sono controllati fin dal primo mattino; altro che ‘incontri con l’orso’, era una bufala – gli escursionisti più o meno gentilmente pregati di tenersi alla larga.
Dietro al papa, il seguito. Chi gli porta i libri da leggere, chi la brandina per la pennichella, la tenda per gli acquazzoni imprevisti, il fornello per cucinare… «Grazie, pranzo buonissimo!», sorride ogni giorno ai cuochi. «È proprio allegro», assicura Navarro. E come no? Con un trattamento da papa.
(dai giornali del 22 luglio ’96)
I figli di Noè che uscirono dall’arca furono Sem, Cam e Jafet; Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, da questi fu popolata tutta la terra.
Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all’interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre scoperto.
Quando Noè si fu risvegliato dall’ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; allora disse: «Sia maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli!».
Disse poi:
«Benedetto il Signore, Dio di Sem,
Canaan sia suo schiavo!
Dio dilati Jafet e questi dimori nelle tende di Sem,
Canaan sia suo schiavo!».
(Genesi 9,18 ss.)
ZUCCOTTI E BAMBINI
Doppio fuori programma ieri per il Pontefice. Il primo è venuto da una bimba che, senza timori reverenziali, ha tentato di impadronirsi dello zuccotto papale ma senza successo.
Secondo caso quindi alla recita dell’Angelus, quando a Giovanni Paolo II, mentre salutava i pellegrini in piazza è sfuggito uno starnuto in diretta, quasi dentro il microfono.
«Salute», ha augurato a se stesso; «salute», gli ha fatto eco la folla, cui ha risposto con un «grazie» divertito.
(dai giornali del 10 giugno 1996)
— Ma se non ha niente indosso! — disse un bambino.
— Signore Iddio! La voce dell’innocenza! — disse il padre; e ognuno sussurrava all’altro quello che aveva detto il bambino.
— Non ha niente indosso! C’è un bambino che dice che non ha niente indosso!
— Non ha proprio niente indosso! — urlò infine tutta la gente. E l’imperatore si sentì rabbrividire perché era sicuro che avevano ragione; ma pensò: «Ormai devo guidare questo corteo fino alla fine!» e si drizzò ancor più fiero e i ciambellani camminarono reggendo la coda che non c’era per niente.
(‘I vestiti nuovi dell’imperatore’ – da H. C. Andersen, Fiabe )
