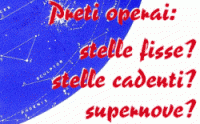
a cura dei PO del Veneto
PASSA LA NAVE MIA
COLMA D’OBLIO
(Petrarca)
IL DESIDERIO DEL BENE E L’ILLUSIONE
Se si subordina ogni cosa all’obbedienza a Dio, senza restrizione alcuna, con il pensiero: se Dio è reale, si guadagna così tutto – anche se l’istante della morte portasse il nulla; anche se queste parole non corrispondessero ad altro che a delle illusioni, non si è perso niente, perché in questo caso non c’è assolutamente alcun bene, e quindi niente da perdere; piuttosto si è guadagnato di essere nella verità, perché si sono abbandonati alcuni beni illusori, che esistono ma che non sono beni, per una cosa che (in questa ipotesi) non esiste, ma che, se esistesse, sarebbe anche l’unico bene…
Se si governa così la propria vita, nessuna rivelazione nel momento della morte può causare rimpianto; perché anche quando il caso o il demonio governassero tutti i mondi, non ci sarebbe da rimpiangere di aver vissuto così.
Questo è di gran lunga preferibile alla scommessa di Pascal.
Quand’anche Dio fosse un’illusione dal punto di vista dell’esistenza, Egli dal punto di vista del bene è l’unica realtà. Di questo ho la certezza, perché è una definizione. «Dio è il bene» è altrettanto certo di «Io sono». Io sono nella verità se strappo il mio desiderio da tutte le cose che non sono dei beni per dirigerlo unicamente verso il bene senza sapere se esista o meno.
Una volta che io abbia diretto tutto il mio desiderio verso il bene, quale altro bene devo attendere? Allora possiedo tutto il bene. Possedere tutto il bene è proprio questo. Non è assurdo immaginare un’altra felicità?
Per il privilegio di trovarmi prima di morire in una situazione perfettamente simile a quella del Cristo, quando sulla croce diceva: «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?» – per questo privilegio rinuncerei volentieri a tutto ciò che si chiama Paradiso.
Perché tutto il suo desiderio era interamente diretto verso Dio, e quindi possedeva perfettamente Dio. Egli soffriva una sofferenza quasi infernale, ma che importanza ha questo dettaglio? È per i beni falsi che desiderio e possesso differiscono; per il bene vero, non c’è alcuna differenza.
Pertanto Dio è perché io Lo desidero; questo è certo quanto la mia esistenza.
Io mi trovo in questo mondo con il mio desiderio incollato a cose che non sono beni, che non sono né buone né cattive. Devo strapparlo via, ma questo fa sanguinare.
Non c’è da stupirsi che il desiderio sia diverso dal possesso finché è incollato a queste cose, perché esso ha bisogno del bene ed esse non sono beni.
Appena si scolla e si volge verso il bene, esso è possesso.
Ma questo non si realizza di colpo per tutto il desiderio dell’anima. Dapprima solo per una parte infinitesimale.
Eppure questo granello di desiderio che è possesso, è più forte di tutto il restante desiderio che è vuoto.
Se desidero soltanto desiderare il bene, desiderando il bene sono colmata. Non è più difficile di così.
Simone Weil, Quaderni, vol. IV.
L’ABBANDONO AL TEMPO
È nel tempo che noi abbiamo il nostro io.
L’accettazione del tempo e di tutto ciò che esso può portare – senza alcuna eccezione
– (amor fati) – è l’unica disposizione dell’anima che sia incondizionata rispetto al tempo. Essa racchiude l’infinito. Qualsiasi cosa succeda…
Dio ha dato alle sue creature finite questo potere di trasportare se stesse nell’infinito. La matematica ne è l’immagine.
Se il contenuto piacevole o doloroso di ogni minuto (anche quelli in cui pecchiamo) è considerato come una carezza speciale di Dio, in cosa il tempo ci separa dal Cielo? L’abbandono in cui Dio ci lascia è il suo modo proprio di accarezzarci.
Il tempo, che è la nostra unica miseria, è il tocco stesso della sua mano. È l’abdicazione mediante la quale ci fa esistere.
Egli resta lontano da noi, perché se si avvicinasse ci farebbe sparire. Aspetta che andiamo verso di lui e spariamo.
Alla morte, alcuni spariscono nell’assenza di Dio, altri nella presenza di Dio. Noi non possiamo concepire tale differenza. Per questo, affinché l’immaginazione possa coglierla in modo approssimativo, sono state forgiate le rappresentazioni del paradiso e dell’inferno.
Simone Weil, Quaderni, vol. IV.
Materiali di documentazione e riflessione
sulla condizione del prete vecchio, malato, morente
a cura di Don Umberto Miglioranza
Premessa
Don Umberto Miglioranza (che cura questa parte del quaderno), negli anni ‘70, con altri preti ed amici ha tentato a Spinea (diocesi di Treviso) una distinzione di ambiti all’interno del pericoloso e vincente modello della parrocchia-totalità. Ambiti di fede da una parte e ambiti sociali e politici dall’altra. Nel contesto divenne logico, anche il prete operaio (il primo nel trevigiano) come uno dei tentativi di distinguere, per spazi, idee, responsabilità e libertà, anche le dimensioni del testimone, del credente e dell’uomo, oggi come allora cementati nel ‘prete’.
Una combinazione di paura e bigottismo dal basso e di puro calcolo dall’alto, ha tutto distrutto, anche il tentativo di pensare qualcosa in quella direzione. Chiamare ‘chiesa’ o ‘istituzione’ o ‘gerarchia’ chi ha detto questo, non si può, dato che quei termini hanno un senso. Forse solo le pagine, citate in questo quaderno, di Bonhoeffer sulla “stupidità”,fanno un po’ di luce; oppure il detto popolare sul malato pazzo che butta via il termometro per non avere la febbre…
Cacciato il pastore e disperse le pecore, don Umberto è rimasto sempre all’interno del movimento dei PO, più che come simpatizzante, come sponda preziosa. Ora ritorna con questi materiali. Il lettore distratto, stia attento. Queste note non portano verso qualche solidarietà di categorie verso i preti che, poverini, anche loro ecc. ecc. A cominciare dal Papa, con tutti i suoi archiatri, fino all’ultimo prete, nessuno finirà nelle maglie normali dove invecchia e muore la gente. Ci sarà sempre qualche ‘buco’ speciale.
Qui il discorso è un altro e porta vicinissimo ai temi dell’esperienza dei PO. La professionalizzazione del prete come operatore sacro-sociale (otto per mille ecc.) ha fatto del prete, in controtendenza alle donne, una ‘casalinga’ che dipende in tutto dal marito, chiuso nel suo ruolo dove tutte le differenze prima ricordate sono piallate. Nessuno gli ha chiesto niente, come un’azienda farebbe, almeno con i quadri, nel caso di riforme riguardanti i vari processi di produzione e commercializzazione.
Don Umberto, che vive al di dentro le situazioni, pone le domande. Le persone si
accorgono dei costi di quel modello? Hanno visto i costi di quella che appariva una sicurezza? Se il modello non ha ricevuto domande né dai problemi relativi alla trasmissione del famoso Messaggio o dall’aver creato una comunità cristiana di produttori-consumatori (a nessuno importa niente né del messaggio né della comunità), sarà l’autodistruzione e lo smarrimento di questa categoria di ‘salvatori di professione’ che porrà le domande? L’esperienza dei PO, condivisione di fabbrica, di fede, di problemi di territorio, di rispetto della fede delle persone, il lavoro come governo e limite sia dei propri egoismi che delle proprie generosità ecc., portano vicini i PO ai temi di don Umberto. Non sono temi né da “capezzale” né clericali ma portano al centro della condizione umana e cristiana.
DALLE PAROLE ALL’ESPERIENZA
Qualche tempo fa, ho passato alcuni giorni in una unità cardiologica. Vi ho trovato un medico, un primario di un reparto rinomato nell’ospedale. Era ricoverato come me. Aveva avuto un collasso cardiaco con i sintomi di un infarto. Ciò che mi ha impressionato non è stata la natura del male, che poco dopo è stato superato, ma la paura di quel medico.
Un uomo che aveva preso in mano la situazione di tanti malati, anche gravi, ora si trovava di fronte al suo male e aveva paura. Una cosa naturale aver paura del male. Ma non era naturale che uno che si sentiva padrone della vita degli altri, ora si trovasse paurosamente disarmato davanti alla propria vita.
Il riferimento alla professione e alla vita del sacerdote mi è venuto spontaneo. Un prete compie un ministero che lo mette a contatto con molte persone. Per tutte deve essere un ‘medico delle anime’. Lui si prodiga, e spesso con grande generosità, a dare risposte ai problemi spirituali della gente. Sarebbe naturale aspettarsi da lui una grande ricchezza spirituale, una ricchezza che si chiama ‘fede’. Grande è la sorpresa quando, al posto di una ‘fede’ personale, si trova un professionista della fede, uno che ha imparato a parlare di Dio a tutti, ma che non si è fermato per avere l’‘esperienza di Dio’, quella esperienza che porta la persona ad avere occhi che vedono, orecchie che ascoltano, cuore che comprende. È l’esperienza che è un dono che viene dallo Spirito e che conduce a conoscere la verità tutta intera, la verità della vita, del senso del merito di Dio e dell’uomo, la verità del dolore, della solitudine, della morte.
Quando, come tutti, i preti perdono la salute, entrano nella solitudine, vivono la vecchiaia e vedono vicina la propria morte, se non hanno radici profonde, entrano in crisi. È la crisi che si avverte nelle testimonianze dei preti in casa di riposo, quella di chi si risveglia da una lunga attività fatta per gli altri. È la crisi che ha il suo centro nella profondità di se stessi. Ritrovare se stessi è il tema di queste note e di questo lavoro. Ritrovarsi perché, molto spesso, ci siamo perduti. Ritrovarci, ed è un segno di speranza che ci suggerisce. Ritrovarci come uomini, come credenti e come preti. Le indicazioni sulla formazione permanente sono in questa direzione, sono una provocazione per entrare in questa realtà.
L’aumento di una cifra (una semplice cifra) è uno stimolo più forte della conservazione della vita.
Solo il sentimento della morte forse prossima rende la conservazione della vita il più potente degli stimoli.
«Niente è più dolce agli sventurati della vita, proprio nel momento in cui essa non è in nulla preferibile alla morte».
Fenomeno di “vuoto”. L’orrore del “vuoto” e il lavoro dell’immaginazione nel ricordo e nella previsione. Aver speso dell’energia affinché tutto si ritrovi nello stato di prima: intollerabile.
[Questo accade spesso al contadino: fieno ammucchiato, bagnato dalla pioggia, steso ad asciugare, di nuovo ammucchiato].
È la legge della vita umana: spazzare, lavare, ecc., mangiare.
«Congiungere le due estremità», espressione di un ciclo. Un campo in autunno, e l’autunno seguente: tutto è uguale, l’uomo ha lo stesso peso, la casa è simile, la provvista di grano nei granai la stessa… Si è solo un po’ invecchiati.
Simone Weil, Quaderni , vol. 2°
Nessuno saprà mai cosa voleva, cosa cercava. Forse la libertà, forse un lavoro, forse solo la possibilità di divertirsi come tanti suoi coetanei. Un’ansia profonda: insofferenza di sé, degli altri, del proprio paese senza futuro.
T. E., occhi azzurri da duro e capelli biondi, a 13 anni aveva già deciso che in Albania non voleva più vivere. Cercava fortuna in Italia senza sapere dove trovarla. Una ricerca spasmodica, scappando da tutto e da tutti, di giorno e di notte. Come domenica scorsa. Poi il buio, le zolle di terra che si sbriciolano sotto i piedi ed il vuoto: 40 metri giù in un burrone fino sul greto del fiume Candigliano al fondo di una vita ribelle da consumare in un attimo.
dai giornali del 3 ottobre 1996
PER UNA RIFLESSIONE SUL PRETE ANZIANO
1. Noi siamo diventati una società più vecchia. Non solo perché mancano i figli, ma anche perché l’anziano vive più a lungo. Si può calcolare un tempo di vita dopo il pensionamento da 15 a 20 anni.
2. L’anziano ha la salute a rischio. Il rischio di ammalarsi è permanente, e con esso il rischio di diventare non autosufficiente. Ciò significa aver bisogno ed essere nelle mani degli altri. È una dipendenza necessaria e raggiunge circa il 10% dei pensionati.
Quando non si è più autosufficienti ci sono problemi di assistenza, di solitudine, di esigenze economiche ulteriori, e ci sono problemi di fede.
È il senso della vita che viene messo in questione e non si trovano motivi adeguati per continuare a vivere.
Ci si pone la domanda: Quale missione Dio affida all’uomo quando arriva a queste condizioni?
Come vivere la propria malattia e la propria morte, perché sia degna di un essere umano e di un credente?
3. Gli anziani che sono autosufficienti passano il loro tempo o nella completa improduttività, il che significa avvilire presto, troppo presto, la propria dignità con il vino, con l’ozio forzato, con il dispendio di energie e di denaro solo per avere quello che prima non potevano avere, con una vita inutile che non ha più un senso. Il suicidio dell’anziano diventa sempre più frequente oppure l’anziano continua a lavorare con impegni marginali alla società, attività di carattere sociale e religioso.
Questo impegno sta diventando molto utile, così che si parla di un nuovo investimento che si può fare sull’anziano.
4. La nostra riflessione non si ferma però a queste analisi.
C’è una nuova realtà da scoprire: non quali i bisogni dell’anziano, ma quali i compiti che la vita gli consegna.
Questo significa rimettere l’anziano nella sua famiglia, nel suo paese, nella sua chiesa non per farne un oggetto di assistenza, ma per aiutarlo a capire ciò che deve dire, ciò che deve fare, ciò che deve costruire lui per gli altri.
È una riconversione al senso della vita e una ripresa dei motivi per vivere, ma è di più la scoperta di un ruolo finora inatteso: è il ruolo del saggio, del consigliere; amiamo definirlo come il ruolo del profeta.
Una società, una famiglia, una chiesa senza anziani può essere una realtà senza profeti, e sarebbe un impoverimento imperdonabile.
5. Il prete sta passando per le stesse strade. Anche se continua a lavorare fino a 75 anni, conosce il peso dell’età, almeno da 65 anni in poi.
Spendere le ultime energie per la chiesa è un frutto generoso di una grande fede. Ma questo non toglie la dimensione umana che pone il prete a vivere come tutti gli altri uomini la stanchezza dell’impegno quotidiano, il logorio che appesantisce la sua opera, e una grande nostalgia di riposo che gli suggerisce di ritirarsi dal suo impegno ministeriale anche prima dei 75 anni.
6. Questa situazione del prete sta entrando tanto rapidamente in tutto il Clero. L’età media del clero è ora portata sopra i 60 anni per tutti gli ambienti, e la chiesa non ha possibilità di cambiare i cavalli per la corsa, mentre il mondo sta cambiando velocemente e pone problemi sempre nuovi, indigeribili ormai per chi è anziano.
È giusto rivolgere le proprie cure per le nuove vocazioni, ma anche questo passa attraverso i preti ormai anziani.
È comprensibile la preoccupazione di non avere preti a sufficienza per tutte le parrocchie. È lodevole la premura dei preti anziani di fare anche vita comune per rispondere meglio alla richiesta religiosa della gente.
Ma il problema rimane: il prete è anziano e tutto quello che fa è ormai anziano e non può non esserlo. È assurdo voler rimanere in campo a giocare, quando altri problemi attendono di essere presi in mano, che non sono i problemi del servizio strettamente pastorale o ministeriale.
7. Si pone la questione: quale ruolo può avere il prete ora che è diventato anziano?
Non si pone evidentemente il problema dell’assistenza, che pure esiste, ma ha altre dimensioni, e neppure ci si ferma alla sua generosità di volersi impegnare fino alla morte nel campo che gli è stato assegnato. In fondo anche questo può aiutarlo a rimuovere il vero problema della sua vita.
Si tratta di prendere coscienza che l’anziano non è fatto per continuare a lavorare come prima, ma per riscoprire la vita nel suo senso più profondo, che passa attraverso l’inattività, la solitudine, la malattia e la morte.
Sono appuntamenti che non possono essere rimossi solo mettendo un supplemento di attività.
A volte si ha l’impressione che il prete che continua a fare il parroco fino a 75 anni spiritualizzi il suo lavoro, perché ha paura di affrontare il duro cammino della vita.
8. Volendo approfondire questo discorso, ci sembra di poter dire che anche il prete ha il dovere di discernere tra il fare e l’essere. L’anziano è dentro l’essere più che dentro il fare.
L’ essere significa ripercorrere il senso della sua vita, rivedere i fondamenti della sua fede, ascoltare la verità di quella parola che si fa udire nel silenzio della solitudine, nella malattia e nella morte. Riacquistare la saggezza della vita e la sapienza del cuore e ritornare a dire parole di vita.
Noi crediamo che questo sia un compito forte, che non può essere accantonato per immergersi nelle attività.
9. Per arrivare a questo ci sembrano importanti due direzioni:
a – quella del profeta. Si può pensare che il Signore abbia preparato questa situazione per riportare nella chiesa la parola del “presbitero”, nutrita di capacità di discernimento. Forse è giusto dire che la chiesa ha tanti maestri, ha tanti diplomatici, ha tanti pastori, ha tanti teologi, ma ha pochi profeti, e anche per questo conosce la difficoltà di orientamento nel travaglio annuale.
b – quella di consigliere, padre spirituale, dell’educatore di un popolo, del punto. di riferimento per le anime che cercano Dio, del confessore.
È un compito che sembra fatto apposta per un anziano che conosce la vita e può parlare con autorità o meglio con autorevolezza.
Noi vediamo questo compito come un carisma che viene dall’alto. È dato per la chiesa, è dato per la società. È dato perché non venga sepolto come l’unico talento della parabola, ma sia comperato anche a caro prezzo, come si compra il tesoro in cui mettere il nostro cuore.
LE CONDIZIONI PER UNA VITA NORMALE PER IL PRETE
Il suicidio di un prete
L’articolo di presentazione dell’ultimo bollettino della FIAS ha come titolo provocatorio: “Non c’è problema…”
Rileviamo che le ragioni per cui un prete si trova disarmato davanti alla vita e ne esce sconfitto si possono trovare sia sulla sua famiglia, sia sul Seminario che l’ha preparato, sia sulla difficile vita comunitaria tra preti, sia sulla fatica dell’impatto della persona fragile con la realtà pastorale, spesso più grande del cammino preparatorio.
Manca il “dialogo”
Sul discorso teorico siamo tutti d’accordo. In pratica però non c’è dialogo tra il prete e la CEI, salvo un rapporto economico, spesso sproporzionato con l’esigenza di pagare anche una persona che stia accanto al prete. Non c’è dialogo tra i preti e il Vescovo e tra preti e preti. Tentativi personali ci sono, ma manca una prospettiva di sentirsi in famiglia, di parlarci come in famiglia, di fidarci come in famiglia, di camminare insieme come in famiglia. Da questa situazione nasce un rapporto di funzionario, non di un fratello o di un padre o almeno di amico. I preti, che hanno lasciato la loro famiglia, hanno il diritto di trovare nella chiesa diocesana un rapporto di famiglia.
La solitudine del prete
può diventare tragica se c’è una solitudine nel rapporto personale, ma c’è anche una solitudine nel ministero sacerdotale. Le comunità cristiane chiedono, ma non aiutano. Allora si vive nel relativismo. Si lavora tanto, adattandosi alle richieste. Ma dentro c’è un vuoto che va riempito con una profonda relazione spirituale.
Ma è un cammino troppo solitario, quando i preti hanno il vescovo alle spalle e confratelli a fianco.
Le prospettive
Si possono intravedere con una ricerca che non può finire in poche raccomandazioni o in documenti esortativi. C’è bisogno che questo problema venga preso in mano con umiltà da tutto il presbiterio e dai vescovi.
Ci sembra che la ricerca debba puntare sulla spiritualità della persona, ma anche sulla esigenza di avere preti che siano uomini adulti. L’educazione degli adulti è necessaria per una crescita comune, e va fatta con esperti di professio ne, sia uomini che donne, sia laici che preti, ma soprattutto va fatta camminando insieme.
Le ipotesi
Prima di arrivare alla sconfitta finale con il suicidio, il prete può avere diversi segni di cedimento che vanno presi sul serio. C’è il problema dell’alcolismo, c’è quello delle devianze affettive, c’è quello di una mancanza di rapporti personali, che nascondono spesso un infantilismo non maturato.
Ci sembra che per questo sia importante riflettere insieme sulla importanza: a) di avere un accompagnatore spirituale che si deve preparare con anni di esperienza; b) di normalizzare i rapporti tra uomo e donna, vissuti con il criterio dell’adulto; c) di mettere a disposizione piccole comunità di preti, operanti nello stesso territorio con una disponibilità a regolare da adulti i rapporti personali; d) ma soprattutto è il presbiterio che deve prendere coscienza della difficoltà di ciascuno. Non è il gruppo a parte, o lo psicologo che riporterà il prete alla normalità.
È tutto il presbiterio che deve dare il clima di famiglia a tutti. In questo campo persone più preziose sono quelle che hanno fatto l’esperienza. Appunto, il prete anziano. Il suo ruolo profetico diventa pietra angolare per una ricostruzione di chiesa corrispondente ai nostri tempi e alla nuova evangelizzazione.
Bibliografia
• Tolstoj, La morte di I. Ilic, varie case editrici
• S. Natoli, Esperienza del dolore, ed. Feltrinelli
• S. Natoli, I nuovi pagani, ed. Il Saggiatore
• Bernanos, Diario di un curato di campagna, ed. Mondadori
• A. Di Nola, La morte trionfata, ed. Newton Compton
• A. Di Nola, La nera signora, ed. Newton Compton
• G. Scherer, Il problema della morte nella filosofia, ed. Queriniana
• Marie de Hennezel, La morte amica, ed. Rizzoli
• Rossanda-Gentiloni, La vita breve, ed. Pratiche
Altre culture:
• H. S. Hisamatsu, La pienezza del nulla, ed. Il Melangolo (budd. zen)
• Libro tibetano dei morti, ed. UTET
• Bardo Thodol, Libro dei morti tibetano, ed. Einaudi
Filmografia:
• Il posto delle fragole, regia di I. Bergman
• Sussurri e grida, regia dii. Bergman
ASCENSORI PER IL CIELO?
Santa Teresa di Lisieux — Aver proposto come modello alle folle un destino che trova il suo avvio in circostanze assolutamente eccezionali è un’assurdità che merita veramente di essere esaminata. Lei stessa aveva già commesso questa assurdità. il segreto del suo successo risiede nella sua idea di inventare un «ascensore» per andare in cielo. È questo che è piaciuto ai suoi contemporanei, e non il suo amore per il Cristo. Dopo il 1914, e ancor più dopo il 1940, questa particolare qualità della sua santità è del tutto inattuale.
«Nessuno sa se egli è degno di amore o di odio». Ma porsi tale questione è del tutto inutile, il dramma della salvezza si svolge dietro il sipario. Non è possibile constatare la presenza dell’amore di Dio, se lo si ha in sé. Egli non è un oggetto per la conoscenza. Perché è Dio in noi che ama Dio, e Dio non è un oggetto. Quanto al prossimo, gli atti di beneficenza di cui ci ricordiamo non saranno menzionati nei ringraziamenti del Cristo, perché per il fatto di ricordarcene abbiamo «ricevuto la nostra ricompensa». Quanto a quelli di cui non ci ricordiamo, per definizione non sappiamo se hanno avuto luogo.
Del male, al contrario, si ha una conoscenza certa. Quando si fa una cosa che si ritiene contraria alla volontà di Dio, è certo che si è colpevoli di disobbedienza, anche se in realtà si tratta di una cosa innocente. Quando ci si ricorda degli sventurati che non abbiamo soccorso, si è certi di non averli soccorsi.
Si deve dunque ammettere per principio che se c’è Giudizio saremo indubbiamente riconosciuti condannabili. E tuttavia non si deve attribuire a questo alcuna importanza, si deve essere indifferenti, e avere come unico desiderio la perfetta obbedienza a Dio nell’intero arco di tempo che separa l’istante presente da quello della morte, Il resto non ci riguarda. L’istante della morte, intersezione del tempo e dell’eternità, punto d’incontro dei bracci della croce. Istante che sta agli altri istanti del tempo come il Cristo agli uomini. Bisogna avere lo sguardo del pensiero fisso su quell’istante, e non sulla vita mortale, neppure sull’eternità, perché la nostra ignoranza attorno all’eternità fa sì che pensando ad essa l’immaginazione proceda senza nessun freno.
Simone Weil, Quaderni vol. IV, ed. Adelphi
RINUNCIARE A DIO PER DIO
La cosa più elevata e ultima, alla quale l’uomo possa rinunciare, è di rinunciare a Dio per Dio; ora san Paolo rinunciava a Dio per Dio: rinunciava a tutto ciò che poteva prendere da Dio, rinunciava a tutto ciò che Dio poteva dargli e a tutto ciò che poteva ricevere da Dio. Quando vi rinunciò, rinunciò a Dio per Dio, e Dio gli rimase così com’è presente a se stesso, non come oggetto ricevuto o conquistato: cioè nell’essere puro che Dio è in se stesso. Egli non diede mai nulla a Dio, né ricevette nulla da Dio: è un uno e una unione pura. Qui l’uomo è un vero uomo e nessun dolore può cadere su quest’uomo, come non può cadere sull’essere di Dio; come ho detto spesso, c’è qualcosa nell’anima così affine a Dio, che è un uno e non unito.
È uno e non ha nulla in comune con nulla e non ha più nulla in comune con tutto il creato. Tutto ciò che è creato è nulla. Ora, ciò è lontano da ogni cosa creata ed estraneo ad essa. Se l’uomo fosse tutto così, sarebbe totalmente increato e increabile; se tutto ciò che è corporeo e manchevole fosse conosciuto nell’Unità, non sarebbe nient’altro che l’unità stessa. Se mi trovassi per un solo istante in questo essere, mi stimerei tanto poco quanto un vermiciattolo di letamaio.
M. Eckart, Trattati e prediche , ed. Rusconi
SOLITUDINE NELLA MORTE
Quanto a sofferenza non si sbagliavano mai,
I Vecchi Maestri: come capivano bene
La sua posizione umana; come accada
Mentre qualcun altro mangia o apre una finestra
O cammina ignaro per la sua strada;
Come, quando i vecchi
Attendono reverenti, ansiosi,
La nascita miracolosa, ci debbano sempre essere
Bambini, che non vedevano in essa
Niente di straordinario, a pattinare
Sul laghetto presso il limitare del bosco:
Non dimenticavano mai
Che perfino il tremendo martirio
Deve compiere il suo corso
Come che sia in un angolo,
In qualche sordido luogo,
Dove i cani trascinano la loro vita da cani,
E il cavallo del torturatore
Si gratta l’innocente deretano contro un albero.
NelI’Icaro di Brueghel per esempio:
Come ogni cosa volge le spalle
Con assoluta indifferenza
Al disastro; forse l’aratore
Ha udito il tonfo, il grido solitario.
Ma per lui non fu una catastrofe importante;
Il sole splendeva,
Come su ogni cosa, sulle gambe bianche
Che sparivano nell’acqua
Verde; e la nave costosa e sottile,
Che doveva pure aver visto
Qualche cosa di prodigioso,
Un giovanetto cadere dal cielo,
Aveva un porto da raggiungere,
E continuò calma la sua rotta.
W. H. Auden, Poesie, Guanda
DOLORE E CONSOLAZIONE
… non si deve mai cercare una consolazione al dolore. Perché la felicità è al di là dell’àmbito del dolore e della consolazione, al di fuori. Essa è percepita con un altro senso, come la percezione degli oggetti sulla punta di un bastone o di uno strumento è diversa dal tatto propriamente detto. Quest’altro senso si forma per uno spostamento dell’attenzione per mezzo di un apprendistato a cui prendono parte l’anima nella sua interezza e il corpo.
Per questo nel Vangelo è scritto: «Io vi dico che essi hanno ricevuto la loro ricompensa». Non c’è bisogno di compensazione. È il vuoto nella sensibilità a portarmi al di là della sensibilità.
La religione in quanto fonte di consolazione è un ostacolo alla vera fede, e in questo senso l’ateismo è una purificazione. Io debbo essere atea con la parte di me che non è fatta per Dio. Tra gli uomini la cui parte soprannaturale non si è destata, hanno ragione gli atei e torto i credenti.
S.Weil, Quaderni, vol. II, ed. Adelphi
«“Ma, Signore, bisogna che io viva”. “Non ne vedo la necessità”».
Bisogna accettare completamente la morte come annientamento.
La credenza nell’immortalità dell’anima è nociva perché non è in nostro potere rappresentarci l’anima come veramente incorporea. Così questa credenza è di fatto credenza nel prolungamento della vita, e nega l’uso della morte.
Simone Weil, Quaderni, vol. III, ed. Adelphi
