Ricordando Emilio Coslovi (1)
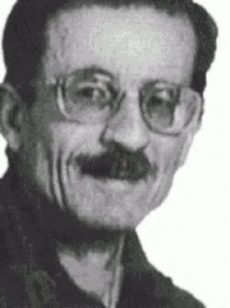
Emilio vivo
Emilio Coslovi, nato a Momiano (Istria) nel 1938 e ordinato sacerdote nella chiesa del Monte Grisa nel 1967 dal vescovo Santin, è deceduto all’alba del 13 gennaio 2002 in via Vasari 7 a Trieste nell’incendio dell’appartamento, dove viveva solo e nello stile di vita da barbone.
È passato dall’esperienza di cappellano a quella di prete al lavoro (già dal 1972 e per periodi, compatibilmente con la sua malattia, fino al pensionamento (1998) nell’azienda Colombin, una fabbrica di tappi di sughero).
Traumatizzato dall’incendio, nel giugno 1998 a Prosecco, della baracca della madre, che ha temuto fosse rimasta ustionata, considerava l’evento voluto e intimidatorio, perché si lasciasse libero il terreno, dove doveva passare una strada.
Ha sofferto e frequentato il tribunale, sentendosi perseguitato e costretto a guardarsi da provocazioni e minacce. Ha vissuto anticipatamente la sua tragedia dell’incendio e della morte, avvertendo di condivere la sorte di tante persone come lui, divenute perciò oggetto della sua particolarissima solidarietà.
Uno scambio tra PO
Sintesi dell’incontro del 9 febbraio 2002
Ricordare e far memoria non ha l’obiettivo di mettere una pietra sopra al ricordo, costruendo un altro monumento o una tomba, per poter considerare l’amicizia e la comunità di vita una cosa chiusa, e la morte un incidente di percorso da dimenticare in fretta. Abbiamo bisogno di ripensare, porci degli interrogativi, perché la vita e l’esperienza di Emilio continui ad interrogarci davvero. Poco ci sembra di aver capito allora, e tutti abbiamo bisogno di ripensare, di cogliere più a fondo la vita, che è presente nella sua, per continuare a vivere, per imparare sempre di nuovo rileggendo la vita. Lo abbiamo considerato malato e forse non ci siamo resi ben conto (anche se la cosa non è legata direttamente all’esperienza dei PO) che la schizofrenia ha fatto e fa parte della nostra vita. Siamo stati chiamati a confrontarci con la contraddizione di chi “era diverso” per la Chiesa, ma lo è stato anche per noi. Forse la nostra attenzione era rivolta altrove, forse all’ideale e alla sua affermazione e efficienza, alla grande impresa, ma ora dobbiamo farci carico di una mancata solidarietà e ascolto. Ogni persona, soprattutto chi è in difficoltà, domanda amicizia e rispetto per quello che è, non per come la pensiamo e la vorremmo. Siamo stati sensibili e la vita dipendente ci ha aiutato a considerare prima le persone della istituzione e della organizzazione e sappiamo bene che ognuno ha bisogno di una rete e di un insieme per crescere. Ma forse doveva essere più viva e corposa la vicinanza a lui, che la richiedeva con la sua ansia di partecipare e di sentirsi protagonista, per essere aiutato ad uscire dalle sue angosce esistenziali. Il funerale ci ha detto qualcosa di questa sua solitudine e non è stato, come dovrebbe, un incontro di vita, una occasione per interrogare le nostre vite, oltre il semplice ricordo. Lo abbiamo detto al Vescovo, ma dobbiamo dircelo anche tra noi, che siamo un po’ tutti inadempienti, da dover domandare scusa a lui e alla sua voglia di dire una sua “parola”. Era uno strano “beato” evangelico, inquietante e diverso, quindi da continuare ad ascoltare.
Ci siamo forse accorti tardi, che era un reale “uomo della strada”, un vero “barbone”, povero, non per aver scelto i poveri, ma perché lo era di fatto. Non ci sono stati spazi di scelta. Era il tipico “mato”, che fa parte del nostro contesto veneto e che ha in sé una povertà, ma insieme una ricchezza, che tormenta, che interroga, che evoca altri contesti, che lascia impotente la sua Chiesa, ma anche noi. È stato povero reale, a volte cristiano “blasfemo”, e amico irriverente, difficile da sopportare, abbandonato anche da coloro che gli volevano bene, per la sua incorreg-gibilità e la sua ossessione, per la mancanza di “mezze misure” e per la infelicità cercata, per il poco rispetto dell’impegno altrui. Ma egli ci costringe a domandarci se anche noi siamo diventati un gruppo politico, con obiettivi da raggiungere, con efficienze da garantire, perché ci dobbiamo dire che ci ha dato fastidio, come dà fastidio la pazzia, che costringe a evidenziare le contraddizioni, le incoerenze, le infedeltà e domanda l’autocritica severa. Non è certo facile convivere con chi “rompe…”, ma non può essere lasciato perdere il valore del richiamo a non adattarsi recuperando tutto e il contrario di tutto. Non vogliamo “adoperare” Emilio per noi, né far emergere la ricerca di una conferma alle nostre scelte (“balsamo per le nostre ferite”) e pensare a lui come a una “caduta vantaggiosa”, di conferma, perché è ancora lui, che continua a richiamarci le contraddizioni e i paradossi che sono parte della nostra vita. Il pensare a lui ci resta scomodo, pensare alle sue sofferenze, alle sue angosce reali e presunte, alla sua solitudine da bastonato e magari “masochista”, come è tipico dei “poveri” come lui, proponeva una amicizia e una forte provocazione, che non abbiamo colto e che arrischiamo di sottovalutare anche ora.
Dovrebbe restarci il “senso dei poveri come lui”, schizofrenici, poveri reali (come la madre di D. M. Turoldo, che, essendosi presentato a casa con la macchina, lo rimproverava di aver tradito la sua “miseria” originaria e di aver saltato il fosso…!), dissociati, ma fedelissimi all’amicizia, che ricercano e coltivano). Non si sa spesso quale sia il modo migliore per l’accoglienza, ma solo la comunitarietà è per loro una risposta. Lui non sapeva condividere la vita, ma ricercava sempre di nuovo il modo di “stare insieme”. Lo ha certamente aiutato la convivenza a Verona nel periodo della cura, anche se non è stato possibile liberarlo fino in fondo da ossessioni e rifiuti (autorità, vescovo, beneficenze, compatimenti … ), da manie di persecuzione e rifiuto di ogni imposizione; lo ha molto sollevato lo scherzare su se stesso, l’auto-ironia, il ridere delle sue angosce, che lo faceva concludere “te dise ben ti” . Questa relazione giocosa e liberante sdrammatizzava spesso le situazioni, ma ha fatto scoprire che occorre dare tempo, disponibilità, dedizione, camminare insieme. Il nostro stile di voler restare “gente di confine”, indica una strada, che si fa gioco di libertà, liberazione profonda, deconcentrante, se rimette al centro la persona. È certamente impegnativo leggere e stare accanto alla pazzia, è difficile anche solo capirla e aiutare la sua ricerca di equilibrio e di senso, ma porta in sé un richiamo alla “essenzialità, alla semplicità del vivere “povero”, all’uso della “compassione” che previene e accompagna, che “guarisce”. Dovrebbe costituire un segno per noi e per la nostra Chiesa. Nella esasperazione dei problemi e delle situazioni, si riscopre il dubbio e il domandarsi dove è davvero la normalità!
C’è del maniacale negli atteggiamenti, tipici di chi legge, è informato, ha tutto chiaro e distinto, ma non realizza, non interviene efficacemente, non incontra la profondità e complessità del vivere. C’è anche il rischio di confondere l’essere maniaco e la profezia. La mania fa parte delle nostre zone profonde non dette, forse esasperati dalla radicalità dei fatti della vita, dalle sconfitte, dagli insuccessi nei propri progetti, dalla solitudine. È nella prospettiva dei preti oggi, che scoprono l’inutilità, l’estraneità, soprattutto se non hanno fatto un cammino di riscoperta dell’essere minoranza e meno padroni della fede altrui.
Certe forme di “evangelismo” intransigente crea forme maniacali. È utile inoltre chiarire i rapporti tra pazzia e profezia, perché certi richiami al Vangelo fanno sì che si perdano anche gli amici, che, partiti insieme per alcune iniziative di cooperazione, nel momento in cui si affaccia l’occasione di far soldi a palate, ti dichiarano pazzo se richiami i valori di partenza e la necessità di non lasciarsi portare dalle comuni convinzioni, di dover approfittare e cavalcare il mercato e le richieste del consumo impazzito.
Anche a noi PO è oggi più che mai richiesto di essere un poco “mati” e profeti, con quella attitudine che sta al fondo dell’equilibrio, anche alla nostra età, che riconosce che l’opera non è “nostra”, ma dello Spirito, che “siamo solo servi”, non padroni.
Emilio nella sua pazzia ha fatto cose buone, aveva un suo equilibrio spirituale, e a quel livello parla anche a chi non sa parlare e si fa capire nel silenzio. La sua morte parla di solitudine e di radicalità, del suo bisogno di coerenza e praticità del fare, che non sublima la realtà e la vita, ma la vive, pagandone il prezzo. Il suo funerale è sembrato una sublimazione, un rifiuto della dicotomia, delle incoerenze e delle contraddizioni, che caratterizzano la vita reale. Il prezzo è stata l’esclusione dal coinvolgimento degli amici e dei poveri del suo quartiere e della sua parrocchia. Andava forse rispettata la sua maniera di sentire le cose senza voler sintetizzare, armonizzare, in un equilibrio squilibrato e mai raggiunto, che lo portava, da “pazzo lucido”, a finalizzare tutto e conservare tutto, non per sé, ma per informare, aiutare, avvertire con volantini gli altri, gli sprovveduti come lui. Il suo confessionale e il suo appartamento erano i punti di riferimento per queste operazioni, che lo hanno anche imprigionato e distrutto. È arrivato al confine, dove ci siamo proposti da tempo di stare e che può portarci a quella sanità mentale e psicologica che confina con la pazzia. Qui gioca la solitudine, gioca il nostro celibato, che non è automaticamente problema risolto, quando non se ne discute o se ne ignora la forza e i limiti.
Di fronte e nonostante il suo rifiuto di farci entrare nella sua casa, abbiamo scoperto la forza del contatto e del rapporto personale, che lo aiutava a rientrare nella realtà, a farlo riflettere e uscire dalle sue esasperazioni e fissazioni, dalla sua radicale solitudine. Ti obbligava tuttavia a fermarti di fronte alla forza della sua interiorità, all’arcano che lo possedeva, al sogno che lo tormentava, nella esperienza di quella malattia, che fa intravedere realtà altre e profonde. Ci sono equilibri difficili e normalità non definibili: il limite dell’istituzione è che non può capire questi livelli e tende a mortificare le richieste. Diventa urgente per i preti l’equilibrio instabile che viene dal mantenersi, dal misurarsi con l’impegno politico, dall’avere ruoli e funzioni limitate e “da mansionario” preciso, senza essere costretti a rispondere a tutto e a qualcosa d’altro. C’è per i preti una sana igiene mentale da conservare, che eviti il rischio della schizofrenia, della onnipotenza, dell’evasione a livelli di disumanità verso se stessi e gli altri. C’è da ritrovare una dimensione di normalità da rifare, che dia possibilità a “poveri” come Emilio, di avere spazi di accoglienza, di ascolto e di comunicazione, di cittadinanza comune, che possano essere spazi di comunione e di accompagnamento, fino alle sponde della morte, dove finalmente saremo in perfetta solitudine, ma davanti a Colui che abbiamo cercato.
