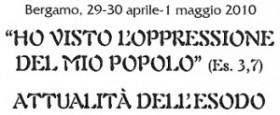
Seconda relazione
Molti osservatori della politica italiana, anche stranieri, lanciano a cadenza sempre più ravvicinata un allarme per il degrado istituzionale che investirebbe il nostro Paese e lo stato di profonda sofferenza che attraverserebbe il nostro sistema democratico.
Vorremmo anzi tutto elencare sinteticamente alcuni degli elementi più significativi che ci sembrano giustificare lo sguardo allarmato sulla situazione italiana ed il giudizio di degrado sulle nostre istituzioni democratiche.
Dalla separazione dei poteri all’adulazione per il potere
È propria del pensiero liberale, più ancora che di quello socialista o di quello cattolico, l’idea che del potere si debba diffidare perché esso tende naturalmente ad abusare. Per questa impostazione, il liberalismo è all’origine del costituzionalismo, inteso proprio come tecnica di limitazione del potere. Questo principio basilare, che pareva consolidato da più di due secoli di storia e di elaborazioni filosofiche e giuridiche, appare oggi e soprattutto in Italia fortemente appannato. Nella cultura popolare italiana la diffidenza sembra lasciare spazio ad un atteggiamento di adulazione diffusa verso il potere, considerato in tutte le sue forme, per i privilegi e la visibilità che garantisce a chi lo detenga. Il fatto stesso del successo è oggi scambiato per una prova inconfutabile del valore di chi lo raggiunge. Tale apprezzamento per il potere deriva forse dalla diversità marcata della condizione del potente rispetto a quella comune e dai troppi vantaggi e privilegi che, ben tollerati ed anzi invidiati, conseguono dal potere. Sul piano culturale ed istituzionale, il corollario di questa situazione è l’abbandono progressivo della tenuta del principio della separazione dei poteri e, a ruota, la distorsione che subisce il principio costituzionale di sovranità popolare.
Nella nostra Costituzione, la sovranità popolare è affermata in consapevole opposizione a qualsiasi tentazione identitaria, e cioè a qualunque pretesa di “esaurire” (identificare, appunto) il popolo in questo o in quel suo rappresentante o anche “potere”. È stata propria del regime fascista ed è, più in generale, una caratteristica di ogni sistema a vocazione totalitaria l’aspirazione a identificare, in modo organico e completo, il popolo in una sua parte, che diventa per questo “parte totale”, quando non addirittura in un “capo”, che si ritenga investito di un compito solitario di guida e che pertanto sia insofferente ai contrappesi ed ai limiti. In questa visione totalizzante, il dissenso diventa nemico del popolo ed un ostacolo da eliminare; il pluralismo è avversato come fosse una condizione di fragilità della Nazione e quindi come una malattia da cui guarire. L’idea che la Costituzione ha scolpito, fissando il principio della sovranità popolare, è esattamente l’opposto del totalitarismo: la sovranità appartiene al popolo perché nessun individuo e nessun potere possano appropriarsene, perché nessuna parte possa aspirare a racchiuderne l’identità ed esaurirne il volere. Allo stesso modo, il divieto di ricostituzione del partito fascista allontana dalla dialettica democratica il partito che non si percepisca come relativo, ma assuma un’ambizione assolutistica.
La sovranità popolare significa che il popolo si esprime nella pluralità dei poteri che la Costituzione organizza e pone in equilibrio, ma anche direttamente nell’esercizio delle libertà, individuali e collettive (anche l’opposizione è un organo del popolo). Pare quanto mai urgente riaffermare l’idea che il popolo non è un’entità astratta, della cui volontà, semplificata fino alla reductio ad una, qualcuno si possa appropriare: esso è strutturalmente plurale. La Costituzione fissa questo concetto, articolando il popolo in un pluralismo di formazioni sociali (art. 2), di appartenenze istituzionali e territoriali (art. 5), di componenti linguistiche (art. 6), di confessioni religiose (artt. 7 e 8). Anche la dimensione statale non è il culmine dell’esperienza della persona, che si apre a un sistema di relazioni sovranazionali (art. 11). La pretesa di riferirsi al popolo come a una massa indistinta e singolare, o, peggio ancora, di esprimere sic et simpliciter il consenso del popolo è allora una semplificazione non innocua. L’unità del popolo è un obiettivo strutturalmente problematico, irraggiungibile se non nella forma di una armonia polifonica che va ricercata nel dialogo e nella coesistenza tra diverse identità, individuali e collettive. Il primo compito dell’azione politica in una democrazia costituzionale è proprio quello di garantire il pluralismo delle forme di vita e la coesistenza pacifica delle storie personali e delle culture. Il principio di sussidiarietà in fondo rafforza questa conclusione, affermando che la stessa libera iniziativa dei cittadini è chiamata a prendersi cura dell’interesse generale e dunque ad assumere un rilievo politico. La cura del bene comune deve diventare una responsabilità diffusa nel corpo sociale, non una professione o una funzione delegata all’autorità e in essa concentrata. Si giunge, per questa via, a riaffermare il nesso fondamentale, ma offuscato, che lega la sovranità popolare al principio della separazione dei poteri.
Oggi è invece evidente e ricorrente la pretesa identificazione del “capo” del Governo con il popolo sovrano. Tale pretesa si fonderebbe sulla legittimazione che il popolo, attraverso le elezioni, conferirebbe al “capo” del Governo. Si tratta di una legittimazione così forte da prevalere sulla legalità medesima. L’eletto si ritiene infatti non giudicabile, se non dal popolo, alla scadenza del mandato. L’elezione del “Capo” del Governo – che oltre tutto, in Italia, almeno formalmente, non è diretta – porrebbe il principe legibus solutus, sopra la legge, esattamente come si affermava per l’assolutismo seicentesco. Dal Settecento, con le rivoluzioni americana e francese, appartiene al patrimonio incontestato dello Stato di diritto l’idea che il detentore del potere sia esso stesso sottoposto alla legge e, di conseguenza, giudicabile da un altro potere indipendente, quello appunto dei giudici, i quali sono a loro volta soggetti alla legge, ma solo alla legge.
È sconfortante che un quadro così consolidato e, per certi versi, scontato di principi sia così rapidamente evaporato nella coscienza civica e nella condotta di alcuni uomini di potere. La stessa disinvoltura un po’ grossolana, con cui vengono “interpretate” alcune alte cariche istituzionali, tradisce una visione patrimonialistica delle istituzioni medesime. La separazione dei poteri è screditata come “laccio e lacciolo” dell’azione del Governo, che si vorrebbe libera da impacci, con l’unico vincolo di un raccordo diretto, impossibile ed ingannevole (o affidato a sondaggi di cui non è dato di verificare e discutere la struttura e l’attendibilità) con l’opinione pubblica. Non è un caso che l’autorità di Governo sia entrata in conflitto con tutti i poteri che la Costituzione pone all’esterno o a temperamento del circuito della maggioranza politica (Magistratura, Corte costituzionale, Presidente della Repubblica, autorità amministrative indipendenti). La lamentata lentezza delle procedure parlamentari ha fatto perfino invocare la necessità di semplificare (ridurre) drasticamente la rappresentanza. C’è davvero da chiedersi come possa un disegno tale di concentrazione autoritaria dei poteri comporsi con un riassetto istituzionale di tipo federale che la stessa maggioranza politica vorrebbe imprimere all’ordinamento.
La nevrosi individuale (e tuttavia collettiva) per il potere intacca un altro fondamento del costituzionalismo: il principio di uguaglianza. Questo principio non può resistere di fronte al diffuso bisogno spasmodico di apparire e di emergere che si sfoga talora nel gesto estetico o anche folle o criminale. Ogni cosa è potenzialmente buona per distinguersi e conquistare, come si riesce, un posticino nel palcoscenico della vita e non venirne via senza essere stati, almeno una volta, inquadrati dalle telecamere. L’uguaglianza si colora così della tinta grigia del gregge indistinto. E tuttavia, un tale passaggio culturale non può lasciare tranquilli, in quanto mette radicalmente in discussione l’idea stessa di democrazia, perché è sull’intuizione dell’eguaglianza che quella si fonda. Solo chi crede nell’eguaglianza può, ad esempio, accettare che i voti si contino e non si pesino.
La sproporzione del peso della televisione nella trasmissione culturale e la carenza di pluralismo nel settore televisivo
Il problema è, come si vede, duplice. Anzi tutto è un problema in sé, secondo noi, il peso sproporzionato che la televisione riveste nei processi di trasmissione culturale e di formazione dell’opinione pubblica nel nostro Paese. Secondo problema, distinto ma collegato: l’egemonia politica sulla televisione e la carenza di pluralismo informativo.
Il predominio della televisione tra i mezzi di diffusione del pensiero costituisce, isolatamente considerato, un indice di debolezza per un Paese . Ne siamo convinti anzi tutto per il riconosciuto potenziale di suggestione e di manipolazione che il linguaggio ed il ritmo delle immagini contiene. La debolezza della stampa e di altre forme di trasmissione culturali è l’altra faccia della stessa medaglia. La televisione non è, in democrazia, innocua, perché consiste in una trasmissione a senso unico (non si dialoga col televisore…): essa scova il cittadino nel suo privato di telespettatore, lo investe di immagini mentre è da solo, in una situazione di particolare vulnerabilità e condizionabilità. La televisione inibisce il dialogo, trasforma i cittadini in spettatori passivi e, alla lunga, rischia di estraniare dalla realtà. La televisione suggerisce modelli culturali senza elaborarli; per questo è ancora più insidiosa. Inoltre, il predominio del mezzo televisivo allontana la politica dal territorio e proietta, su ogni livello istituzionale, dal Comune alla Regione, l’immagine invadente dei leader nazionali più esposti mediaticamente. L’attivazione di un reale circuito di responsabilità tra azione amministrativa locale e cittadini è inevitabilmente, in queste condizioni, resa problematica dall’inquinamento della politica a dimensione mediatica. L’esponente politico locale, ancorché in ipotesi assai modesto, gode di un vantaggio competitivo notevole se associa o addirittura nasconde la sua immagine dietro a quella del leader nazionale, che è capace di trainare a tutti i livelli il consenso dei cittadini che, in quanto telespettatori, sono sradicati e sprovvisti di criteri autonomi di giudizio.
A questi limiti strutturali del mezzo televisivo si deve ora aggiungere la situazione, tutta italiana, della stretta connessione tra televisione e potere politico e della concentrazione della proprietà nel mercato televisivo. L’assenza di indipendenza delle testate giornalistiche impedisce o scredita uno stile di ricerca ed investigazione della realtà che sia al servizio dell’opinione pubblica, a tutto vantaggio di una manipolazione della verità dei fatti a uso e consumo della proprietà. L’attacco sferrato alla stampa desta un’attenzione allarmata anche all’estero, soprattutto in ambienti liberali. Peraltro, il modo in cui, nei telegiornali nazionali, viene presentato il dibattito prettamente sulle questioni politiche ci appare davvero meschino: spesso esso è ridotto alla stucchevole successione di brevissime dichiarazioni – evidentemente preparate e recitate con piglio ed espressione da attori – da questi nuovi personaggi della politica: i telegenici portavoce dei partiti o dei loro leader. Lo stesso pluralismo delle reti commerciali appare, rispetto agli anni scorsi, fortemente ridimensionato a causa di alcuni avvicendamenti nella direzione dell’informazione politica nelle televisioni private. E comunque il consenso, ci pare, un certo stile di fare politica lo possa costruire e raggiungere soprattutto grazie alle trasmissioni non di argomento politico (“Uomini e donne”, il “Grande Fratello”, tanto per fare degli esempi…), che propongono modelli culturali (ricerca della visibilità, primato dell’apparire e dell’esibirsi) tutt’altro che neutri rispetto alle grandi scelte politiche. La cultura politica ha bisogno anzi tutto della cultura tout court e di una società abituata a porsi criticamente di fronte alla realtà e non anestetizzata da gossip o discussioni del tutto vuote.
L’assenza di un confronto politico interno ed esterno al sistema partitico
Un terzo grande limite della democrazia italiana appare una stretta conseguenza dei primi due elementi di crisi. Le grandi questioni politiche, quali per esempio il futuro dell’Europa, l’ambiente (mai in Italia è partito un dibattito serio pubblico sui cambiamenti climatici…), la crisi economica sono pressoché completamente ignorate o addirittura esorcizzate dal dibattito politico o, forse, da ciò che del dibattito politico traspare attraverso i mezzi di comunicazione. Le poche volte in cui accade che questioni serie arrivino al centro del dibattito politico-culturale, lo stile con cui il confronto si consuma è quello della contrapposizione da stadio, sloganistica e superficiale, perché in fondo serve alla politica soffiare sul fuoco delle divisioni del Paese per racimolare un po’ di consenso. La gestione politico-mediatica del pietoso caso Englaro è stata emblematica, con la rappresentazione della vicenda, assai delicata e complessa, come uno scontro tra il partito della vita e quello della morte. E intanto il Governo mostrava di voler sfruttare la contrapposizione per ingraziarsi l’elettorato cattolico e “picconare” gli equilibri costituzionali con un inedito e violento attacco al Presidente della Repubblica. A distanza di qualche mese, che fine ha fatto quel dibattito, che pure sembrava la sfida finale tra il bene ed il male? Esso è assopito, pronto però ad essere risvegliato alla bisogna. Altri esempi sono possibili: si guardi com’è affrontata la questione sicurezza, con l’evidente manipolazione delle notizie di cronaca. Non pochi (si pensi al sociologo Bauman) hanno colto nel modo di affrontare i temi della sicurezza una strategia di controllo politico, consistente nell’alimentare l’insicurezza poiché essa induce l’uomo televisivo, impaurito e solo, ad abbracciare il potere, a sbarazzarsi frettolosamente del lusso della libertà e della partecipazione in cambio della sicurezza della sua pelle e dei suoi poveri beni.
Insomma, a noi pare che la politica non solo non favorisca un profondo scambio sui grandi temi della convivenza, ma addirittura non rinunci a soffiare irresponsabilmente sul fuoco delle paure e delle divisioni sociali. I fronti della divisione sociali, alimentati ad arte dall’azione politica, sono diversi e talvolta si intrecciano pericolosamente: Nord contro Sud, cittadini contro stranieri, lavoratori del pubblico impiego contro lavoratori autonomi e/o privati, cattolici contro non cattolici, ecc… Si avverte in questa situazione tutto il peso della mancanza di un dibattito politico e culturale che sia indipendente dal sistema partitico. Il pluralismo politico non può essere solo pluralismo partitico, anche se pure di questa versione, davvero minimale, si avverte ormai la carenza. Occorre che la politica sia animata, seguita e controllata da un vivo dibattito nel Paese, grazie all’aiuto di molte agenzie educative ed informative (la stampa, le Chiese, le associazioni, ecc…). Ben più dei partiti, sono infatti le altre formazioni sociali le risorse della coesione di una comunità, gli elementi di ricomposizione di un tessuto sociale lacerato. Gli stessi partiti appaiono, dal punto di vista culturale, strumenti fortemente indeboliti perché la legge elettorale, privando l’elettore dello strumento della preferenza tra i candidati, assegna alle segreterie di partito la possibilità concreta di cooptare (di scegliere) il personale da collocare nelle istituzioni elettive. E la scelta delle segreterie finisce con il premiare il servilismo politico degli yesmen (e yeswomen), anziché personalità che potrebbero risultare ingombranti o difficilmente gestibili. Di fronte a queste chiusure, gli intellettuali, che già normalmente sono spesso tentati dalla fuga dalle concrete responsabilità pubbliche, trovano buoni argomenti per rifuggire un diretto impegno politico. E comunque è indubbia l’importanza che potrebbe rivestire la stessa azione culturale, per quanto esterna rispetto all’ambito partitico, se solo trovasse canali adeguati di espressione.
Colpisce del dibattito italiano la fragilità delle culture politiche. È chiaro che la crisi delle grandi culture (non solo delle ideologie) politiche è, a sua volta, figlia del tramonto delle identità collettive e, conseguentemente, di uno stile progettuale di fare politica, come racconto ed interpretazione della realtà ed elaborazione di una speranza collettiva di trasformazione sociale. Dopo la celebrata morte di Dio, siamo forse, come qualcuno ha scritto, alla morte del prossimo e la scena sociale e politica resta occupata da un individuo che, anziché più libero, si scopre più insicuro e manipolabile. Negli Stati Uniti, Obama ha saputo, in un tempo di profonda depressione, riaccendere amore per la politica perché ha coinvolto il Paese in una sfida, lo ha appassionato ad un progetto di cambiamento democratico.
La crisi della cultura politica si manifesta anche come miseria ed irresponsabilità della parola. Il linguaggio politico si è reso spregiudicato, giuridicamente coperto dall’insindacabilità parlamentare. La parola viene detta e poi subito negata. La responsabilità politica manca, perché nessuno fa valere la parola. Le parole dell’opposizione appaiono, agli occhi del pubblico, come pregiudicate in partenza e, di nuovo, mancando agenzie indipendenti, l’accertamento della verità del detto o del fatto diventa impossibile. La parola che si libera dalla responsabilità diviene insindacabile, offensiva, arbitraria, generica, e, quel che è peggio, degrada la politica in modo profondo.
Quanto dipende da Berlusconi?
Più volte, presentando la situazione che si è descritta, si è alluso o si è espressamente chiamata in causa la responsabilità personale del Presidente del Consiglio Berlusconi. Occorre però domandarsi come sia possibile che una tale situazione sia frutto di un solo uomo, per quanto potente possa essere.
A noi pare che Berlusconi, più che la causa, sia il miglior prodotto della trasformazione culturale ed antropologica a cui stiamo assistendo. Egli è insieme l’uomo di potere e di televisione. I due termini si legano strettamente, come mostra significativamente il recente film Videocracy, in cui Berlusconi è associato ad un manager televisivo di successo come Lele Mora o al re dei paparazzi, Fabrizio Corona.
L’agire politico di Berlusconi incarna il tipo puro dell’uomo di potere, cui – come si è detto – si rivolge l’adulazione collettiva. È davvero difficile trovare nella linea politica, sua e del partito che regge, un qualche punto di riferimento stabile. Il modo stesso in cui è stata, con consumata tecnica pubblicitaria, fondata Forza Italia e poi improvvisamente sciolta nel Popolo delle Libertà testimonia della sovrapposizione tra partito e volontà di una persona. Si fa fatica ad incasellare il centro-destra italiano entro le tradizioni della politica: non è una destra liberista o del rigore economico (memorabile è rimasta una conferenza stampa del luglio 2008 in cui Berlusconi sosteneva di portare avanti una politica di sinistra!); nemmeno è una destra nazionalista (come potrebbe con la Lega?) o conservatrice. Eppure, all’occorrenza, è tutte queste cose… Sul piano politico, Berlusconi, a parte l’ossessione per le persecuzioni giudiziarie e la difesa dei propri interessi economici, agisce in modo plastico e spregiudicato, aderendo in maniera camaleontica ai differenti contesti, sempre in direzione della conservazione del potere. Il sondaggio gli è in questo una guida fondamentale. Ciò che lo caratterizza non è un programma d’azione, ma uno stile, populistico e demagogico, che si alimenta del mito vitalistico e giovanilistico di un leader superman perfino fisicamente. L’uomo di potere è un alleato ideale, perché non ha pregiudiziali ideologiche da opporre ai suoi compagni di cordata.
Il suo successo personale, indubbio, dipende dall’abilità e spregiudicatezza comunicativa e dalla sua capacità di farsi collettore dei processi identificativi individuali, benché non di progetti collettivi. Più volte, nel pieno degli scandali sessuali o della crisi politica, lo abbiamo ascoltato difendersi, a suo modo a ragione, dicendo che gli Italiani si identificano con lui, nonostante tutto o, forse, proprio per tutto quello che gli succede e che combina. Il Premier non raccoglie consensi per le idee che esprime, ma per lo stile che impersona e per il potere che esercita. Il consenso gli deriva dall’immagine di vincente, nella vita, nello sport, nel mercato, con le donne… In Berlusconi non si cerca un progetto politico (per quanto strumentalmente qualcuno possa tentare di usarlo ai suoi fini), ma si celebra il nichilismo individualistico e la trasformazione del bene comune in desiderio individuale.
Se l’analisi è giusta, il problema è, più ancora di Berlusconi, semmai quello della cultura, ormai egemone, da cui Berlusconi stesso trae appoggio, sostegno e consenso. Questa cultura è una miscela strana di ammirazione e aspirazione rivolte al potere e alla visibilità che il successo dà; di apprezzamento per uno stile personale sicuro e disinvolto, perennemente giovane e sano, che inevitabilmente occulta, perché vergognose o sconvenienti, la morte e le fragilità. Questi valori di riferimento riflettono fedelmente e confermano la condizione culturale diffusa nella modernità, ove prevale un edonismo personale, senza progetto e apertura sociali.
Come reagiscono i cattolici?
In questa situazione allarmante, che cosa fanno i cattolici? Come si muovono? Mai come in questa fase, per parlare dei cattolici in politica occorre valutare le posizioni espresse dalla gerarchia ecclesiale. Altro “materiale” di studio sembra non disponibile, o almeno fatica a raggiungere dimensioni significative. Sono infatti spesso voci autorevoli della gerarchia ecclesiale, a ciò indubbiamente sollecitati, a dialogare, direttamente o attraverso i propri organi di stampa, con gli attori della politica, mentre è quasi assordante il silenzio a cui è ridotto il laicato. Finita infatti la stagione del collateralismo rispetto al partito di riferimento (la DC), e forse non soddisfatta del peso che i cattolici riescono ad avere all’interno dei due principali schieramenti partitici, la Chiesa è sembrata, soprattutto in un recente passato, non disdegnare la via di una presenza e di un intervento diretti, con Pastori che fanno dichiarazioni su singole questioni dell’agenda politica. Tale strategia sembra peraltro incontrare il gradimento sostanziale degli stessi leader politici: di fronte alla difficoltà del sistema politico di intercettare e rappresentare identità collettive, sempre più frammentate ed inafferrabili, il poter dialogare con un rappresentante “ufficiale” della Chiesa consente di raggiungere una delle pochissime, residue, identità visibili. Da ciò consegue che, entro il dibattito pubblico, alla posizione cattolica sia attribuita un’enfasi forse addirittura superiore alla sua stessa consistenza, ma al prezzo di presentarla come monolitica, compatta, riassunta dalla voce di pochissimi autorevoli esponenti della gerarchia ecclesiale. A questo esito coopera certamente, e in misura non trascurabile, anche la semplificazione che del dibattito ecclesiale e delle posizioni magisteriali opera la rilettura giornalistica.
Il timore è che, in questo modo, si perpetui la situazione attuale di irrilevanza ed insignificanza della classe politica cattolica, che spesso è grossolanamente identificata con un moderatismo fiacco o forse furbo, perennemente equidistante.
Vi è poi una questione fondamentale di metodo. L’intervento diretto su singole questioni comporta il rischio di non valorizzare adeguatamente la dimensione sintetica e progettuale della politica, frammentando quest’ultima in un’azione che può apparire di tipo lobbistico. Inoltre, la tentazione della trasposizione immediata in progetto politico di posizioni di fede, favorita dalla disponibilità di sponda politica, minaccia di tradursi in una “prova di forza” e nella programmatica rassegnazione a un consenso non generale, ma parziale, costruito attorno a posizioni confessionalistiche. Una strategia di questo tipo introdurrebbe tuttavia una pericolosa scissione tra il fine dell’azione politica (la ricerca della pace sociale) ed i mezzi impiegati e, conculcando chi non crede, può addirittura contribuire a rendere ostili i principi di fede. Si finirebbe inoltre con il rallentare la maturazione, tra i cittadini, cattolici e non, di un consenso più solido, conseguito per via di mediazione.
È infatti fondamentale pensare entro quale progetto complessivo ed entro quali culture scaturiscano certe decisioni, ancorché gradite, e cercare di discernere i presupposti antropologici che guidano un’azione politica. Nella dottrina sociale è infatti saldamente fondato il riconoscimento del valore dell’azione politica, come perseguimento sintetico del bene comune. La vera urgenza politica è quella dell’educazione e della formazione a una sana azione politica, a cui la stessa Chiesa può prestare la propria secolare sapienza, incoraggiando i laici ad un impegno serio in questa direzione, anziché apprezzarne un ossequio di facciata. Non pare infatti solo teorico il rischio che attori della politica “usino” le questioni cui l’elettorato cattolico è più sensibile in modo ambiguo, ad esempio come strumenti di una chiusura difensivistica contro le culture di cui gli immigrati sono portatori o contro gli immigrati tout court. La stessa Chiesa, almeno in alcune sue lucide voci, è parsa avvertita del rischio che si accrediti una rozza equiparazione tra questione nazionale e questione religiosa. Non si può accettare che quest’ultima sia prestata a un’azione politica orientata alla chiusura e alla divisione sociale.
La criticità di questa situazione conosce un versante per così dire pastorale che non desta meno preoccupazioni. Il silenzio dei laici, infatti, non è solo conseguenza di un coinvolgimento diretto della gerarchia, ma è anche il riflesso della povertà della laicità della fede. Intendiamo dire che manca, nelle comunità cristiane, un modello di fede che incorpori ed elabori uno sguardo antropologico sulle grandi questioni dell’uomo e della società. Questa mancanza dei cattolici, frutto di una fede isterilita in una religiosità esteriore o meramente declamata, aggrava la povertà del tessuto civile del Paese in cui latita quell’educazione al discernimento storico ed antropologico che è condizione per una seria mediazione politica.
Emblematica di questa situazione è la crisi in cui versa il cattolicesimo democratico, che pure è all’origine della Costituzione (e “prodotto” del Concilio Vaticano II). Esso riprende e valorizza l’affermazione, appartenente alla stessa tradizione della dottrina sociale della Chiesa, del valore della politica che, quando sia orientata al bene comune, rappresenta un’autentica forma di servizio al prossimo e finanche d’amore. La piena accettazione della funzione “buona” e della conseguente relativa autonomia della politica conduce il “cattolicesimo democratico” a declinare il principio di laicità nell’idea di mediazione. La mediazione è sia di tipo storico, sia etico.
Con mediazione etica si intende che nella ricerca, propria dell’azione politica, dell’accordo, occorre che gli uomini agiscano sforzandosi di mostrare le ragioni per tutti dei propri convincimenti, quand’anche ricavati da posizioni di fede. Poiché infatti il contesto in cui si muove l’azione politica è pluralistico, per convincere della bontà del proprio progetto, occorre saper tradurre con linguaggio e categorie comuni, di tipo etico ed antropologico, i propri principi. È proprio adottando coraggiosamente e sapientemente questa linea di mediazione antropologica che i Costituenti sono riusciti ad approvare, insieme a uomini da cui li separava – allora sì – radicalmente una ideologia, una Costituzione laica e tuttavia pienamente rispondente all’ispirazione più profonda dei Cristiani. Questa opera di mediazione etica non equivale a compromesso spartitorio: essa mira ad un progetto complessivo di bene comune, rispettando la vocazione sintetica dell’azione politica, e non procede selezionando, dal materiale della politica stessa, singole questioni, in cambio delle quali disinteressarsi del resto. La parte di valore che eccede la linea raggiunta della mediazione va incarnata dai credenti con la testimonianza personale e culturale, dando cioè anzi tutto l’esempio, portando nella propria vita il valore oltre la legge. Sbagliato sarebbe invece usare la legge per sopperire alle debolezze della testimonianza individuale o del dibattito culturale. O, peggio ancora, esigere dalla legge, obbligante tutti, credenti e non, soluzioni che nemmeno il credente, personalmente, ha la forza e la coerenza di testimoniare.
Accanto a quella etica, v’è la mediazione di tipo storico. Per il Cristiano, infatti, le premesse di fede non si presentano nella forma di “regoline” minute e pronte all’uso, ma disegnano principi generali di orientamento che, per essere praticati, devono essere incarnati nel tempo e nello spazio. I Cristiani non possono cioè presumere di poter deduttivamente e semplicisticamente ricavare una ed una sola risposta per ogni problema pratico da questo o da quell’altro passo della Scrittura. La via della mediazione resterebbe dunque necessaria anche nell’ipotesi, invero irrealistica, che si ricostituisse una società di soli credenti, perché resterebbe la necessità storica di incarnare, nel tempo e nello spazio le premesse di fede.
Il valore della democrazia ermeneutica
La via della mediazione, ricavata dal principio personalistico (che è matrice della dottrina sociale della Chiesa), non va affatto confusa con l’adesione a una prospettiva relativistica o nichilistica. È invece la prospettiva di chi ritiene che la verità non sia conoscibile dall’uomo se non nell’incontro con l’altro, se non nella relazione con il (e nell’apertura al) prossimo da sé. Su queste premesse, è lo stesso concetto di “valore” a non essere fondabile in termini assoluti, se questo significa collocarlo al di fuori di una relazione. Il temuto relativismo individualistico, paradossalmente, somiglia di più all’approccio dogmatico: entrambi separano infatti la verità dalla relazione. Il relativista, stimando la verità inesistente, rischia di impoverire la relazione, sottraendole la vocazione di ricerca; il dogmatico, immaginando la verità già data storicamente a una parte, immiserisce la relazione in una dialettica giusto/sbagliato propedeutica ad una resa ed incorporazione (dello sbagliato entro il giusto). Nell’apertura all’altro sta l’unica possibilità data alla condizione umana di approssimarsi al vero.
Quella indicata è la strada per riconoscere e valorizzare l’alto significato della democrazia. La democrazia non è – come una sua interpretazione sostiene – insensibile al vero, ma è ricerca del vero insieme. La democrazia è infatti ricerca che avviene nel confronto delle idee, tanto che le procedure in quella assumono un valore decisivo, perché è la procedura, in primis, ad offrire la garanzia di apertura al confronto ed alla relazione. La relazione non è solo la condizione di ricerca del vero ma è vero in sé, è valore in sé. Il volto dell’altro, e dunque la relazione responsabile con la sua irriducibile alterità, è infatti il valore che fonda la democrazia e le sue procedure, sempre che queste ultime non siano svilite a mera tecnica di incoronazione del potere.
Filippo Pizzolato
Filippo Pizzolato è docente di diritto pubblico all’Università degli Studi Milano-Bicocca. Il titolo completo della relazione era: “Degrado istituzionale, prevaricazione dei poteri, deriva lobbistica del volto pubblico della chiesa, silenzio dei cristiani in Italia. Aprire strade per l’Esodo”
