Sguardi e voci dalla stiva
Eternit
Intervista al frate operaio Bernardino Zanella

Casale Monferrato, 05/08/2010 — Bernardino Zanella ha 73 anni e si trova attualmente a Oruro, in Bolivia, al Santuario di Nostra Signora (http://santuariodelsocavon.com) su un altopiano a 3700 metri di quota. Condizioni naturali ostili e sociali difficili. «Qui c’è molta povertà. Nella missione c’è una mensa popolare frequentata da 300-350 persone ogni giorno, si svolgono attività sociali e assistenziali, di formazione ed educazione. C’è un servizio di appoggio alle donne vittime di violenza familiare che in Bolivia è un problema molto grave», spiega Bernardino.
A Casale – tra il 1974 e il 1977 – aveva lavorato all’Eternit. Colto, intellettualmente indipendente, aveva messo più volte in difficoltà pubblicamente i dirigenti dell’Eternit.
Nel luglio del 1976 in un rapporto del consiglio di fabbrica sottolineò che all’Eternit moriva un operaio al mese e che la causa principale era l’amianto, soprattutto quello blu, che causava asbestosi, cancro al polmone e mesotelioma. Ma l’Eternit continuò a negare “politicamente” i rischi dell’amianto fino al fallimento nel 1986.
Era il 1975 e all’Eternit la polvere era dappertutto. I camion giravano scoperti per la città seminando la polvere per vie e piazze. Il Ronzone era grigio e chi andava a lavorare all’Eternit -talvolta – aveva già visto morire il padre e magari il nonno per «la polvere», che non causava solo l’asbestosi ma anche il tumore. E quella parola – mesotelioma – era tutt’altro che sconosciuta.
Nel cortile si macinavano gli scarti con la ruspa e si accumulavano insieme al polverino e ai riccioli della tornitura. Ma le gente si portava anche a casa i sacchi in cui era stato trasportato l’amianto, dopo averli scrollati un po’ per togliere «il più grosso».
Sono alcuni elementi delle testimonianza di Bernardino Zanella il frate operaio che lavorò all’Eternit tra il 1974 e il 1977 e che abbiamo rintracciato a Oruro, in Bolivia, al Santuario di Nostra Signora dove svolge la sua missione pastorale.
Si è parlato molte volte di un suo rapporto sulle condizioni di lavoro all’Eternit che aveva fatto come presidente del Consiglio di fabbrica. Lo ricorda?
Sì, nel 1975 avevamo fatto un lavoro di analisi di ogni reparto, con assemblee dei lavoratori e chiedendo a tutti di segnalare i punti di maggiore contaminazione.
Come avevate condotto questo lavoro di analisi?
Avevamo percorso reparto per reparto con una piccola commissione sindacale e chiesto ai lavoratori quali erano i punti di maggior esposizione. La direzione sapeva benissimo quali erano le lavorazioni maggiormente a rischio e infatti pagava di più chi le svolgeva. Ma da parte dei lavoratori non c’era consapevolezza. Per cui l’indagine era anche lo strumento per creare una coscienza da parte degli operai. E in effetti era servito.
Che cosa era emerso?
Per esempio che molti lavoratori ricordavano che già i nonni erano morti di tumore. C’era una storia familiare, spesso, con l’Eternit; chi ci lavorava era andato in fabbrica dopo che c’erano già stati il padre e a volte il nonno…
Quindi era noto il fatto che i lavoratori si ammalavano di tumore… E la direzione che diceva?
Ci dicevano che il rischio era solamente legato al fumo e non alla nocività dell’asbesto. Ma è possibile che anche alcuni dirigenti fossero poco consapevoli del rischio o lo sottovalutassero.
Vittime della loro stessa propaganda, visto che per esempio il direttore del SIL Bontempelli quando aveva comprato casa aveva fatto togliere il polverino dall’ingresso del garage perché sapeva che era rischioso…
Ricordo che il direttore dello stabilimento abitava all’ingresso della fabbrica con la famiglia. Credo che se ne avesse avuto coscienza non avrebbe esposto la famiglia a un tale rischio.
Senta, quel rapporto ce l’ha ancora?
No, però penso che i sindacati ne abbiano ancora copia.
Cosa se ne fece di quella indagine?
Venne distribuita a tutti i lavoratori. A ciascuno venne data copia della parte relativa al reparto in cui era occupato.
Com’era strutturata l’indagine?
Una prima parte esaminava – appunto – reparto per reparto il tipo di lavorazione, i macchinari e le attrezzature utilizzate. Si cercava di capire quali erano i punti critici, le fonti di dispersione delle polveri per sapere dove intervenire. Avevamo raccolto anche le dichiarazioni degli operai.
E ne fu data copia anche all’azienda?
Certamente. Perché la seconda parte consisteva nelle richieste che il sindacato faceva per limitare il rischio.
Quali erano i punti più pericolosi?
Il reparto peggiore era certamente quello in cui venivano aperti i sacchi di asbesto per mettere il materiale nelle tramogge.
Come avveniva l’operazione?
I sacchi si aprivano con un coltello, poi si prendeva l’amianto con le mani e si metteva nelle tramogge. Ad aumentare il rischio c’era il fatto che quando capitava qualche sacco che i lavoratori pensavano potesse essere utile lo scuotevano alla meglio, lo ripiegavano e lo portavano a casa.
E l’azienda ne era al corrente?
Certamente. Un altro punto molto nocivo era dove si tagliavano le lastre e i tubi, sia per la polvere, sia per il rumore delle seghe.
Si tagliava a secco o a umido?
A secco. Ma tutti i reparti erano contaminati, forse un po’ meno i locali sotterranei dove si faceva la stagionatura, erano locali molto umidi…
Alla richieste che avevate avanzato c’erano state reazioni, risposte da parte dell’azienda?
Avevamo preparato una lista di richieste reparto per reparto e la direzione predispose un suo documento, un’altra lista in cui teneva conto di quanto chiedevamo, ma solo per quanto interessava loro…
E cosa cambiò in sostanza?
Ci fu una maggiore attenzione alla manutenzione. Prima quando si rompeva la manichetta di un filtro degli aspiratori restava rotta magari per giorni e giorni. Da quel momento si fece più attenzione.
Così come per i tubi dove l’amianto veniva trasportato con l’aria compressa. Nei gomiti spesso si creavano delle fratture e l’asbesto, sotto la pressione dell’aria…
Quindi si curò di più la manutenzione. E quale risultato si ebbe sull’ambiente di lavoro?
L’ambiente restò nocivo, ma da quel momento in poi è iniziata una certa coscienza da parte dei lavoratori e anche la direzione vedendo che gli operai si stavano svegliando cominciò a essere più attenta.
Certo l’azienda diede risposte molto blande rispetto al problema ma qualcosa fecero.
Ma si assumevano precauzioni? Per esempio si usavano le mascherine?
C’erano delle mascherine che erano… “psicologiche”. Ma lo sapevano tutti, anche la direzione…
Che cosa sapevano tutti?
Che non servivano e che comunque non si poteva portarle per una giornata di lavoro, facendo un lavoro faticoso con temperature magari alte e in un ambiente umido.
Ma perché non servivano?
Tutti sapevano, e questo era stato detto anche da esperti, che quel genere di mascherina non serviva a fermare le fibre di amianto che erano troppo sottili. Sarebbe stato necessario utilizzare altre maschere – tipo maschere antigas -ma non era pensabile usarle otto ore al giorno per fare un lavoro che era anche di fatica.
Per questo puntavamo sulla salubrità dell’ambiente di lavoro.
E che sensazione si aveva della fabbrica e del quartiere, visivamente?
Al Ronzone c’erano anche altre fabbriche che lavoravano il cemento-amianto oppure solo il cemento. Era tutto grigio per la polvere di cemento e di amianto che era ovunque. Ma penso che questo i casalesi lo ricordino bene…
E poi i camion carichi di amianto e di eternit uscivano dalla fabbrica e attraversavano scoperti la città per andare ai magazzini.
Una delle richieste che avevamo fatto era proprio che venissero coperti perché seminavano polvere lungo tutto il percorso e la città era contaminata permanentemente.
Mi ha parlato dei sacchi che i lavoratori portavano a casa. E gli altri scarti?
C’erano i ritagli delle lastre rotte. Venivano ammucchiati e frantumati nel cortile con un cingolato. E lì si alzava un gran polverone…
Alla Piemontese, di fronte agli stabilimenti?
Non solo, anche in un cortile interno dell’Eternit. Quel materiale mescolato con il polverino dei filtri e i riccioli della tornitura veniva prelevato da molti per pavimentare cortili e vialetti.
Ma come si faceva a ottenere questo materiale? Era a disposizione di tutti?
No, bisognava fare domanda andando negli uffici.
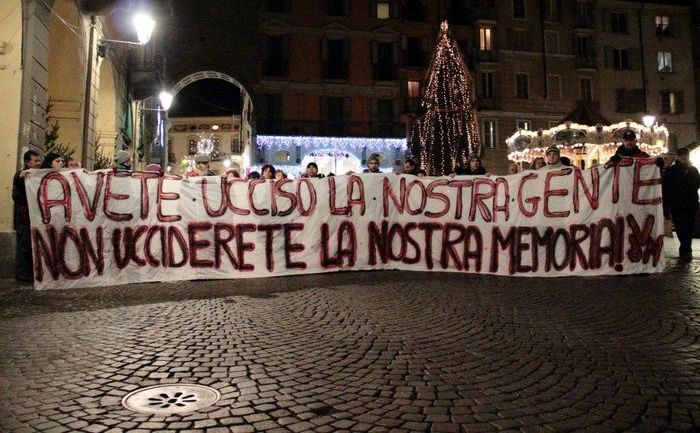
.
Senta, nel 1976 lei parlò del rischio non soltanto per quanto riguardava l’asbestosi ma anche per il tumore e in particolare per il mesotelioma. Come ne era venuto al corrente?
Quando sono entrato all’Eternit non conoscevo il rischio a cui erano esposti i lavoratori, e a cui mi esponevo anch’io. Ma subito ho cominciato ad aprire gli occhi. Mi ha aiutato in questo anche un corso che ho fatto ad Alessandria, promosso dal sindacato e tenuto dall’Università di Genova, sulla medicina del lavoro, nocività ambientale, rischi e precauzioni per la salute, ecc.
Quelle relative alle patologie causate dall’amianto comunque erano informazioni che avevo ricavato documentandomi su alcune riviste scientifiche e parlando della questione con esperti in medicina del lavoro. C’erano studi relativi ad altri Paesi, come la Russia – mi pare – e l’Africa e in cui si parlava del rischio di mesotelioma e di tumore al polmone.
Un’ultima cosa: Nicola Pondrano durante la sua deposizione ha ricordato una frase che lei disse per spiegare la sua decisione di andarsene da Casale: «Gli svizzeri non sono solo in Vaticano…».
(Ride…) Non so, non mi ricordo…
Da come reagisce, si direbbe che si riconosca in questa frase… Potrebbe effettivamente averla pronunciata?
(Ride…) Non so…
Ma perché “gli svizzeri”, chi erano i padroni dell’Eternit?
Si parlava sempre di svizzeri, anche se non si facevano nomi.
Sono anche venuti qualche volta a Casale. Ricordo distintamente almeno di una volta che proprio perché c’era la visita degli svizzeri si erano fatte le pulizie, si era rimesso tutto bene in ordine ed era anche stato “dato il bianco”.
Ogni tanto ripensa all’Eternit? Al rischio al quale si è esposto insieme a tante altre persone?
Ho pensato molte volte, anche negli anni successivi, lontano da Casale, ai miei compagni di lavoro. Non mi sono preoccupato molto della mia salute, ma ho pensato ai molti di loro che ho lasciato nel cammino, e che si andavano spegnendo a causa delle conseguenze di essere stati all’Eternit. Sono grato a loro per molte cose, compresa una grande sensibilità che ho coltivato per tutti i problemi relativi alla salute dei lavoratori, e ora più in generale relativi all’ecologia e allo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali, come già si è fatto per l’uomo. Anche in America Latina ho portato questa sensibilità e questo impegno.
Massimiliano Francia
